La pelle dell’orso non è un film… é qualcos’altro.

Genova, pioggia a tratti e luci cittadine che si riflettono nei piccoli laghetti fra le pietre dei caruggi. Gli specchi d’acqua non dipingono i monti, invisibili tra gli alti e stretti palazzi medievali, né il mare, vicino ma nascosto tra piazzette e mura di mille anni fa.
Cerco una piccola saletta nascosta nel dedalo dei vicoli e la trovo, come un gioiello scomparso in un antico scrigno; andare a vedere questo film è un po’ come fare un viaggio nel tempo già a partire dal luogo in cui viene proiettato. Ci sono gli espositori di caramelle con la rotella, un telo molto piccolo e i sedili ribaltabili, sul cui bordo chiuso mi sedevo da bimbo, perché altrimenti non sarei stato abbastanza alto da vedere al di là delle teste.
Inizia l’opera… e subito vengo catapultato in un luogo mio; ci sono la natura che conosco, molti aspetti che ho vissuto da ragazzo e qualcuno dei racconti dei miei patriarchi, dell’evo che ho ascoltato e non visto. La fotografia è semplicemente magnifica e t’immerge in un ambiente vivo, fatto di larici che cantano e foreste che ondeggiano alle carezze del vento. Foreste non boschi.
Ogni inquadratura dei frammenti di montagna sembra commuoversi di lacrime alla bellezza, la vera grande bellezza. Ci sono cattedrali di pietra scolpite dall’impressionante e infinito, quasi mostruoso, rumore silenzioso del tempo che scorre. Penso al lavoro di Sorrentino del 2013 che ho amato di passione viscerale e credo che, per quanto sublime, ritragga una Roma stupefacente che comunque resta una lontanissima copia umana di ciò che era ed è il regno di Gea. Questo è il metro di pargone per chi viene dalla città: quest’immensità semplice è ciò che compare dentro il cinema.
Ed ecco la storia… una delle tante che si potrebbero raccontare parlando dei piccoli uomini che si muovono in questo luogo d’incanto in cui vige la “legge della zanna“. Non c’è musica, parla la magia dei respiri che si trattengono, un fotogramma alla volta, ricordando e vivendo i brandelli di una vita naturale.
Pietro Sieff… uomo ferito, come una bestia che vaga, dato per morto che cammina da, e in, una società piccola, fatta di gerarchie nell’alcova di un paese, autoreferenziata tra saggi ignoranti, “end to end”.
Pietro fatto di silenzi e di demoni che si nascondono nelle pieghe di un volto scolpito dalla montagna, cicatrici invisibili scomparse tra rughe procurate dal tempo. Uomo rude e schivo che lavora alla cava con gli altri valligiani, ricordando le atmosfere descritte nelle prime opere di Mauro Corona, quelle più genuine.
Domenico, quattordicenne alla ricerca della sua crescita e di una figura di padre in cui credere, che non aspetta altro che un poco di dialogo, approvazione, amore, insegnamento nelle lacune di una madre, dei ricordi, della propria consapevolezza, che scorge l’uomo dentro l’uomo, il modello a cui aspirare all’interno di un guscio di dolore.
Il cinema e l’orologio scompaiono lasciando il posto alla vorticosa immutabile calma delle montagne, ai profumi dei formaggi e degli insaccati, alle uova sode che si conservano per le grandi avventure, al rumore dei pugni sui tavoli giocando a carte nelle locande tra soli uomini, al frastuono dell’assenza delle donne.
Diau, l’orso che tutti credevano morto, la bestia che ha imparato la sua immortalità dalle ferite degli umani che terrorizza, incita, ammalia: Diau, il diavolo, la variabile che squilibra l’equazione, l’inafferabile caso in un modo deciso, l’istinto primordiale che inquieta la calma apparente di un luogo immutabile che può durare giusto un battito di ciglia o il boato di uno schioppo.
Una scommessa, come in ogni buona storia di paese, dà il via alla caccia, quella al pericolo di una microsocietà protolegalistica e quella dello scampo personale. Una scintilla che fa partire il piccolo falò di vite intrecciate.
Domenico che vuol crescere, che sa sparare ma non conosce l’uccisione e le donne, che scoprirà cosa significhi esser adulto: la vera perdita, il dolore, la gioia, una profezia che si avvera nel ciclo naturale.
Pietro che si libera dei suoi fantasmi, abbattendoli, e vedendosi allo specchio, ammazzando la sua immagine, liberandosi da essa al prezzo di perdere se stesso. La libertà della sua storia che diventa viva, non un peccatore ma un marito ferito, non un carnefice, ma una vittima; il perdono e il figlio riconquistato con cui diventar padre per pochi attimi prima del divenire delle cose.
Il gioco di tre sorrisi, quello di un amante che ghigna anche da morto, quello di un padre che gioca con il proprio figlio orsetto in riva a un lago, e quello di un cacciatore, libero dal passato, finalmente senza più ombra sul viso, lo stesso volto rimasto senza parole e senza colpi qualche attimo prima. Assenza.
Domenico che finalmente è Sieff… adesso uomo, senza più nessun peso su di sé, ora comparso alla luce, tra montagne meravigliose, immutate al mutare della storia dei piccoli uomini tra le valli.
Marco Paolini, un attore, ma molto di più: un uomo che conosce le montagne che in una parte di questo personaggio rievoca quel verismo viscontiano de La Terra Trema in cui gli uomini recitano se stessi. Un personaggio e un metaruolo realista, il primo fruitore della storia prima ancora che il primo interprete.
Marco Segato, che con la sua regia espone un mondo vero, anni ’50, differente in parte da quello narrato nella storia originale di Matteo Righetto, che strizza l’occhio al genere western, richiamando la tensione mozzafiato del leggendario Sfida a White Buffalo con Charles Bronson.
La pelle dell’Orso non è un film, è un viaggio geografico e temporale, un opera 4D, in grando di trasformare gli astanti in valligiani, per 92 minuti o una manciata di battiti.
Christian Roccati
SITO – Follow me on FACEBOOK
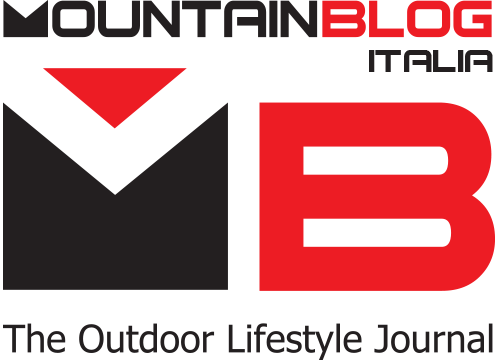








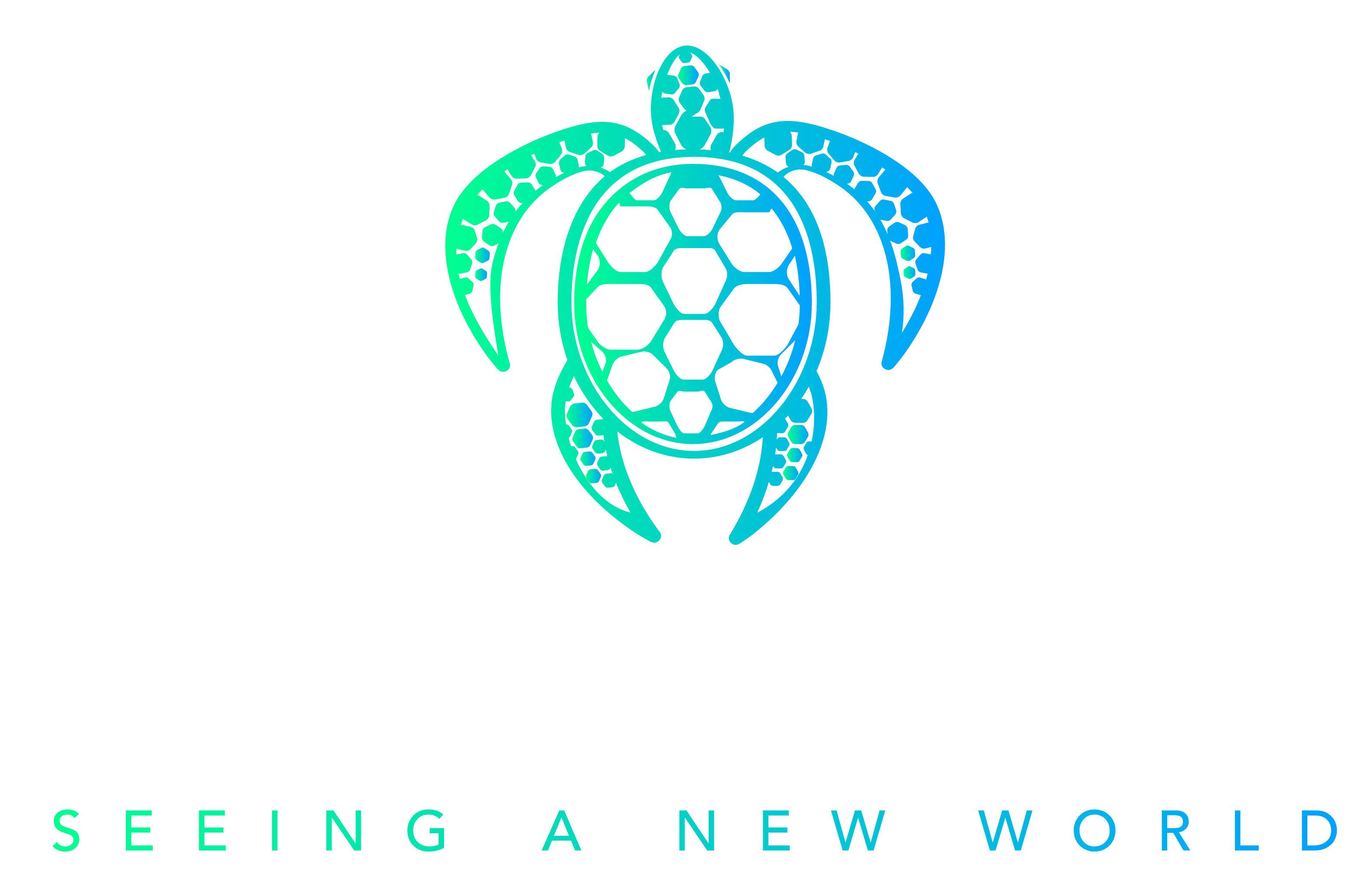









































Meraviglioso e struggente, aspro ma sincero. Avercene di prodotti cinematografici italiani così rigorosi e asciutti !