 Stefan Glowacz, 41 anni, ha esordito nell’arrampicata vincendo nel 1985 a Bardonecchia la prima competizione ufficiale nella storia dell’arrampicata sportiva, disciplina in cui ha eccelso fino al 1993, quando dopo aver vinto tre edizioni dell’Arco Rock Master ed essersi laurato vicecampione del mondo ad Innsbruck ha deciso di interrompere la sua carriera agonistica per dedicarsi all’arrampicata su roccia e alle spedizioni alpinistiche. Tra queste spiccano il superamento del "Passaggio di Drake" in Antartide con una barca a vela per raggiungere il Renard Tower e le più recenti spedizioni in Patagonia sulla parete nord del Cerro Murallòn, tutte caratterizzate da una consapevole rinuncia all’ausilio di mezzi tecnologici, compresi elicotteri e motoslitte per l’avvicinamento.
Stefan Glowacz, 41 anni, ha esordito nell’arrampicata vincendo nel 1985 a Bardonecchia la prima competizione ufficiale nella storia dell’arrampicata sportiva, disciplina in cui ha eccelso fino al 1993, quando dopo aver vinto tre edizioni dell’Arco Rock Master ed essersi laurato vicecampione del mondo ad Innsbruck ha deciso di interrompere la sua carriera agonistica per dedicarsi all’arrampicata su roccia e alle spedizioni alpinistiche. Tra queste spiccano il superamento del "Passaggio di Drake" in Antartide con una barca a vela per raggiungere il Renard Tower e le più recenti spedizioni in Patagonia sulla parete nord del Cerro Murallòn, tutte caratterizzate da una consapevole rinuncia all’ausilio di mezzi tecnologici, compresi elicotteri e motoslitte per l’avvicinamento.
Abbiamo incontrato Stefan Glowacz il 5 maggio scorso, in occasione della presentazione delle sue ultime avventure in Patagonia alla 54^ edizione del TrentoFilmFestival.
 D: Stefan Glowacz, fino al 1994 sei stato un campione del free climbing, direi anzi un pioniere: dal ’94 hai lasciato il free climbing per l’alpinismo, pechè?
D: Stefan Glowacz, fino al 1994 sei stato un campione del free climbing, direi anzi un pioniere: dal ’94 hai lasciato il free climbing per l’alpinismo, pechè?
R: Non ho in realtà mai smesso con il free climbing: arrampicare è ciò che faccio ancora oggi, semplicemente ho smesso di gareggiare. Ho fatto gare per otto anni, dall’85 al ’93, anno in cui ho deciso di concludere la mia carriera nelle competizioni internazionali. Ma ho comunque continuato fare free climbing.
Nel frattempo ho cominciato sempre più con l’organizzare e condurre spedizioni nelle zone e sulle pareti più sperdute e remote della terra, ad esempio in Antartide, dove abbiamo addirittura navigato a vela attraverso il “Passaggio di Drake” per raggiungere e scalare una parete di 900 metri, il Renard Tower! E tutto questo io l’ho sempre fatto con l’atteggiamento del free climber, non attrezzando una parete per superarla con mezzi tecnici, ma affrontandola con la filosofia dell’arrampicata libera.
Il fattore determinante che caratterizza le spedizioni in queste regioni estreme, è che cerchiamo di condurle rinunciando il più possibile ai mezzi di trasporto, affidandoci alle nostre sole forze. In questo modo già l’avvicinamento diventa una spedizione, un’avventura in se stesso.
D: Cosa differenzia sostanzialmente l’arrampicata su parete artificiale da una spedizione in Patagonia?
R: Beh, credo che si tratti di due discipline completamente diverse: sarebbe difficile paragonare l’arrampicata su pareti naturali, in montagna, alle gare e all’arrampicata su parete artificiale. Io considero l’arrampicata su parete artificiale come una disciplina a se stante, anche perché non è possibile superare su terreno naturale le stesse difficoltà che si hanno sulla parete artificiale.
D: Ma facendo un paragone? Cos’è la cosa più difficile di un’arrampicata su parete naturale?
R: La cosa più difficile è che in natura ci sono molti fattori che non si possono prevedere: sono il tempo atmosferico, il ghiaccio o la caduta improvvisa di pietre. Mentre in palestra non si tratta d’altro che di gesto atletico e di sport, arrampicare su terreno naturale richiede molta più esperienza perché c’è il confronto con la natura stessa: questo è un aspetto essenziale, ed è per questo che attualmente in Germania l’intero movimento dell’arrampicata nasce e si sviluppa nelle palestre, mentre sono pochi quelli che dopo aver cominciato sull’artificiale continuano anche in natura.
 D: Pensi che arrampicare in montagna, rispetto alla parete artificiale, possa favorire un “ritrovare” se stessi?
D: Pensi che arrampicare in montagna, rispetto alla parete artificiale, possa favorire un “ritrovare” se stessi?
R: Sì, certo. I più praticano l’arrampicata in palestra per un fatto di socializzazione: si possono incontrare amici, ci si può confrontare con gli altri, ci si mette in evidenza. Ma in montagna ci si ritrova con se stessi, e soprattutto in questo genere di spedizioni in regioni remote bisogna avere molto chiaro a stessi che cosa ci si aspetta di trovare. Significa che tutto quello che si fa bisogna desiderarlo, amarlo, ci deve essere una passione, altrimenti non è possibile superare certe difficoltà: sono troppo dure.
D: Parliamo ancora delle tue spedizioni… Una cosa che mi ha colpito è questo tuo partire da così lontano, per arrivare a quello che è l’obiettivo vero e proprio – la parete o la montagna da scalare. Sono delle spedizioni nella spedizione, come dicevi prima, soprattutto perché le affronti con il minor numero di mezzi possibile: cerchi apposta degli avvicinamenti così impegnativi?
R: Sì, li cerco apposta. Le grandi montagne – il Fitz Roy, o il Cerro Torre – mi interessano, ma per me è un logico sviluppo dell’alpinismo il fatto di cercare di conquistare pareti difficili in regioni difficilmente accessibili. Questo significa però anche rinunciare consapevolmente ai mezzi artificiali che la moderna tecnologia mette a disposizione: ci si può far portare in qualsiasi luogo del mondo con l’elicottero o l’aereo, ma questo è solo un dispendio logistico ed economico. Credo che al giorno d’oggi si debba definire il proprio modo di fare avventura in un altro modo; il mio è rinunciare ai mezzi artificiali, all’elicottero, all’aereo, partire dall’ultimo punto civilizzato e raggiungere con le proprie forze la parete, cercare di scalarla e tornare indietro con le proprie forze. Questa è la mia definizione dell’alpinismo moderno e delle spedizioni alpinistiche.
D: Potrebbe essere anche una definizione dell’avventura moderna?
R: Naturalmente lo è: al giorno d’oggi dobbiamo ridefinire che cos’è avventura. L’utilizzo delle previsioni meteo con il telefono satellitare, ad esempio, è un mezzo artificial
e, ed uno dei più determinanti: tanto che poche spedizioni, senza di esso, arriverebbero in cima. Io decido di rinunciare anche a questo mezzo…
D: Hai mai fatto alpinismo da solo? E se no, lo faresti?
R: Tempo fa da giovane ho fatto molto da solo, senza riflettere su cosa facevo. Poi durante un’arrampicata in solitaria sono caduto, grazie a Dio da un’altezza di “soli” otto metri, a causa della rottura di un appiglio della cui tenuta mi ero affidato al 100%. Cadendo da otto metri d’altezza mi si è distrutto il tallone e si sono rotti i menischi: ho dovuto smettere di arrampicare per quasi un anno. Questo fu per me un segnale. Avevo fatto in solitaria molte vie pericolose, e pensavo naturalmente di fare altrettanto nelle spedizioni, ma dopo questo incidente mi è divenuto chiaro quanto io ami la vita, e come sia un oltraggio metterla a rischio in questo modo.
Oggi non lo farei, perchè la vita mi sta a cuore, perchè ora so come ci si sente dopo che si è caduti: ricordo il momento in cui giacevo a terra, consapevole di essermi ferito gravemente ma di essere sopravissuto. Sarebbe bastato un metro in più, o cadere un po’ più in là su di uno spuntone di roccia, e probabilmente sarei morto. Nel momento in cui realizzai tutto ciò mi divenne chiaro che non ne valeva la pena, che la vita è troppo preziosa.
D: Si potrebbe affermare che il rischio in se stesso non è solo privo di senso, ma addirittura che non sia etico?
R: Non direi questo: ognuno deve poter decidere per se stesso. Io ho deciso per me, ma non vorrei mai fare da paragone, giudicare o criticare qualcun altro. Ognuno deve essere a posto con se stesso, quando decide di scalare una montagna o una difficile parete da solo: questa è unicamente e solamente una sua decisione, a se stesso deve rendere conto perché e come lo fa.
D: Per concludere, che cosa suggeriresti ad un giovane che voglia avvicinarsi all’alpinismo?
R: Penso che ogni giovane, ma anche ogni uomo di ogni età, debba vivere i propri sogni, e questo in qualsiasi campo: che sia l’alpinismo, l’arrampicata, ma anche nella propria professione, nel privato. Credo che ognuno dovrebbe cercare di vivere i propri sogni, e non lasciare che rimangano tali.
Intervista di Andrea Bianchi.
© Etymo gmbh-srl.
Sito ufficiale di Stefan Glowacz (in lingua tedesca) >
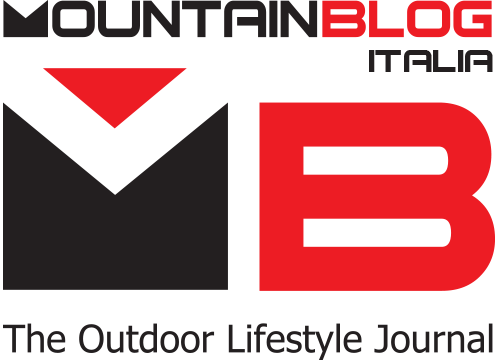
 Action
Action
























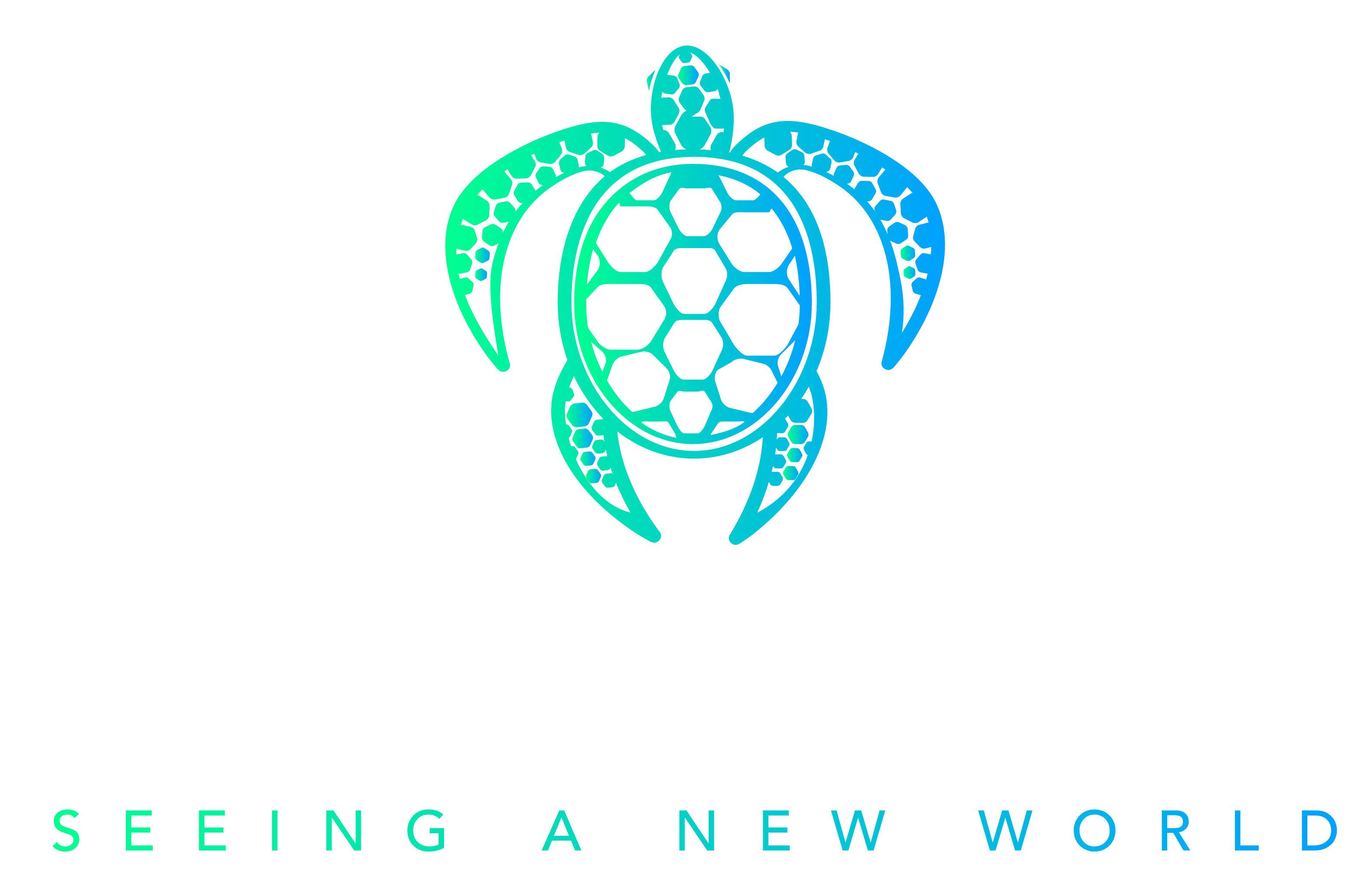





































Sono venuta a conoscenza del vostro nuovo blog cercanto in google informazioni su Stefan Glowacz. Mi sembra una gran bella iniziativa che debba essere publicizzata opportunamente in modo da renderla un interessante diario di montagna in cui raccontare le proprie avventure ed esprimere le proprie emozioni magari contagiose ! In quanto a Stefan l’ho conosciuto al 54 Film Festival di Trento e m’è piaciuta molto, oltrechè la sua superba interpretazione dell’alpinismo moderno, la sua dimensione umana il suo senso della mortalità e della sofferenza dell’essere umano; l’avventura intesa come qualcosa che riguarda l’uomo e la natura e il loro eterno ed intramontabile rapporto. Questa è la vera dimensione da cui possono nascere poi tante altre situazioni anche “artificiali” o meramente “tecnico-sportive”. Perfotuna che persone come Stefan ci ricordano che l’uomo ha superato ogni tipo di difficoltà,in ogni epoca, per il fine vero di conoscere e vivere. . .anzi di sopravvivere!
“raggiungere con le proprie forze la parete, cercare di scalarla e tornare indietro con le proprie forze” ha un senso perchè crea il vero rapporto uomo-natura che di per sè giustifica la nostra esistenza. Solo nelle società occidentali dei nostri tempi rischiamo spesso di perdere il senso della vita, persi in obiettivi futili e scioccamente edonistici. Grazie a Stefan e a quelli che la pensano come lui.
Beh…. Son qui per CASO !! Non sapevo proprio di qs blog, son capitato semplicemente “navigando”. Lascio un commento qui, perchè leggendo qs righe mi è tornato alla mente un giorno di molti anni fa in cui ho avuto modo CASUALMENTE di arrampicare con Stefan e di scambiare quattro chiacchiere…. Erano i tempi in cui faceva gare (e le vinceva !!): ma mi ha sempre affascinato, comunque, quella ricerca che lo accompagnava (e lo accompagna tutt’ora….!!) rincorrendo gradi sempre più difficili e appigli sempre più distanti sulle montagne di tutto il mondo…. CIAO!
Gianluca, anche se sei capitato di qua per caso – e se è vero che le cose non accadono “per caso” – ti invito a continuare a seguire Mountain Blog iscrivendoti alla newsletter , anche perchè di questa “ricerca degli appigli” credo che parleremo ancora sia con Stefan che con altri protagonisti; a Stefan in particolare stiamo cercando di fare arrivare questi commenti per avere da lui qualche battuta in merito…
Andrea Bianchi
Resp. progetto di comunicazione Mountain Blog
mi piace come S si confronta con la montagna e con se stesso.la rinuncia a certe tecnologie gli da modo di valutare appieno le sue possibilità. ad maiora sonia