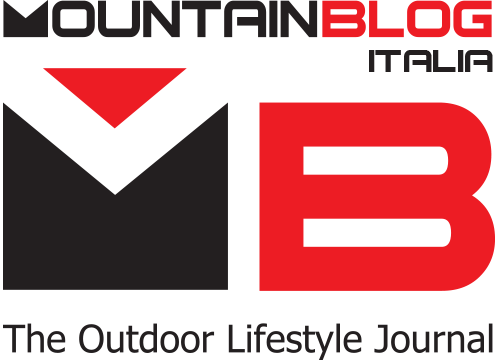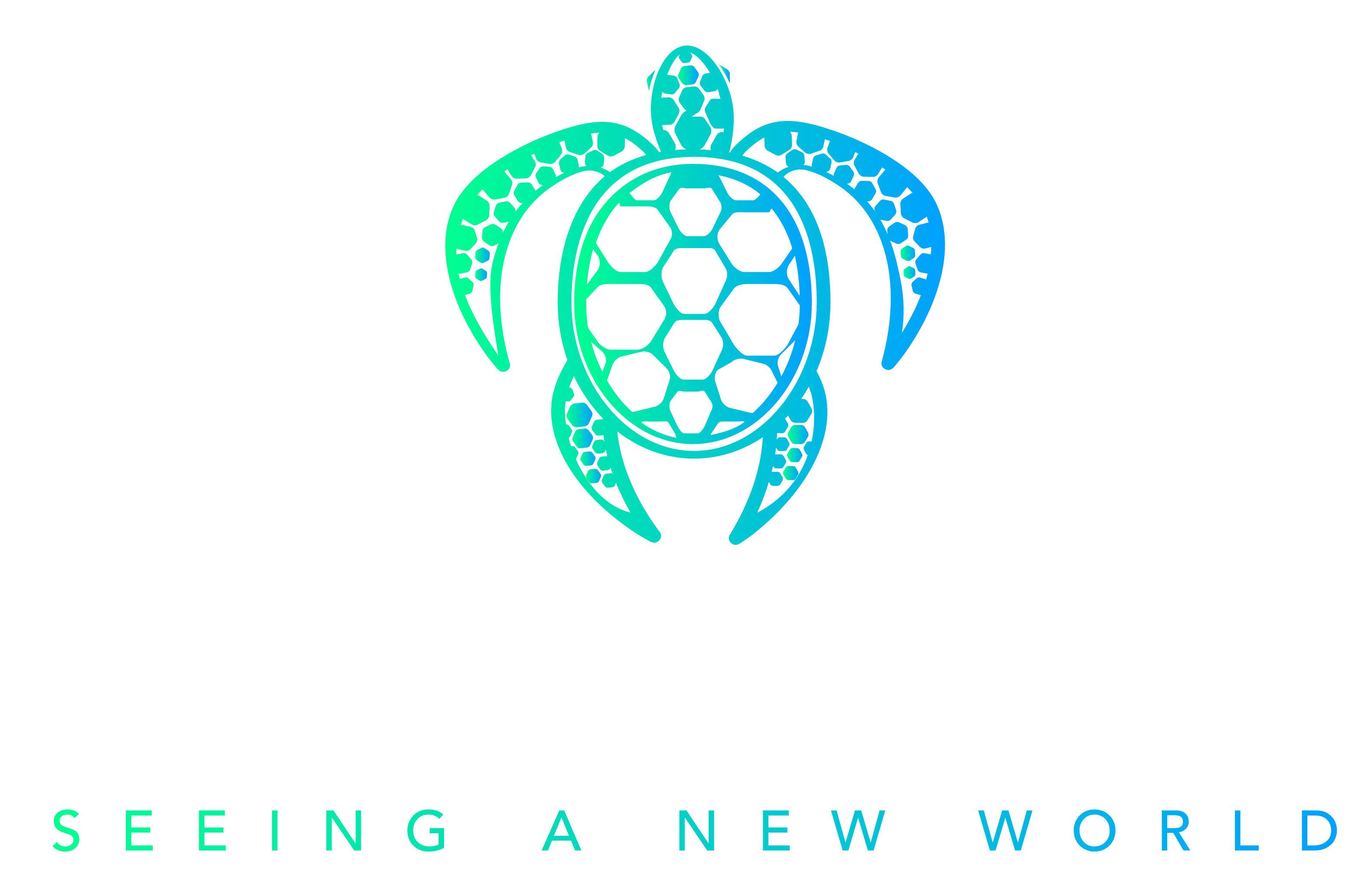Fine febbraio. Sarà l’ultima salita sul ghiaccio d’acqua di quest’anno? Probabilmente sì, almeno nello “stile” che ormai da parecchi anni ho fatto mio: la solitaria.
Fine febbraio. Sarà l’ultima salita sul ghiaccio d’acqua di quest’anno? Probabilmente sì, almeno nello “stile” che ormai da parecchi anni ho fatto mio: la solitaria.
Questi inverni sempre meno freddi e nevosi hanno rimescolato le carte dopo tanti anni di ripetizioni da favola e parecchie prime ascensioni. Qui, però, in Val Grande di Lanzo, nel cuore delle Alpi Graie Meridionali, gioco in casa. Alle spalle mi lascio la catena di confine. Appena lì dietro ci sono la Vallée de l’Arc e il Massif de la Vanoise. Poco più a nord il Gran Paradiso e dieci chilometri più in basso, nella valle, c’è casa mia.
Un’ultima giornata così “visionaria”, vissuta in solitaria tra le montagne che amo e di cui conosco ogni piega, non può fare a meno di un breve passaggio in osteria, a “ritualizzare” la chiusura di questo ciclo. Non un’osteria qualunque, s’intenda, ma un pezzo di storia di queste montagne e del mio vissuto. Le vere osterie di montagna (che sono anche trattorie, le sottigliezze qui si annullano), sono ormai una rarità. E per “vere” intendo quelle ancora gestite da montanari, con un’attività tramandata per generazioni. Sono locali che trasudano storia e per un’alpinista, specie se anch’egli montanaro, s’inseriscono in quella geografia degli affetti che costituisce il tessuto genuino di una montagna che sta perdendo la sua specificità.
Lì, ti può ancora capitare di sentire parlare (e di poter parlare) in patois, ma potrebbe essere una qualsiasi altra lingua del variegato arco alpino, laddove queste osterie ancora esistono. Ci puoi ancora trovare i vecchi del paese, quelli che “la sanno lunga”, assistere ad allegre ribotte tra cacciatori e valligiani. Qualche volta, se passa la persona giusta, anche trovarti in mezzo a un canto spontaneo, che nasce così, dal nulla o meglio tra un bicchiere di rosso e l’altro.
Tre chilometri dal fondo valle ed eccomi arrivato. “Cà di Martu” in piemontese, Queu eud Martou in patois francoprovenzale, è un piccolo angolo tra le montagne di quest’ultimo comune delle Val Grande di Lanzo: Groscavallo. Lì di certo non ti serviranno mai sei agnolotti bolliti serviti su un letto di cubetti di ghiaccio, oppure sofisticati impiattamenti da ristoranti stellati, in cui il cibo letteralmente sparisce. Ristoranti da cui esci con il tuo stomaco di alpinista mezzo vuoto e che reclama vendetta, specie dopo aver pagato il conto. Qui a Cà di Martu, quando superi la piccola bussola, che dà accesso al piccolo “baretto”, ti assale l’odore di civet, di fricandò, di arrosto casalingo e di crespelle, di formaggio d’alpe e di burro fuso. In genere nelle vere e antiche trattorie di montagna, l’arredo deve essere piuttosto caotico. Esattamente come qui. La “montagna” è richiamata da mille oggetti di diverse dimensioni appesi ovunque: quadri lasciati da pittori innamorati del luogo, ricordi di momenti di festa, oggetti di famiglia, in un insieme che crea un “luogo”.
Se da un lato quest’atmosfera farebbe impallidire gli amanti del raffinato, di quei locali dove, quando entri, quasi ti senti a disagio, qui invece ti accoglie e ti precipita in una dimensione senza tempo. Se foste passati di qui una domenica d’autunno di cinquant’anni fa, avreste potuto incontrare Gian Piero Motti, che sulle rocce di questa valle, sopra casa sua, creò il germoglio del Nuovo Mattino, poi le crepuscolari Antiche Sere di Sea. Oppure avreste trovato Gian Carlo Grassi, la cui casa dista soltanto un centinaio di metri. Come quella volta in cui, proprio qui di fianco, su una spessa corazza di ghiaccio che si era formata sulle rocce bagnate nella strettoia della strada, portò una comitiva di alpinisti belgi a sperimentare le basi della piolet-traction. Ma l’osteria in realtà esiste dalla fine del Settecento e se queste mura potessero parlare racconterebbero la storia di viandanti venuti a piedi dalla Savoia, dopo aver sfidato alti passi glaciali e profondi crepacci. Testimonierebbero le gesta dei pionieri dell’alpinismo della seconda metà dell’Ottocento, come Vaccarone, Martelli, Corrà, cui occorrevano un giorno e mezzo di viaggio da Torino per raggiungere le vette lassù, ancora in gran parte inesplorate.
Ed io?
Io mi rivedo tanti anni fa, ragazzo curioso, carpire i segreti di Pietro Garbolino Riva, cacciatore e soccorritore di montagna emerito. Da lui appresi i segreti dei valloni di Mombran e di Marmorand, dei passaggi esposti sul vuoto, lungo le incredibili cenge dell’Invernou. Quante volte, grazie a una parte quel sapere ormai andato perduto, sarei passato lassù di ritorno dalle mie scalate. E quante volte sono passato di qui a festeggiare delle “prime”. Come quella volta, di ritorno dalla prima ripetizione della via “Barisone-Ghizzetti”, che dopo un percorso davvero eterno e impegnativo, raggiunge i 3452 metri della Punta Martellot, quella che i francesi de l’autre côté chiamano “Roc du Mulinet”. Avevo la febbre e dopo il terzo bicchiere di vino avrei voluto gettarmi nel mio letto, ma Valerio, compagno di cordata, forse per la sincerità del “rosso”, si era improvvisamente invaghito della cameriera e non ne voleva più sapere di andarsene. Quante volte, correndo su e giù per la pista di fondo, che passa dall’altra parte della strada, sono entrato qui dentro a cercare generi di conforto, quando gli inverni, quassù erano ancora come si deve. Sorseggio il mio bicchiere di vino.
In questo pomeriggio settimanale soleggiato, la trattoria è tranquilla, cosicché Federico si alterna come taglialegna e come barista, mentre Daniela, di là, si divide tra la cucina è la stiroira allestita in sala da pranzo, al caldo del caminetto. Questa è la trattoria di montagna, un luogo fatto di cibo genuino, di storie e di memorie. Un pezzo di cultura materiale della montagna sempre più raro. Come questo ghiaccio d’acqua su cui, appeso alle piccozze e in punta di ramponi, quest’anno mi sono ancora tolto delle belle soddisfazioni. Ma è ora di scendere. Il sole ormai ha superato le creste. La primavera sta arrivando.
Marco Blatto