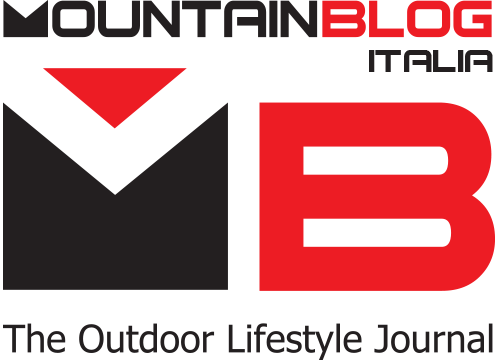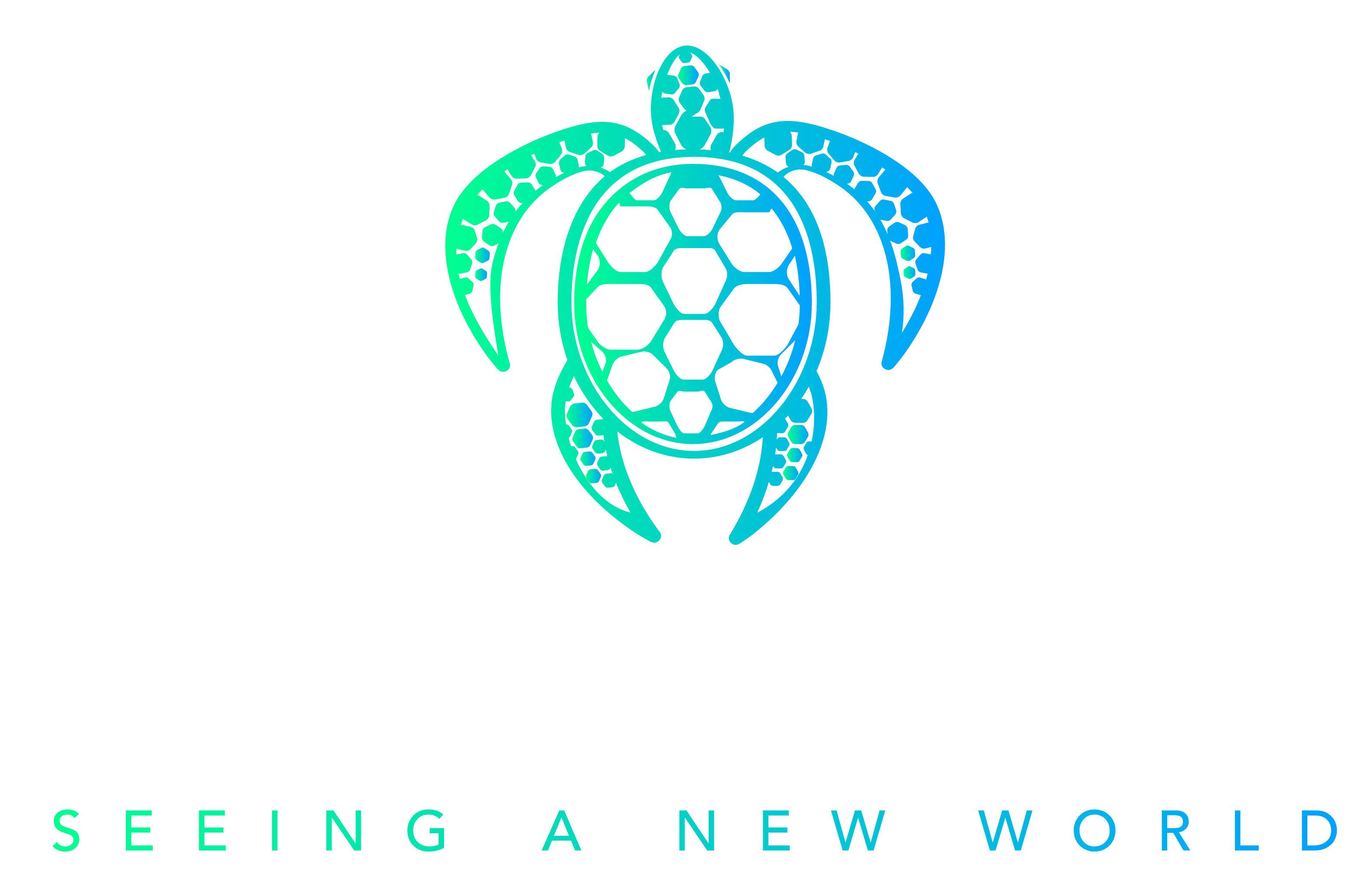Prima della “scoperta” di Schievenin – vedi articolo precedente – uno dei centri di arrampicata più frequentati del Veneto era la Palestra di roccia della Valle di Santa Felicita, un luogo selvaggio e caratteristico a meridione del Massiccio del Grappa, un tiro di schioppo da Bassano.
Prima della “scoperta” di Schievenin – vedi articolo precedente – uno dei centri di arrampicata più frequentati del Veneto era la Palestra di roccia della Valle di Santa Felicita, un luogo selvaggio e caratteristico a meridione del Massiccio del Grappa, un tiro di schioppo da Bassano.
Questa valle – come ricordava il mitico Giovanni Zorzi di Bassano – è una delle più importanti del Massiccio. Lunga quasi nove chilometri, si origina a quota 1200 metri circa ai piedi del Col della Berretta e sfocia in pianura a quota 250 presso il caratteristico borgo di Romano d’Ezzelino. La valle, che in realtà è unica, si può dividere in due parti ben distinte: in alto è conosciuta come Valle di San Lorenzo, ampia, verde, ricca di pingui pascoli e qualche malga; nella parte bassa si chiama Valle di Santa Felicita, ripida, selvaggia, un canyon che termina con lo Scalon al quale segue una fiumana di ghiaie di fronte al colle dove sorgeva fino al 1259 il castello degli Ezzelini. Dante Alighieri la nomina nel Paradiso (IX, 25).
Raccontava sempre Zorzi che l’aspetto desolato della valle, le spaventose alluvioni, l’eco di foschi episodi medioevali … resero questo luogo tristemente famoso e crearono cupe leggende sopravvissute fino alla metà del secolo scorso. In fondo alla valle, secondo documenti storici accertati, intorno all’anno 1000 c’erano dei prati, alcune case, un convento e vi si teneva mercato.
 I primi frequentatori di questa palestra furono gli istruttori della Scuola Allievi Ufficiali Alpini di Bassano nel 1940. Particolarmente attivo nella tracciatura e nella segnatura degli itinerari fu il sergente maggiore Sigismondi che lavorò sulle due pareti principali, alte una quarantina di metri. Qui tracciò dodici itinerari, un tredicesimo fu aperto più avanti, a sinistra entro un canalone, mentre le traversate Alta e del Cristo furono aperte allora, ma non segnate. Tra il 1946 e il 1950 gli istruttori del Cai di Bassano aprirono altre sette vie, sempre su ottima roccia di calcare grigio-nero. Agli itinerari classici furono poi apportate un’infinità di varianti, tant’è che non esiste metro quadro di roccia che non sia stato percorso.
I primi frequentatori di questa palestra furono gli istruttori della Scuola Allievi Ufficiali Alpini di Bassano nel 1940. Particolarmente attivo nella tracciatura e nella segnatura degli itinerari fu il sergente maggiore Sigismondi che lavorò sulle due pareti principali, alte una quarantina di metri. Qui tracciò dodici itinerari, un tredicesimo fu aperto più avanti, a sinistra entro un canalone, mentre le traversate Alta e del Cristo furono aperte allora, ma non segnate. Tra il 1946 e il 1950 gli istruttori del Cai di Bassano aprirono altre sette vie, sempre su ottima roccia di calcare grigio-nero. Agli itinerari classici furono poi apportate un’infinità di varianti, tant’è che non esiste metro quadro di roccia che non sia stato percorso.
Una parete, più delle altre, attirava coloro che volevano fare un salto “di qualità” nella scala delle difficoltà. Parlo degli anni Sessanta-Settanta del Novecento quando l’arrampicata libera (com’è intesa oggi) era nella testa e nelle braccia di pochi e la progressione su staffe era pane quotidiano, una moda, una necessità che non scandalizzava nessuno, tant’è vero che esisteva una apposita scala delle difficoltà: A1, A2, ecc. La parete in questione, bella, gialla, strapiombante, alta 40 metri, era el Pareton. Il solito Zorzi scriveva nel 1975 che questo “viene generalmente salito in artificiale”. La parola “generalmente” fa intendere che qualcuno lo saliva anche in libera. In quegli anni ero spesso in valle e non ho mai visto nessuno salire el Pareton senza staffe, neppure i più forti. Era normale e nessuno se ne vergognava. Era più vergognoso dire – come in effetti è stato detto da qualche personaggio poi diventato noto -: «Ho fatto la parete tal dei tali senza staffe.» Sì, senza le staffe classiche con i gradini di alluminio o di faggio, ma hai usato abbondantemente quelle di fettuccia che, se non sbaglio, sempre artificiale è! Sono un convinto fautore della massima libertà individuale in alpinismo e non voglio scendere in polemiche; ognuno faccia quello che vuole ma poi, per favore, non venga a dare lezioni di etica e, soprattutto, non racconti balle.
E non è una balla quella che segue.
 Un uomo sta sotto al Pareton e lo studia attentamente. È solo. Si capisce che vuol salirlo, ma non ha un compagno che lo assicuri. Io sono appena sceso da una via e sto mangiando una mela. L’uomo mi chiama, vuol sapere se sono libero. Gli dico di sì. Poi chiede se posso fargli sicurezza mentre sale el Pareton. Vorrei affrontare qualcos’altro, ma non oso dire di no a Renzo Timillero, in arte Ghigno, personaggio molto stimato in valle e fuori, guida alpina, ottimo alpinista, esperto soccorritore, gestore del rifugio Treviso in Val Canali. Insomma: un pezzo da novanta. Sono fiero di essergli utile e corro ad assicurarlo, senza tentennamenti. Sale con le staffe anche lui che è un big, sale da maestro come pochi, veloce, sicuro. Passa da un chiodo all’altro con la leggerezza di una farfalla. Chi ha praticato questa “disciplina” sa che sembra tutto facile; in realtà è molto faticoso, specie su strapiombo. Ghigno giunge in cima alla struttura e mi invita a salire. Sono onorato e parto. Certe staffe allora, prima dell’invenzione dei gancetti, avevano una maniglia di acciaio (coperto e “imbottito” da nastro adesivo da elettricista) con un uncino che andava infilato nell’occhio del chiodo; si saliva sulla staffa e si progrediva quanto possibile, quindi si recuperava la staffa rimasta libera, la si agganciava al chiodo superiore e via di questo passo. Naturalmente fra un passaggio e l’altro era salutare rimanere assicurati. A un certo punto io non lo feci con i dovuti crismi, il compagno tirò la corda con decisione e persi l’equilibrio. Non potei fare altro che tenermi al chiodo con l’indice della mano sinistra (all’ora non si gridava “orrore” se toccavi un chiodo) e contemporaneamente agganciai con la destra la staffa al chiodo. Potevo fare tutto con calma, tanto il Ghigno mi avrebbe tenuto; sarei andato giù al massimo di un metro; che necessità c’era di fare quella stupida manovra?! Mi ha fregato l’orgoglio, quello che in montagna non ci dovrebbe stare. Così, nella foga di agganciare la staffa, misi l’uncino sopra al dito indice, quello che si teneva “spudoratamente” al chiodo, poi veloce montai sulla staffa. Capii subito di aver fatto una cazzata da barzelletta, ma ormai c’ero e non restava altro da fare che alleggerire il peso per tirar fuori il dito. Provai e riprovai fino a stancarmi. Il dito era là fra chiodo e uncino, con tutto il mio peso sopra e non voleva saperne di liberarsi. Chiesi al compagno di tirare la corda, ma non sentiva. Quasi mi prese il panico. Cosa fare? Mi ricordai di aver mangiato una mela prima di partire e di averla sbucciata con un temperino. Ecco la soluzione. Tagliare il dito con il temperino che avevo in tasca, tanto si trattava solo della prima falange. Ero deciso a farlo; il dito era ormai nero, insensibile, non avrei sentito dolore. Allora presi il temperino dal taschino e attesi l’attimo di follia per portare avanti il progetto. L’avrei fatto? Certo che sì! Chi sta leggendo penserà che questa è una pietosa bugia e invece vi assicuro che è la verità. Quando sto per dare il colpo fatale il Ghigno tira la corda e lo fa con “quella” forza che ha un alpinista incazzato. Con l’alleggerimento del corpo il dito del disonore esce finalmente dal suo loculo e io continuo la salita. Il Ghigno mi accoglie con una smorfia, ma non dice nulla. Mi scuso per il ritardo dovuto – questa è una balla d’orgoglio di cui vergognarsi – a un maledetto nodo che si era formato, forse per colpa della vecchia corda. Timillero brontola e dice che la sua corda non è vecchia e non fa nodi, poi scende in doppia lasciandomi lì come un papavero. Aveva tutte le ragioni.
Un uomo sta sotto al Pareton e lo studia attentamente. È solo. Si capisce che vuol salirlo, ma non ha un compagno che lo assicuri. Io sono appena sceso da una via e sto mangiando una mela. L’uomo mi chiama, vuol sapere se sono libero. Gli dico di sì. Poi chiede se posso fargli sicurezza mentre sale el Pareton. Vorrei affrontare qualcos’altro, ma non oso dire di no a Renzo Timillero, in arte Ghigno, personaggio molto stimato in valle e fuori, guida alpina, ottimo alpinista, esperto soccorritore, gestore del rifugio Treviso in Val Canali. Insomma: un pezzo da novanta. Sono fiero di essergli utile e corro ad assicurarlo, senza tentennamenti. Sale con le staffe anche lui che è un big, sale da maestro come pochi, veloce, sicuro. Passa da un chiodo all’altro con la leggerezza di una farfalla. Chi ha praticato questa “disciplina” sa che sembra tutto facile; in realtà è molto faticoso, specie su strapiombo. Ghigno giunge in cima alla struttura e mi invita a salire. Sono onorato e parto. Certe staffe allora, prima dell’invenzione dei gancetti, avevano una maniglia di acciaio (coperto e “imbottito” da nastro adesivo da elettricista) con un uncino che andava infilato nell’occhio del chiodo; si saliva sulla staffa e si progrediva quanto possibile, quindi si recuperava la staffa rimasta libera, la si agganciava al chiodo superiore e via di questo passo. Naturalmente fra un passaggio e l’altro era salutare rimanere assicurati. A un certo punto io non lo feci con i dovuti crismi, il compagno tirò la corda con decisione e persi l’equilibrio. Non potei fare altro che tenermi al chiodo con l’indice della mano sinistra (all’ora non si gridava “orrore” se toccavi un chiodo) e contemporaneamente agganciai con la destra la staffa al chiodo. Potevo fare tutto con calma, tanto il Ghigno mi avrebbe tenuto; sarei andato giù al massimo di un metro; che necessità c’era di fare quella stupida manovra?! Mi ha fregato l’orgoglio, quello che in montagna non ci dovrebbe stare. Così, nella foga di agganciare la staffa, misi l’uncino sopra al dito indice, quello che si teneva “spudoratamente” al chiodo, poi veloce montai sulla staffa. Capii subito di aver fatto una cazzata da barzelletta, ma ormai c’ero e non restava altro da fare che alleggerire il peso per tirar fuori il dito. Provai e riprovai fino a stancarmi. Il dito era là fra chiodo e uncino, con tutto il mio peso sopra e non voleva saperne di liberarsi. Chiesi al compagno di tirare la corda, ma non sentiva. Quasi mi prese il panico. Cosa fare? Mi ricordai di aver mangiato una mela prima di partire e di averla sbucciata con un temperino. Ecco la soluzione. Tagliare il dito con il temperino che avevo in tasca, tanto si trattava solo della prima falange. Ero deciso a farlo; il dito era ormai nero, insensibile, non avrei sentito dolore. Allora presi il temperino dal taschino e attesi l’attimo di follia per portare avanti il progetto. L’avrei fatto? Certo che sì! Chi sta leggendo penserà che questa è una pietosa bugia e invece vi assicuro che è la verità. Quando sto per dare il colpo fatale il Ghigno tira la corda e lo fa con “quella” forza che ha un alpinista incazzato. Con l’alleggerimento del corpo il dito del disonore esce finalmente dal suo loculo e io continuo la salita. Il Ghigno mi accoglie con una smorfia, ma non dice nulla. Mi scuso per il ritardo dovuto – questa è una balla d’orgoglio di cui vergognarsi – a un maledetto nodo che si era formato, forse per colpa della vecchia corda. Timillero brontola e dice che la sua corda non è vecchia e non fa nodi, poi scende in doppia lasciandomi lì come un papavero. Aveva tutte le ragioni.
Un giorno, andando ad arrampicare sulla Pala e sul Sass d’Ortiga sopra il Rifugio Treviso (che lui gestiva con grande impegno e passione), gli ricordai il nostro incontro al Pareton di Santa Felicita quando quel dito spregevole … e gli raccontai il fattaccio. Non ci fece caso. Così serioso e tutto d’un pezzo com’era forse pensò alla solita barzelletta stupida che fa ridere solo chi la racconta. Se ne andò per i fatti suoi. Gli avevo solo narrato un errore stupido, ma vero. Anche gli alpinisti sbagliano. Soprattutto quelli che non hanno il coraggio di narrare i lati negativi e ridicoli della loro attività mentre se la godono a parlare delle loro imprese e a sparlare dei colleghi.
Tags: Bassano, CAI di Bassano, Giovanni Zorzi, Massiccio del Grappa, Renzo Timillero, Rifugio Treviso, Romano d'Ezzelino, Valle di Santa Felicita, Valle di Schievenin