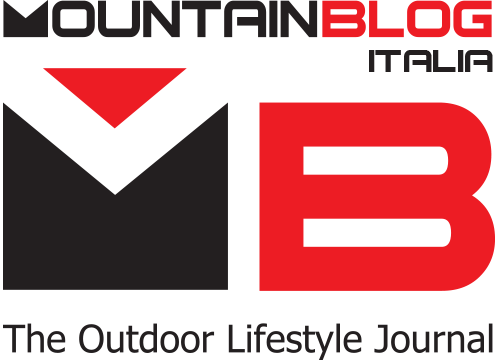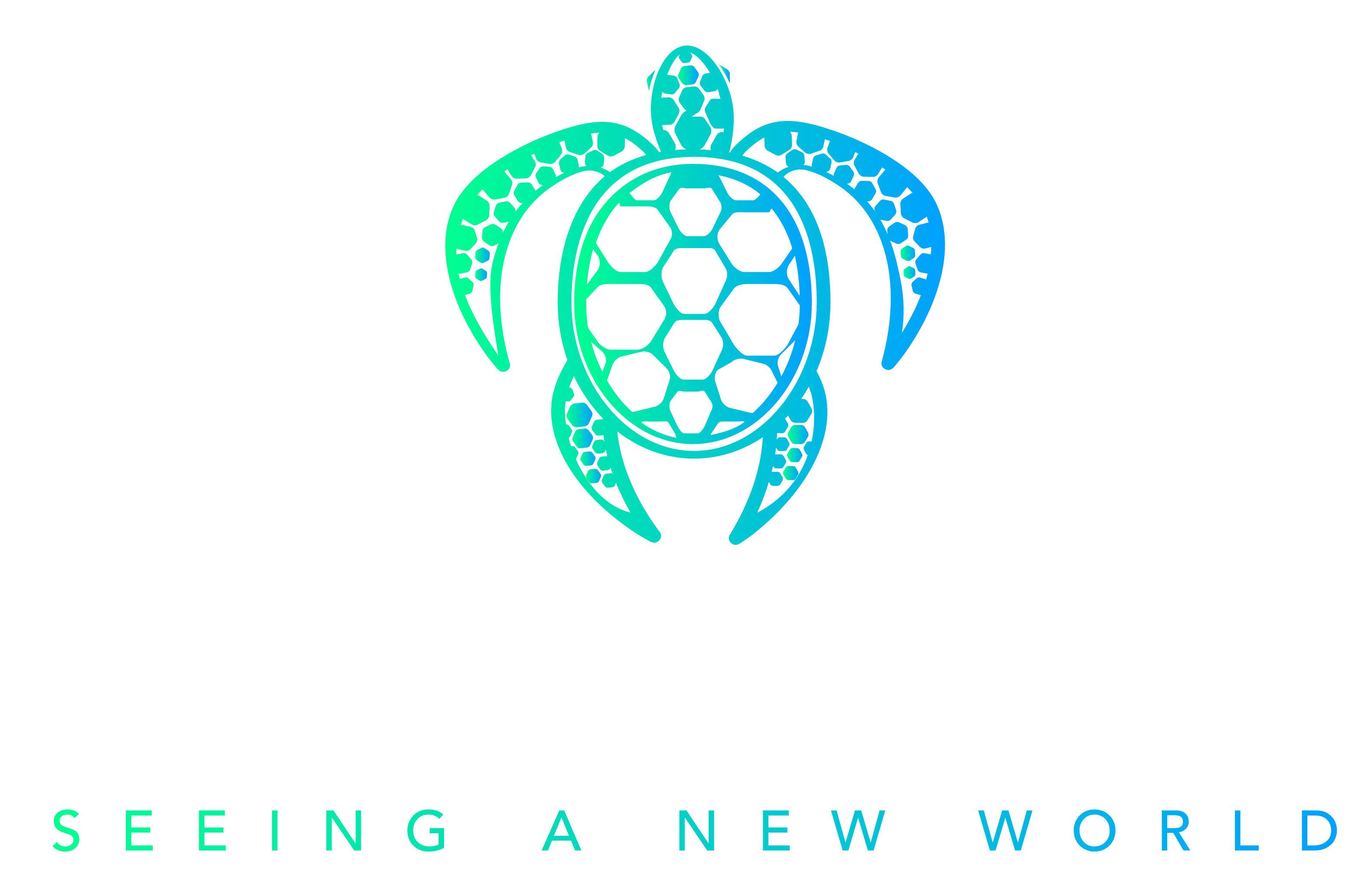“I confini dell’anima, nel tuo andare, non potrai scoprirli, neppure se percorrerai tutte le strade: così profonda è l’espressione che le appartiene”
Eraclito
Nell’andare per monti durante la nostra breve esistenza, ci rendiamo conto di essere in grado di disegnare una particolare geografia degli affetti. Si tratta di un insieme di luoghi – oppure anche di uno solo – che sentiamo di dover eleggere a “paesaggi dell’anima”. Quando vi facciamo ritorno, ogni volta, ritroviamo quella parte di noi che non è mai discesa a valle. E’ semplicemente rimasta lassù. I luoghi cambiano aspetto, è nell’ordine naturale delle cose, ma dal momento che l’“essenza” resta immutata siamo in grado di riconoscervi il nostro spirito. Ho raggiunto il rifugio Paolo Daviso nel vallone della Gura per la prima volta nel 1977, nel corso di un’escursione estiva con mio padre.
La prima notte in un rifugio. Ricordo ancora il volto del gestore, coperto di rughe e consumato dal sole, mentre mi mostra le vette circostanti. Picchi per me impensabili e misteriosi. Ed eccomi già un paio di anni dopo a sperimentare la mia piccozza nuova sulle dure e ripide nevi della “talancia”, l’insidioso scivolo di neve dura che rinserrato tra le rocce conduce al plateau superiore del Glacier des Sources de l’Arc, in Savoia. Ricordo quella notte nella cuccetta senza dormire, in un misto di eccitazione e preoccupazione.
Da allora non si contano le volte in cui sono giunto fin quassù per salire una cima o ricercare una via nuova, oppure spinto da ben altre motivazioni. Per esempio come in quel finire dell’estate in cui riuscii a salire tutti i giorni per una settimana intera pur d’incontrare la figlia dei gestori, i cui occhi blu mi avevano fatto dimenticare per un po’ i progetti ambiziosi che avevo su quelle montagne. La scusa dell’allenamento giornaliero non resse a lungo, e ancora mi pare di sentire le urla della madre che ci intima di scendere immediatamente dalle cuccette del locale invernale. Ricordo una volta al bivacco Rivero.
Dopo tre giorni di pioggia e bufera, infine “scornati” per due tentativi falliti nell’aprire una via nuova, avevamo deciso di scendere al Daviso per far asciugare un po’ i vestiti e le corde fradice, per dormire in un letto caldo e per fruire di un pasto decente. I nostri viveri erano andati perduti per una pazzia di Valerio, che aveva voluto calare in un crepaccio con uno spezzone i viveri deteriorabili, tra cui un quarto di prosciutto. Il crollo di un seracco aveva cancellato di colpo la nostra curiosa dispensa. Giunti al Daviso, incredibilmente, il gestore di turno ci aveva rifiutato anche il posto “d’emergenza”, giacché il locale era pieno di soci del club alpino saliti per una consueta, allegra spaghettata sezionale! E poi quella volta, d’inverno, quando fummo sorpresi da una furiosa nevicata all’uscita del couloir “O sole mio” al Dome Blanc du Mulinet. Sull’ultimo tiro l’amico Luca aveva perso la piccozza e le cose si erano parecchio complicate. Eravamo infine scesi aprendoci una traccia con la neve ai fianchi. Senza riuscire a risalire al Rifugio, ormai in piena notte, decidevamo di ripiegare sull’allora malagevole Rifugio Ferreri. Ogni volta, risalendo l’ultima ripida balza che porta al rifugio rivivo tutto ciò in modo nitido e preciso e quando metto piede sulla terrazza una tazza di tè caldo offerto dai gestori, mi fa sentire un po’ a casa.

2013: con gli amici del Cai di Cuorgnè dopo la seconda ascensione in solitaria del couloir nordest del Dome du Mulinet
Una volta ebbi modo di contestare il rifugio inteso come punto di “arrivo” e non di “partenza”, volendo fare riferimento alla scarsa considerazione che la sezione del club alpino in cui militavo riservava all’alpinismo. Forse non avevo ancora digerito l’episodio in cui, noi “scalatori”, fummo rifiutati perché l’alloggiamento era stato riservato a quel nutrito manipolo di allegri festaioli. Oggi il mio “sentimento della meta” è maturato attraverso nuove convinzioni e sensibilità e il mio “Daviso” è sempre là ad accogliermi come un padre affettuoso. Anche dopo una semplice camminata “senza vetta”.