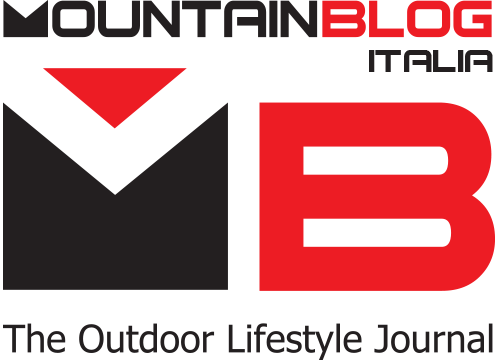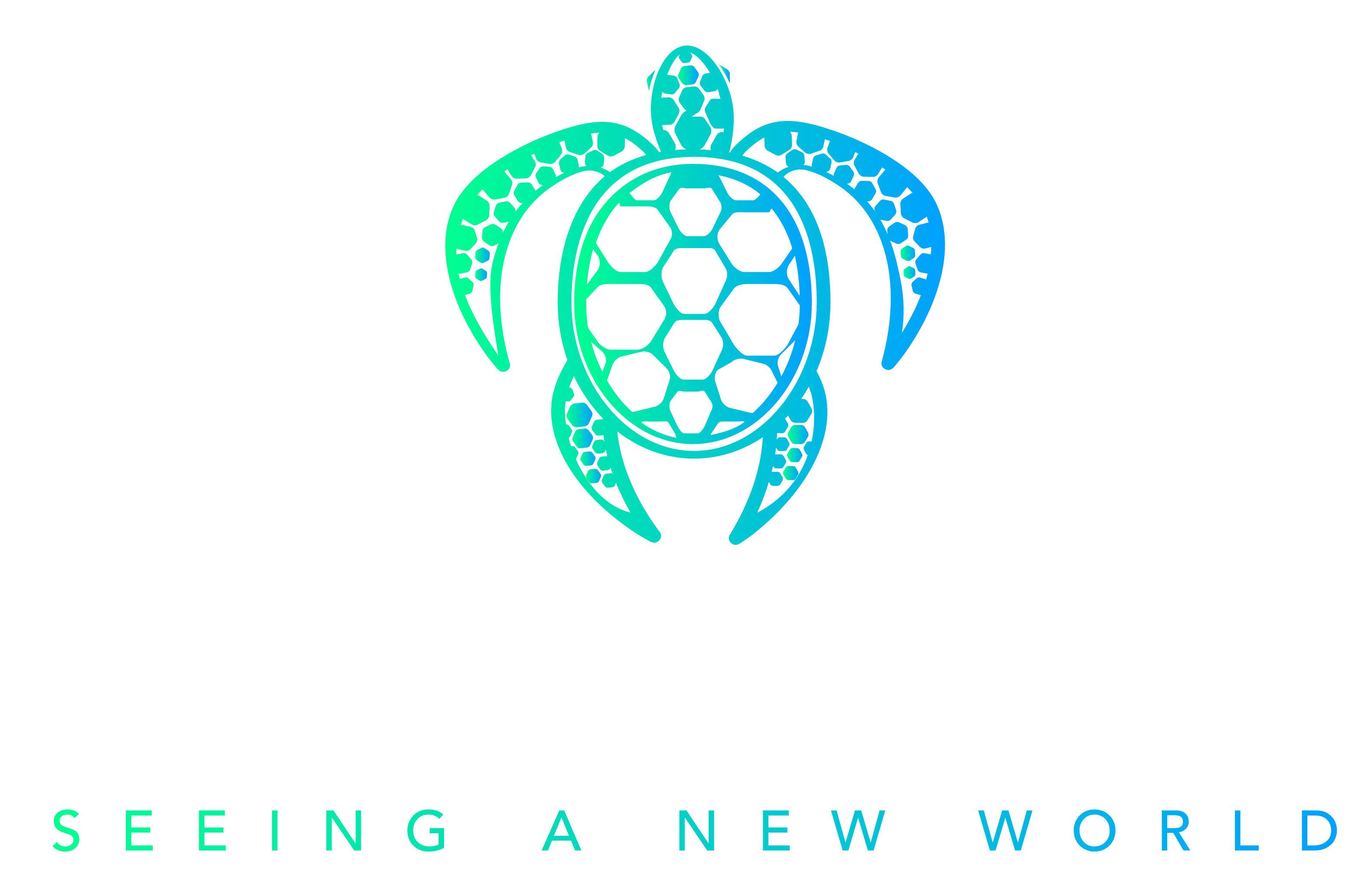Ho compreso la natura del mio alpinismo fin dalle prime uscite iniziatiche. Sono passati ormai trentasette anni dal giorno in cui, legato alla corda di Cosimo Zappelli, realizzai sulle rocce del Mont La Saxe il sogno di diventare uno scalatore. Tuttavia, già nel 1969 mi arrampicavo sui piccoli massi disseminati della Val Ferret spinto da un irrefrenabile desiderio di raggiungerne la sommità. Alzando lo sguardo verso le Grandes Jorasses e l’Aiguille de Prà Sec, immaginavo d’aver così compiuto un primo passo verso mete più ambite e difficili. Fin da subito ho altresì sentito il bisogno di scrivere le sensazioni che provavo anche durante semplici gite a piedi, maturando la convinzione che l’andare per monti era un’attività assai diversa dalle tante discipline sportive che praticavo, pur con soddisfazione e profitto. Nessuna di queste, infatti, mi aveva mai provocato emozioni tali da essere riportate su un quaderno o su un diario.
Ho compreso la natura del mio alpinismo fin dalle prime uscite iniziatiche. Sono passati ormai trentasette anni dal giorno in cui, legato alla corda di Cosimo Zappelli, realizzai sulle rocce del Mont La Saxe il sogno di diventare uno scalatore. Tuttavia, già nel 1969 mi arrampicavo sui piccoli massi disseminati della Val Ferret spinto da un irrefrenabile desiderio di raggiungerne la sommità. Alzando lo sguardo verso le Grandes Jorasses e l’Aiguille de Prà Sec, immaginavo d’aver così compiuto un primo passo verso mete più ambite e difficili. Fin da subito ho altresì sentito il bisogno di scrivere le sensazioni che provavo anche durante semplici gite a piedi, maturando la convinzione che l’andare per monti era un’attività assai diversa dalle tante discipline sportive che praticavo, pur con soddisfazione e profitto. Nessuna di queste, infatti, mi aveva mai provocato emozioni tali da essere riportate su un quaderno o su un diario.
Certamente pur non negando una componente sportiva dell’alpinismo, che può ragionevolmente rapportarsi con un naturale desiderio di primeggiare verso terzi oppure verso sé stessi, ho sostenuto e sostengo che il fine ultimo della scalata non possa essere  esclusivamente di ordine materiale. Sfido chiunque, infatti, a dimostrare che quest’ultimo possa essere considerato come totalmente appagante, come del resto ben si evince dalla stessa storia umana. Diminuendo progressivamente la componente “competitiva”, l’ambizione personale, la ricerca del difficile fine a sé stesso, ho scoperto la dimensione e il valore del “viaggio” come stimolo naturale alla ricerca del nuovo e come possibilità di relazionarmi con ciò che era diverso dalla mia normalità. All’inizio, non lo nego, anch’io identificai nella vetta una sorta di “fine supremo” quasi scontato dell’alpinismo, ove concentrare il sentimento del mio agire. Poi, nel corso degli anni, compresi che il momento culminante del mio salire una montagna non era ciò che provavo una volta raggiunta una cima ma quell’insieme di sensazioni vissute durante il viaggio-scalata. E’ questo il vero spirito “odisseico” che io trovo risiedere nell’alpinismo, dove il significato del viaggio è soprattutto nel suo percorso e non può esaurirsi nell’approdo al “porto finale”. Il fascino del viaggio necessario per raggiungere una meta, così concepita, senza esclusiva di sorta, sta nel fatto che si accetta che la meta possa essere vanamente inseguita, oppure materializzarsi all’improvviso sotto una veste diversa dagli obiettivi che c’eravamo posti. Il fallimento, allora, non esisterà neppure come mancanza di una meta prefissata, poiché conterà soprattutto la natura esperienziale del Nel valore metaforico del viaggio odisseico, la montagna sostituisce il mare costituendo quella dimensione incontrollabile dove il “naufragio” è sempre possibile. Ecco allora che incognita, rischio, incertezza della riuscita, diventano elementi insostituibili di ciò che, ragionevolmente, a questo punto si può definire il “sentimento della meta”. Sarebbe però sbagliato ritenere che il “sentimento della meta” si ponga in antitesi al “sentimento della vetta” teorizzato dall’amico e maestro Spiro Dalla Porta Xydias. Al contrario, esso lo comprende e semmai lo nobilita, giacché sarà sempre preponderante e centrale il significato del viaggio, al di là dell’obbiettivo fisico raggiunto. Ciascuno sarà libero di attribuire un significato mitico simbolico oppure religioso alla vetta, così come a un colle o alla sommità di una parete, senza per questo decentralizzare il valore “spirituale” del viaggio. L’idea di Ulisse come “eroe” non deve peraltro trarre in inganno né avvalorare le tesi di coloro che, in ambito alpinistico, hanno mistificato, generalizzandola, la figura dell’“eroe”, tratteggiando l’“eroismo” addirittura come un disvalore. Tòpos dell’“eroe Ulisse” è, infatti, la conoscenza interiore e non la meta prefissata. Essa si concretizza durante il viaggio con il superamento degli ostacoli e delle avversità, attraverso un connubio tra azione e contemplazione. Egli è assai più vicino all’eroe del romanticismo ottimista di prevalente invenzione letteraria piuttosto che all’oltre-uomo d’annunziano-nietzcheiano. Se s’intende la scalata o l’ascesa alpinistica anche come una ricerca interiore, avvalorando la tesi del valore “spirituale” del viaggio, non è possibile prescindere dal connubio azione-contemplazione. Se si escludesse l’azione e si compisse il viaggio, per esempio in funivia, potremmo certamente “contemplare” ma non per questo avremmo fatto dell’alpinismo. Viceversa, se prevalesse esclusivamente l’azione saremmo nell’ordine di un’attività meramente tecnicistica. Potremmo allora addirittura eliminare la montagna o la parete quale valore simbolico del “viaggio” e sostituirlo con una realtà artificiale.
esclusivamente di ordine materiale. Sfido chiunque, infatti, a dimostrare che quest’ultimo possa essere considerato come totalmente appagante, come del resto ben si evince dalla stessa storia umana. Diminuendo progressivamente la componente “competitiva”, l’ambizione personale, la ricerca del difficile fine a sé stesso, ho scoperto la dimensione e il valore del “viaggio” come stimolo naturale alla ricerca del nuovo e come possibilità di relazionarmi con ciò che era diverso dalla mia normalità. All’inizio, non lo nego, anch’io identificai nella vetta una sorta di “fine supremo” quasi scontato dell’alpinismo, ove concentrare il sentimento del mio agire. Poi, nel corso degli anni, compresi che il momento culminante del mio salire una montagna non era ciò che provavo una volta raggiunta una cima ma quell’insieme di sensazioni vissute durante il viaggio-scalata. E’ questo il vero spirito “odisseico” che io trovo risiedere nell’alpinismo, dove il significato del viaggio è soprattutto nel suo percorso e non può esaurirsi nell’approdo al “porto finale”. Il fascino del viaggio necessario per raggiungere una meta, così concepita, senza esclusiva di sorta, sta nel fatto che si accetta che la meta possa essere vanamente inseguita, oppure materializzarsi all’improvviso sotto una veste diversa dagli obiettivi che c’eravamo posti. Il fallimento, allora, non esisterà neppure come mancanza di una meta prefissata, poiché conterà soprattutto la natura esperienziale del Nel valore metaforico del viaggio odisseico, la montagna sostituisce il mare costituendo quella dimensione incontrollabile dove il “naufragio” è sempre possibile. Ecco allora che incognita, rischio, incertezza della riuscita, diventano elementi insostituibili di ciò che, ragionevolmente, a questo punto si può definire il “sentimento della meta”. Sarebbe però sbagliato ritenere che il “sentimento della meta” si ponga in antitesi al “sentimento della vetta” teorizzato dall’amico e maestro Spiro Dalla Porta Xydias. Al contrario, esso lo comprende e semmai lo nobilita, giacché sarà sempre preponderante e centrale il significato del viaggio, al di là dell’obbiettivo fisico raggiunto. Ciascuno sarà libero di attribuire un significato mitico simbolico oppure religioso alla vetta, così come a un colle o alla sommità di una parete, senza per questo decentralizzare il valore “spirituale” del viaggio. L’idea di Ulisse come “eroe” non deve peraltro trarre in inganno né avvalorare le tesi di coloro che, in ambito alpinistico, hanno mistificato, generalizzandola, la figura dell’“eroe”, tratteggiando l’“eroismo” addirittura come un disvalore. Tòpos dell’“eroe Ulisse” è, infatti, la conoscenza interiore e non la meta prefissata. Essa si concretizza durante il viaggio con il superamento degli ostacoli e delle avversità, attraverso un connubio tra azione e contemplazione. Egli è assai più vicino all’eroe del romanticismo ottimista di prevalente invenzione letteraria piuttosto che all’oltre-uomo d’annunziano-nietzcheiano. Se s’intende la scalata o l’ascesa alpinistica anche come una ricerca interiore, avvalorando la tesi del valore “spirituale” del viaggio, non è possibile prescindere dal connubio azione-contemplazione. Se si escludesse l’azione e si compisse il viaggio, per esempio in funivia, potremmo certamente “contemplare” ma non per questo avremmo fatto dell’alpinismo. Viceversa, se prevalesse esclusivamente l’azione saremmo nell’ordine di un’attività meramente tecnicistica. Potremmo allora addirittura eliminare la montagna o la parete quale valore simbolico del “viaggio” e sostituirlo con una realtà artificiale.  Fatto questo, per esempio, che già accade nella ben nota arrampicata sportiva agonistica, praticata su strutture modulari e su prese di resina e in cui lo scopo è la gara superando una difficoltà a rischio azzerato. E’ importante rimarcare come questa disciplina dai connotati e dalle regole ben precise – che non intende per nulla sostituirsi all’arrampicata su roccia naturale – sia comunque figlia di quest’ultima e di un’evoluzione che ha messo in primo piano il superamento del grado riducendo la componente psicologico-emotiva. Si ha quindi il primato dell’azione sulla contemplazione, esaltando una concezione “sportiva” della scalata, dischiudendo le porte a fenomeni molteplici che nel tempo hanno connotato e influenzato l’alpinismo stesso. Tre questi il cosiddetto “fenomeno plaisir” che risponde alla rivendicazione di quella che potremmo definire una certa “democrazia del rischio” che, attraverso il massiccio intervento tecnicistico, rivendica l’adattamento della montagna (parete) alle capacità dell’individuo e non viceversa. Certo, in una siffatta condizione vi è anche lo spazio per la “contemplazione” ma la mitigazione del rischio, l’eliminazione dell’incognita e dell’incertezza della riuscita determina una dimensione corrotta del “viaggio”, assai diversa e distante da quello che finora abbiamo inteso per “sentimento della meta”. Allo stesso modo, l’alpinismo dei primati, dei record, delle corse forsennate sul filo dei minuti e dei secondi, pur conservando elementi di rischio e d’incertezza, sacrifica il valore contemplativo-spirituale del viaggio verso la meta. Tra il 1981 e il 1983, mentre il fenomeno nostrano del free-climbing degenerava verso la sportivizzazione della scalata, io fui testimone diretto delle cosiddette “Antiche Sere”. Così fu chiamato da Gian Piero Motti quell’ultimo periodo della sua vita, speculare e in qualche modo chiarificatore del precedente “Nuovo Mattino”, fenomeno, quest’ultimo, del tutto travisato o totalmente confuso da mistificatori senza scrupoli. Il “Nuovo Mattino” nell’idea primigenia e pura prevedeva un distacco temporaneo dalla vetta e dalla grande montagna, necessario per estendere la dimensione spirituale anche alle semplici pareti, dimostrando l’esistenza di
Fatto questo, per esempio, che già accade nella ben nota arrampicata sportiva agonistica, praticata su strutture modulari e su prese di resina e in cui lo scopo è la gara superando una difficoltà a rischio azzerato. E’ importante rimarcare come questa disciplina dai connotati e dalle regole ben precise – che non intende per nulla sostituirsi all’arrampicata su roccia naturale – sia comunque figlia di quest’ultima e di un’evoluzione che ha messo in primo piano il superamento del grado riducendo la componente psicologico-emotiva. Si ha quindi il primato dell’azione sulla contemplazione, esaltando una concezione “sportiva” della scalata, dischiudendo le porte a fenomeni molteplici che nel tempo hanno connotato e influenzato l’alpinismo stesso. Tre questi il cosiddetto “fenomeno plaisir” che risponde alla rivendicazione di quella che potremmo definire una certa “democrazia del rischio” che, attraverso il massiccio intervento tecnicistico, rivendica l’adattamento della montagna (parete) alle capacità dell’individuo e non viceversa. Certo, in una siffatta condizione vi è anche lo spazio per la “contemplazione” ma la mitigazione del rischio, l’eliminazione dell’incognita e dell’incertezza della riuscita determina una dimensione corrotta del “viaggio”, assai diversa e distante da quello che finora abbiamo inteso per “sentimento della meta”. Allo stesso modo, l’alpinismo dei primati, dei record, delle corse forsennate sul filo dei minuti e dei secondi, pur conservando elementi di rischio e d’incertezza, sacrifica il valore contemplativo-spirituale del viaggio verso la meta. Tra il 1981 e il 1983, mentre il fenomeno nostrano del free-climbing degenerava verso la sportivizzazione della scalata, io fui testimone diretto delle cosiddette “Antiche Sere”. Così fu chiamato da Gian Piero Motti quell’ultimo periodo della sua vita, speculare e in qualche modo chiarificatore del precedente “Nuovo Mattino”, fenomeno, quest’ultimo, del tutto travisato o totalmente confuso da mistificatori senza scrupoli. Il “Nuovo Mattino” nell’idea primigenia e pura prevedeva un distacco temporaneo dalla vetta e dalla grande montagna, necessario per estendere la dimensione spirituale anche alle semplici pareti, dimostrando l’esistenza di  un “sentimento della meta” e al contempo umanizzando un po’ l’alpinismo appesantito da una vuota retorica che ne aveva affossata addirittura l’epica iniziale. Questo viaggio, come indica metaforicamente l’apertura della via “Itaca nel sole” alla parete del Caporal, avrebbe dovuto infine ricondurre alla “grande montagna”, cioè al porto da cui si era salpati, forti di un’esperienza e di uno spirito nuovo. Ci fu però chi non comprese o meglio, non volle comprendere. Ormai giunti alle porte della nascita delle gare d’arrampicata e al crepuscolo del free-climbing inteso come esperienza di ricerca interiore, le “Antiche Sere” proposero una nuova dimensione visionaria, simbolica e introspettiva della scalata. Nell’invenzione di quelle atmosfere crepuscolari, Motti fece ricorso a tutti gli ingredienti degni di un’esperienza romantica, con contaminazioni che vanno dalla prosa dissacrante dell’omonimo romanzo di Mailer (pubblicato proprio nel 1983) all’idealismo magico di Novalis. Ed è qui che Motti priva se stesso dell’azione che era stato elemento fondamentale nel periodo del “Nuovo Mattino”. Egli, al contrario, pone al centro esclusivamente la contemplazione – dell’“irraggiungibile” dirà qualcuno. Non sarà lui, infatti, ad arrampicare su quelle nuove pareti quasi salvifiche in un momento di deriva e mistificazione. Da quell’estate del 1983, spetterà ad alcuni di noi salpare nuovamente, novelli “Argonauti” impegnati in un viaggio il cui significato risiede soprattutto in quella magnifica dimensione spirituale che io amo definire il “sentimento della meta”.
un “sentimento della meta” e al contempo umanizzando un po’ l’alpinismo appesantito da una vuota retorica che ne aveva affossata addirittura l’epica iniziale. Questo viaggio, come indica metaforicamente l’apertura della via “Itaca nel sole” alla parete del Caporal, avrebbe dovuto infine ricondurre alla “grande montagna”, cioè al porto da cui si era salpati, forti di un’esperienza e di uno spirito nuovo. Ci fu però chi non comprese o meglio, non volle comprendere. Ormai giunti alle porte della nascita delle gare d’arrampicata e al crepuscolo del free-climbing inteso come esperienza di ricerca interiore, le “Antiche Sere” proposero una nuova dimensione visionaria, simbolica e introspettiva della scalata. Nell’invenzione di quelle atmosfere crepuscolari, Motti fece ricorso a tutti gli ingredienti degni di un’esperienza romantica, con contaminazioni che vanno dalla prosa dissacrante dell’omonimo romanzo di Mailer (pubblicato proprio nel 1983) all’idealismo magico di Novalis. Ed è qui che Motti priva se stesso dell’azione che era stato elemento fondamentale nel periodo del “Nuovo Mattino”. Egli, al contrario, pone al centro esclusivamente la contemplazione – dell’“irraggiungibile” dirà qualcuno. Non sarà lui, infatti, ad arrampicare su quelle nuove pareti quasi salvifiche in un momento di deriva e mistificazione. Da quell’estate del 1983, spetterà ad alcuni di noi salpare nuovamente, novelli “Argonauti” impegnati in un viaggio il cui significato risiede soprattutto in quella magnifica dimensione spirituale che io amo definire il “sentimento della meta”.