Quando si parla di rischio in alpinismo si va spesso incontro a una serie di facili fraintendimenti.
Il rischiare in montagna è visto dalla totalità dell’opinione pubblica e da una parte stessa degli appassionati di montagna, come una follia egoista inutile, un sintomo d’irragionevole disprezzo per la vita. Ora, se s’accetta che l’imprudenza il più delle volte è riconducibile all’incompetenza e all’impreparazione, non va però confusa con la volontà di “osare”, sacrosanta e legittima, di un alpinista. Se non si osa certo non si rischia, ma se non si “rischia” ci si allontana da quell’elemento d’incognito, d’incertezza della riuscita e di “visione”, che caratterizza l’azione e l’avventura nel mondo verticale. Vi è chi vorrebbe a tutti i costi una montagna sicura, adattandola il più possibile alle capacità medie dell’alpinista, riducendo i pericoli il più possibile con decine di chiodi, di catene, magari con migliaia di bollini di vernice lungo le vie di salita e, ultimamente, addirittura con divieti di accesso e sanzioni. Vi è cioè chi pretende, in nome di un fantomatico bene collettivo (frutto d’una società che ha diffuso caduchi modelli di benessere), d’impedire quella libertà d’espressione e d’azione che da sempre caratterizza l’alpinismo. E si badi bene che non si tratta affatto d’inneggiare alla “bella morte”, memori di un qualche strascico ideologico impastato di retorica tardo – romantica, quanto piuttosto d’affermare il principio dell’autoconsapevolezza. E’ questo un valore che va diffuso attraverso un corretto approccio culturale alla sicurezza, e non soffocato da logiche omologanti e liberticide.
Il rischio è dunque un diritto in alpinismo, come lo è quello di scegliere la propria vita e la propria condotta morale. S’accetti quindi il confronto con le difficoltà che la montagna o la scalata oppone basandosi sulla coscienza delle proprie reali possibilità, senza che s’intervenga ad addomesticare pesantemente il terreno di gioco con illusori stratagemmi tecnologici o, peggio ancora, vietando e imponendo regole al libero andare per monti. Alpinismo è libertà. Si coltivi e si preservi sempre una cultura che faccia riferimento alla componente più ideale e creativa dell’alpinismo, in cui la facilitazione forzata sia considerata un disvalore. In decenni di omologazione, di appiattimento e di banalizzazione della montagna, risiede l’origine stessa dell’equivoco odierno.
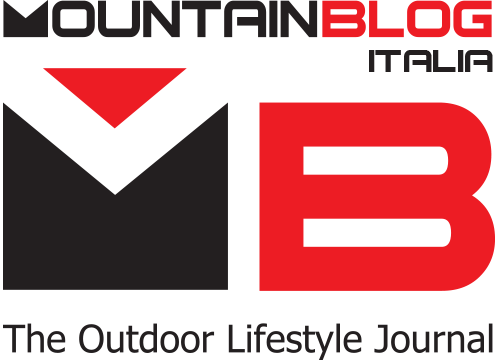




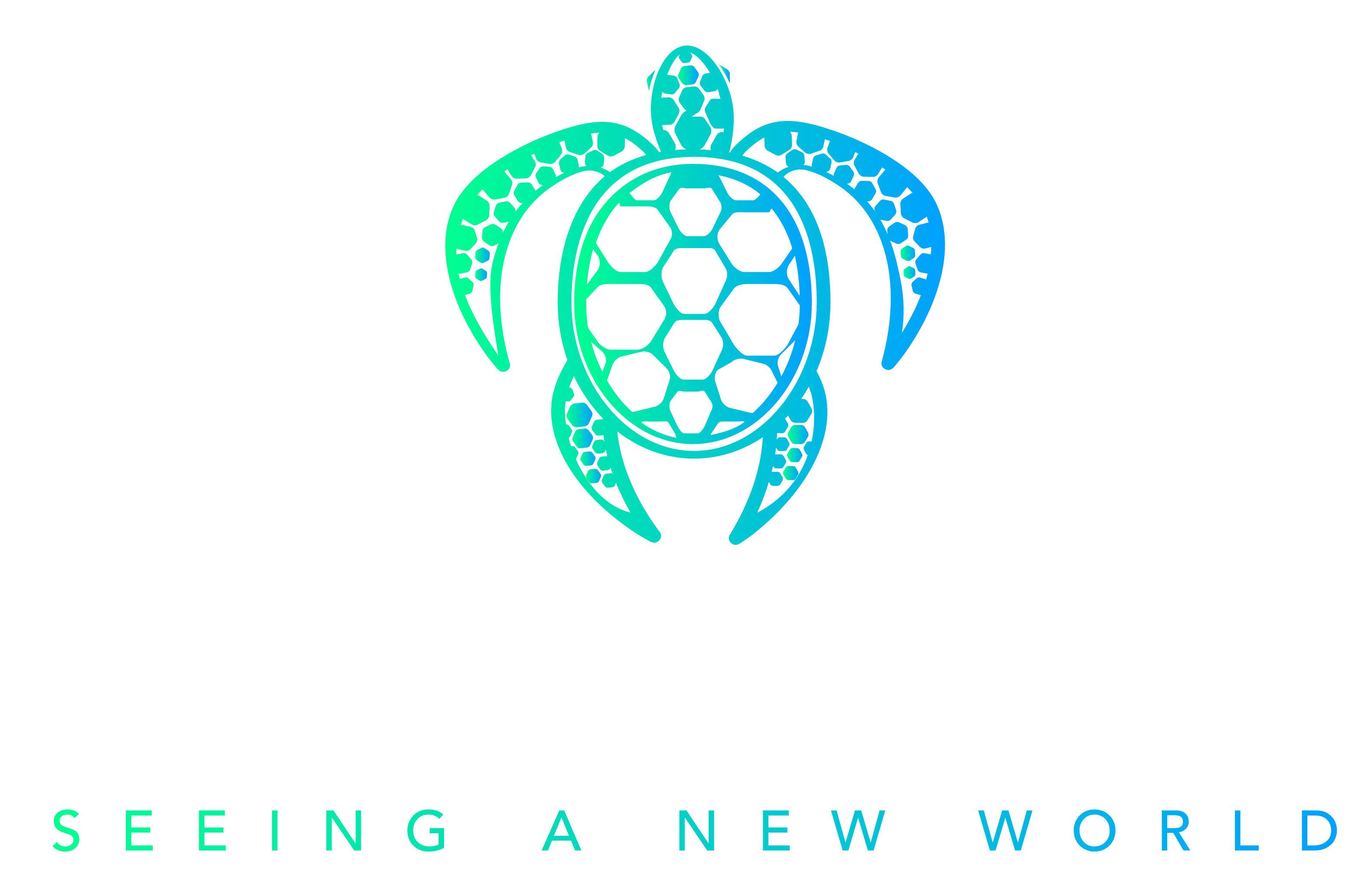










































Bellissimo post che condivido in pieno.
Abbiamo bisogno di alpinisti come te che contribuiscano a diffondere quella cultura della “libertà” (metto le virgolette a questa parola perché non è di certo quella che è usata – diciamo pure abusata – da certi politicanti per infinocchiare l’elettorato..) che chi ama in modo autentico e genuino il “luogo” montagna sa far germogliare nella propria anima.
Grazie.
Ciao Marco…..sacrosanto e legittimo. Arrampicare non deve essere una sola prova di capacità tecnico fisica, deve essere la capacita’ della nostra essenza, della nostra anima, ad adattarsi alle situazioni che la montagna e la roccia ci propone e ci impone. Le protezioni sono d’obbligo, ogni sport ha “diritto” al suo livello di sicurezza minimo, la montagna non esige incidenti ma gente che della montagna vive la natura con rispetto paura e armonia. L’arrampicata non e’ salire ma esserci.
Ciao Daniele, l’arrampicata sportiva, che è uno sport per definizione, ha diritto alla sua sicurezza massima, mutuata dallo spit. Lo scopo è in questo caso superare la difficoltà senza influenze pesanti della componenete emotiva. Su altri terreni, cioè non “sportivi”, credo che lo spit non sia affatto un diritto. A mio avviso la sicurezza non passa necessariamente da una protezione fissa, ma deve dipendere dalla capacità di scelta, dalla consapevolezza dei nostri limiti, dalla capacità di adattare mezzi più legittimi ed idonei a quel tipo di terreno. Superare un passaggio difficile o una via, non è per nulla un diritto, ma semmai il frutto di una maturazione. Molti oggi vorrebbero comode calate al termine di certe vie in montagna per evitare “torture alle ginocchia” e lunghi rientri. Le vorrebbero ancor di più certi rifugisti, che vedono nello spit e nell’adattamento della montagna allo scalatore una maggior possibilità di ripetizioni e quindi di passaggi. Il sacrosanto diritto alla “sicurezza” lo rivendicano coloro che possono scalare solo il fine settimana e che magari hanno famiglia.
Ma è giusto tutto ciò e, soprattutto, è l’unica strada? Io credo di no. Penso che, semplicemente, dovremmo iniziare a cambiare il nostro punto di vista e praticare dell’alpinismo e dell’arrampicata (su certi terreni), scegliendo delle vie che sappiamo davvero fare e non auspicare la posa “istituzionale” di uno o più aiuti psicologici. Il discorso è complesso e delicato, e spesso può sembrare di cadere in contraddizione se ci guardiamo alle spalle. Ma se abbiamo il coraggio di fare anche solo un passo indietro, lasceremo alle generazioni future una montagna più libera, non omologata, rinunciando un pochino a quella tecnologia che già pesantemente oggi influisce nel nostro modo di rapportarci con la “sfida”.
Un caro saluto