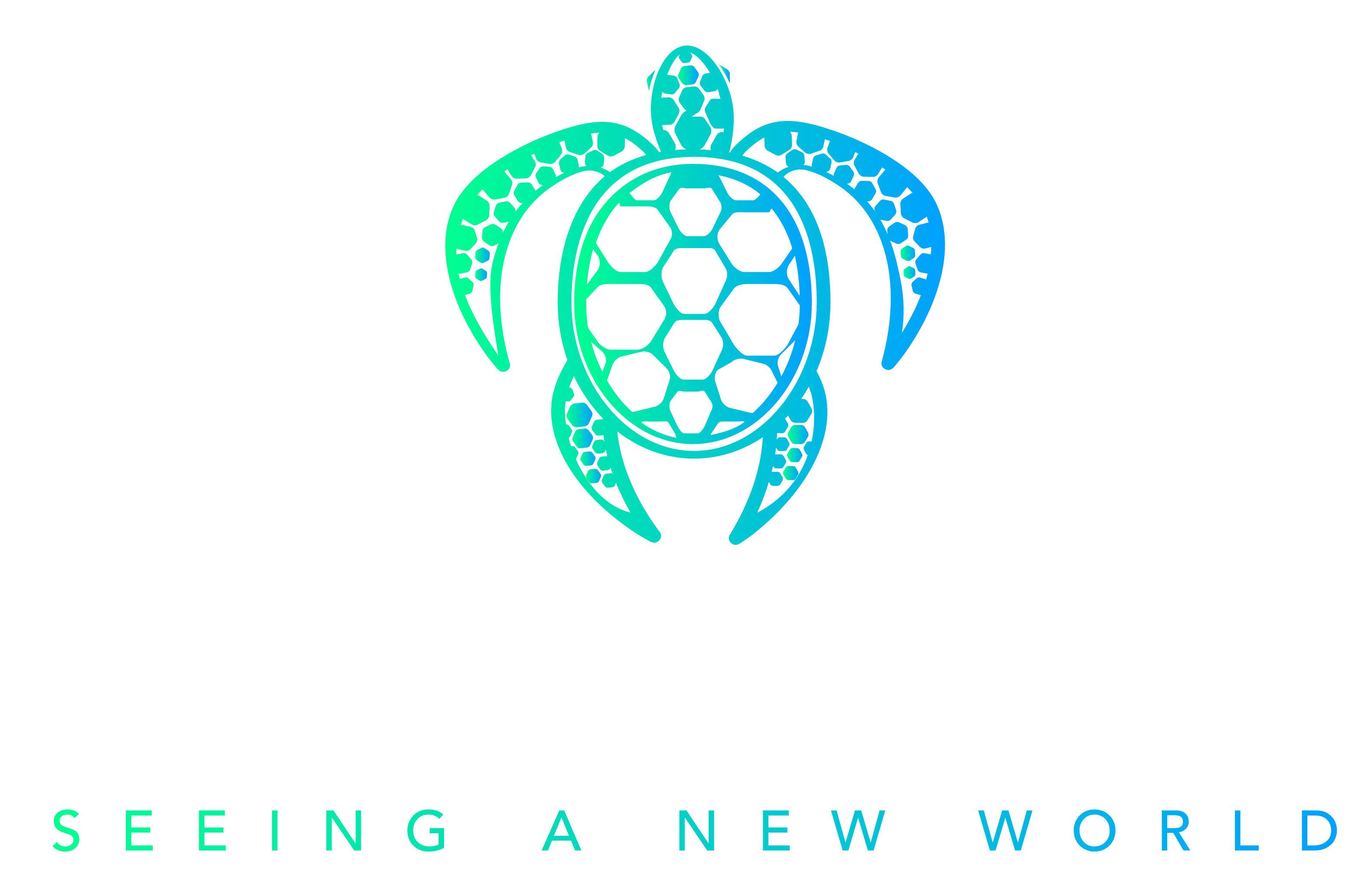Oggi viviamo una fase epocale dove valori, fede, ideali, speranze e sogni sono venuti meno. È come l’uomo avesse perso il suo coraggio, la sua forza per esplorare, per dare senso al suo cammino, a quel breve passaggio che è la nostra presenza sulla terra. Così, quando ti trovi di fronte a uomini come Armando Aste, che hanno fatto della propria fede una ragione di vita, come minimo ti trovi spiazzato, per non dire in preda ad un senso di stupore ed ammirazione, se non invidia.
Lui che ancora oggi recita ogni giorno il rosario, come d’altronde ha sempre fatto anche quando si trovava a dividere i bivacchi con altri, potrebbe essere deriso, snobbato da chi intende l’uomo forte come l’impavido che non si ferma di fronte a niente, che non cede al pianto o al sentimentalismo. Ma proprio la fede, questa ragion d’essere, molto probabilmente gli ha dato la forza, l’ha guidato e preservato in tutta la sua vicenda alpinistica.

Accademico e Socio Onorario del C.A.I., Armando è entrato a diritto nella storia dell’alpinismo italiano. La prima ascensione italiana alla nord dell’Eiger, prima solitaria della via Couzy sulla parete nord della Cima Ovest di Lavaredo, prima solitaria della via Brandler-Hasse sulla Parete Rossa della Roda di Vael nel Catinaccio, prima ascensione invernale della via Carlesso-Sandri sulla parete Sud della Torre Trieste, via dell’Ideale sulla parete Sud della Marmolada, via della Canna d’Organo, sempre in Marmolada, via nuova alla parete nord-ovest della Punta Civetta, la via della Concordia alla Cima d’Ambièz, il Gran Diedro sulla parete nord del Crozzon di Brenta, la prima alla Torre Sud del Paine, sono solo alcune delle sue imprese.
Ma non è questo un motivo di vanto, almeno non per lui.
Una visita a casa sua di un paio di anni fa mi fece riflettere sulla sua figura: un alpinista importante, rimasto solo, giunto al capolinea della sua vita. Come si prepara ad affrontare il grande viaggio? La maggior parte di noi, e in specie gli alpinisti, finché il fisico ci sorregge, non vede limiti, tutto ci sembra possibile, la forza, l’ardire e il coraggio sembrano nostri alleati che non ci abbandoneranno mai. È per questo che si esorcizza la vecchiaia, la malattia, la morte, quel giorno in cui gioco-forza si dovrà

smettere di fare quel che si è sempre fatto e si pensava non finisse mai. Cosa succederà allora, quando si tornerà a vestire i panni di uomini come tutti gli altri, con un corpo che lentamente, ma inesorabilmente decade? Quanto coraggio ci vuole per affrontare con serenità questa avventura? Basterà aver scalato tutti gli ottomila e superato le pareti più difficili del mondo per riuscire a trovare ancora riserve di forza e speranza? Di fronte a questi quesiti l’uomo-alpinista rimane appeso all’appiglio, continua imperterrito la sua scalata verso il cielo, finge di non vedere e sentire, s’aggrappa alla roccia, s’allena e si sforza a credere che mai gli sarà preclusa la via. L’alpinista, l’arrampicatore è un uomo con i piedi in aria ed è quando che tocca il suolo che iniziano i suoi problemi con la quotidianità.
È per questo motivo che, al di là dell’amicizia che mi lega ad Armando, ho voluto cercare di scavare nella sua vita per vedere se ne esce, se non dei buoni consigli, almeno dei spunti di riflessione per coloro che, più giovani, pensano che non arriverà mai il giorno con il quale dovranno fare i conti con se stessi e la caducità del corpo.
Dal 2009 Armando vive solo: prima è morto suo fratello, che ha assistito per 23 anni, e poi la moglie Neda. In realtà lui non si sente mai solo, c’è Dio a fargli compagnia, e un gatto, pure lui rimasto senza compagna da poco, e i merli che giungono sul poggiolo a becchettare le briciole di pane. La sua casa, immersa in un sobborgo popolare di Rovereto, è come una stanza minimalista: tutto è ridotto all’essenziale; il superfluo per uno che si prepara a ricongiungersi ai propri cari è solo un peso.

Capelli bianchi e folti pettinati a spazzola, una serenità negli occhi, il fisico un po’ appesantito, un maglione liso. Armando si fa bastare la pensione e qualche volta, anche per stare in compagnia, va a mangiare in un centro anziani. Una donna delle pulizie lo aiuta nei mestieri più faticosi, per il resto si arrangia, nonostante il medico gli abbia consigliato riposo. Nonostante i molti problemi di salute sorride ancora, tutti i giorni prega e fa un giro al cimitero.
Il più vecchio di sei fratelli, costretto a lavorare per aiutare la famiglia, per 36 anni Armando ha fatto il fuochista, il conduttore di caldaie a carbone presso la Manifatturiere Tabacchi. Seduti uno di fronte l’altro l’operaio roveretano si racconta rispondendo alle mie domande.
Com’è nata la passione per la montagna?
Sono stato allevato da mio nonno mugnaio, vivevo in un maso della Val Cavazzino, la “Val dei molini”, le montagne le vedevo dal basso, poi crescendo sono sempre andato a fare passeggiate, ma un giorno un forte alpinista delle mie parti mi invitò a vedere la Guglia di Castelcorno, mi colpì molto e un po’ di anni dopo, forte della mia preparazione atletica e fisica, facevo ginnastica, la salii senza corda e in solitaria. Fu così che i ragazzi di Rovereto che arrampicavano su quella guglia mi invitarono ad unirmi a loro che poi nel ’48 formarono il Gruppo Roccia Ezio Polo.

Quando hai capito che l’alpinismo era la tua strada?
Quando con uno dei più giovani di questi ragazzi sono andato a fare la via del Pilastro al Baffelan, la mia prima via, e poco dopo la terza ripetizione della via Preuss alla Est del Campanile Basso.
La fede l’hai ereditata dai tuoi genitori o è nata dall’interno?
Prima me l’hanno trasmessa loro con gli insegnamenti e gli esempi, poi l’ho fatta mia facendola crescere dall’interno. Quando avevo 16 anni e facevo il portiere d’albergo c’è stato però un momento che, vedendo tutte quelle donne e prostitute che entravano ed uscivano, a volte provocandomi, sono stato tentato e rischiavo di cedere, ma ho avuto un angelo custode che mi ha salvato. Poi è stato il Vangelo, l’esempio di Cristo il mio modello.
Quanto ti è stato utile l’alpinismo per affrontare le difficoltà della quotidianità?
Mi ha aiutato a crescere e conoscermi, ad accettare tutti i problemi della vita e renderla più bella. Quand’ero giovane anch’io ero ambizioso e volevo essere più bravo degli altri; le imprese di Preuss o Comici mi affascinavano, poi ho capito che sopra i monti c’è il cielo, la vetta più importante da raggiungere. Ma per me le cose che hanno contato di più sono state la carità, l’amore, la famiglia e l’amicizia.
Quanto importante è stata per te?
Fondamentale. Mi ha spinto quando potevo andare e frenato quando avrei rischiato troppo. Mi ha insegnato a rispettare i confini, a non andare oltre un certo limite, ad avere prudenza. Ogni volta che mi apprestavo ad aprire una via, avevo la consapevolezza di potercela fare, una sorta di benedizione.

Cosa cercavi in montagna?
La bellezza, perché vedo l’alpinismo come la sintesi della bellezza, dell’intuizione e del gesto atletico che traduce concretamente il pensiero e l’azione. C’era poi la rincorsa alla felicità che poi scemava una volta terminata la via. Gli alpinisti forse non se ne rendono conto, ma in quell’andare in alto, cercando di andare oltre, diventano leggeri, spiccano il volo, ripetono il gesto di Icaro.
Tra le tue vie qual è che ritieni più bella e perché?
Sono tutte belle. Ogni volta che aprivo una via quella era la più bella. Poi se vogliamo, forse la via dell’Ideale è quella che ricordo con più piacere; per l’ambiente, per l’interesse storico, per la roccia ed altri motivi. Ma la più bella forse è stata la prima che ho aperto nel ’53 alla Est della Cima Sud di Pratofiorito, una via di 400 metri, dove ho fatto anche il mio primo bivacco.
E quella più dura?
Forse quella della Madonna Assunta al Piz Serauta; c’è un passaggio tremendo dove Bruno De Donà durante la ripetizione è volato quattro volte prima di riuscire a superarlo.
Tra gli oltre duecento bivacchi ce n’è uno che ti ricordi in modo particolare?
Come ogni via, ognuno è una storia a sé. Ne ricordo uno con Franco Solina e Cesarino Fava. Eravamo nel Gruppo delle Torri del Paine, nella forcella che separa questa dall’Escudo, volevamo salire la Fortaleza del Paine. Abbiamo fatto il bivacco lì e la mattina dopo, mentre facevamo le corde doppie per scendere, visto che il tempo sembrava volgere al meglio, siamo tornati alla forcella dove abbiamo di nuovo bivaccato e una nevicata ci ha costretto a rimanere lì in truna per altri tre giorni.

C’è stato un compagno di cordata con il quale ti sei trovato meglio?
Tutti. Erano gli altri che mi cercavano per legarsi con me. Mi sono tutti capitati, forse mandati dalla provvidenza perché con ognuno ho avuto un ottimo rapporto e siamo diventati amici. Ma se proprio vogliamo parlare da un punto di vista alpinistico e tecnico, quello con il quale ho condiviso le vie più belle è stato Franco Solina. Lui compensava tutte le qualità che io non avevo.
Il momento più bello che hai vissuto in montagna?
Il ricordo più bello che ho è della prima spedizione in Patagonia assieme al Cai di Monza che mi accolse come uno di loro. Siamo stati via 4 mesi e abbiamo salito la Torre Sud e ripetuto la via alla Torre Centrale. Ma non posso non citare anche la Via della Concordia alla Cima d’Ambièz. Io ero con il Miorandi e in rifugio, con lo stesso intento c’erano Oggioni ed Aiazzi, invece di litigare perché loro erano arrivati prima, unimmo le forze e con due cordate distinte, a comando alternato, aprimmo la via che sancì anche la nostra amicizia.
Un’incompiuta?
La Ovest della Busazza, quella che poi ha realizzato Renato Casarotto. Lì ho fatto otto bivacchi, in vari tentativi, e giunto a due tiri dalla cima sono tornato indietro impressionato dalla grande friabilità della roccia.
E Casarotto alpinista?
Della sua epoca il più forte di tutti, anche di Bonatti, ma doveva fermarsi in tempo, si è spinto troppo in là ed era inevitabile che prima o poi finisse com’è finita. Il suo sbaglio più grande è stato quello di vivere solo per la montagna. Bisogna avere il senso della misura. In montagna non sono mai arrivato al mio limite; ho sempre avuto un margine di sicurezza per preservare il dono della vita.
Dopo di te c’è stato qualcuno che ha seguito il tuo modo di praticare l’alpinismo?
Direi Ivo Rabanser, ma ancor più Elio Orlandi, un grande! Ha fatto delle cose in montagna di assoluto valore, ma è anche un artista, regista, persona sensibile e con una grande umanità e rispetto.
Con Cesare Maestri ti senti ancora?
Sì, spesso. Credo di essere uno dei pochi amici che gli sono rimasti. Anche se per alcuni punti di vista siamo diametralmente opposti, ci sentiamo molto legati. Abbiamo stima ed ammirazione reciproca e per me lui è stato uno stimolo in montagna, soprattutto per la sua determinazione. Allora eravamo visti come antagonisti, ognuno arrampicava per conto suo perché avevamo una buona dose di ambizione: nessuno di noi avrebbe fatto da secondo all’altro. A parte questo Cesare lo sento come un fratello, gli voglio bene perché ha un cuore grande, è un generoso.

Come vedi l’alpinismo oggi? L’approccio e il modo di praticarlo sono cambiati?
Io appartengo ad un’epoca che è seguita a gente come Cassin, Soldà, Carlesso. Sai l’alpinismo è in continua evoluzione, ma bisogna vedere se anche l’etica è migliorata. Avrei dei dubbi. Gli arrampicatori di oggi sono fortissimi, ma non hanno una cultura dell’alpinismo e della montagna. Forse manca la condivisione, la solidarietà, il senso della rinuncia. I giovani di oggi sono figli di questo tempo: guardano al concreto, fanno la via, ma non cercano qualcos’altro di intrinseco, dei valori, altri significati, non cercano di andare al di là della parete, della roccia.
Hai avuto maestri in montagna?
No perché sono stato un autodidatta, ma maestri ideali sì: Marino Stenico, Pino Fox e Armando Biancardi che mi ha insegnato anche la scrittura.
Te la sentiresti di dare un consiglio ai giovani che frequentano la montagna?
Nel libro autobiografico “Pilastri del cielo” c’è il messaggio che ho voluto lasciare. Direi poi che uno deve fare ciò che vuole, in montagna come nella vita, ma prima dell’alpinismo ci sono molte altre cose. Non si può vivere solo per la montagna, ma anche per gli altri: rinunciare al proprio orgoglioso piacere egoistico è più importante.
Quest’anno si festeggiano i 150 anni della fondazione del Club Alpino Italiano. C’è qualcosa che vorresti venisse ricordato di questa lunga storia?
La storia dell’alpinismo, prima della retorica delle parole, è stata scritta dai fatti, dalle cose concrete. E se c’è un valore, un ideale da perseguire, è quello di andare oltre, di fare sempre un passo avanti: sia da un punto di vista tecnico, morale e spirituale. Quello che in montagna non potrà mai essere scalfito è il perché si va, quello è dentro ognuno di noi, è una spinta e una ricerca che non ha un unico comune denominatore.
Armando oggi è un uomo che vive con consapevolezza e serenità d’animo l’ultima fase della sua vita con i ricordi e le amicizie: è all’attacco di una nuova via, pronto a salire in alto. Un uomo, che ha compreso benissimo come la forza più grande non sia quella di compiere imprese eccezionali, bensì quella di stare al proprio posto con dignità, con coraggio ma soprattutto con amore. È per questo che le sue parole risuonano con una carica emotiva non indifferente.
Mentre sto salendo in macchina esce e dal poggiolo mi grida «Non ti ho ringraziato per tutto quello che mi hai portato…»
«Non ce n’era bisogno: me l’hai detto tu che dare è più bello che ricevere!»
È il giorno del nuovo papa Francesco.
Vittorino Mason
Tags: 150 anni del CAI, action, Alpinismo e Spedizioni, Armando Aste, Armando Biancardi, Campanile Basso, Catinaccio, Cesare Maestri, Cesarino Fava, Cima d'Ambiez, Cima Ovest di Lavaredo, Crozzon di Brenta, Eiger, Elio Orlandi, fede, Franco Solina, Interviste, Marino Stenico, Marmolada, montagna, Pino Fox, Punta Civetta, Renato Casarotto, Riccardo Cassin, Torre del Paine, Torre Trieste, Vittorino Mason, Walter Bonatti
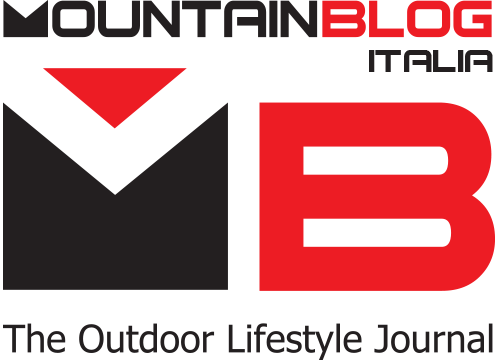
 Action
Action