 Gli infausti eventi di quest’inverno balordo portano alla mente un fatto che mi capitò anni orsono e che poteva finire in malo modo. Lo racconto per spezzare una lancia a favore degli sci alpinisti, una categoria che, mai come in questo periodo, è stata considerata dalla stampa ignorante (nel senso che ignora la realtà mentre è prodiga di sentenze) come una banda di egoisti a caccia di suicidi. Nulla di più sbagliato.
Gli infausti eventi di quest’inverno balordo portano alla mente un fatto che mi capitò anni orsono e che poteva finire in malo modo. Lo racconto per spezzare una lancia a favore degli sci alpinisti, una categoria che, mai come in questo periodo, è stata considerata dalla stampa ignorante (nel senso che ignora la realtà mentre è prodiga di sentenze) come una banda di egoisti a caccia di suicidi. Nulla di più sbagliato.
Ci sono, è vero, delle persone che girano con la testa per aria, ma la maggior parte di chi fa sci alpinismo (intendo dire: quello “serio”), non ignora le regole, sa cosa si può e cosa non si può fare, conosce alla perfezione i rischi a cui va incontro e cerca in ogni modo di evitarli. In tanti anni di frequentazione della montagna – in roccia, su ghiaccio, su neve, d’estate, d’inverno, in spedizioni alpinistiche, in round d’alta quota in Himalaya, Tibet, Siberia, Africa, ecc. – non ho mai conosciuto un solo candidato suicida. Non erano tali neppure quei russi che ho visto scalare una parete da brivido negli Altaj giocando a nascondino con le valanghe. Qualche incosciente “gasato” l’ho incontrato a dire il vero, ma ho anche constatato che quando il gioco si faceva duro, il “gas” spariva come per incanto e tutto rientrava nella norma. Purtroppo qualcuno è tornato a casa “con il cappotto di legno”, come si dice dalle mie parti, e questa è una triste realtà che mi ha toccato personalmente con la scomparsa recente di due cari amici “al di sopra di ogni sospetto”: Giuliano De Marchi e Leonardo Gasperina. Ma è successo quasi sempre a causa del fato, dell’imponderabile, dell’umanamente inevitabile. Coloro, e sono tanti, che hanno gettato secchiate di fango sugli sci alpinisti (e anche sugli alpinisti e sulla povera “montagna assassina” che è totalmente innocente e non c’entra assolutamente nulla con le nostre debolezze o con le nostre sfortune) devono capire che all’appuntamento fatale di cui parla l’antica leggenda di Samarra – vuoi sulla strada come in montagna – nessuno può sfuggire!
 Un ricco mercante di Baghdad mandò il suo servo al mercato per fare provviste. Al ritorno, tremante e stravolto, il servo disse di aver incontrato al mercato una donna vestita di nero. Era la morte che gli aveva fatto un gesto minaccioso. Allora il servo si fece prestare un cavallo e scappò al galoppo nella città di Samarra dove la morte non avrebbe potuto trovarlo. Il mercante quindi andò al mercato, incontrò la morte e le chiese come mai avesse minacciato il suo servo. «Il mio gesto era di stupore, non di minaccia – disse la morte -. Non mi aspettavo di vederlo al mercato di Baghdad, dato che avevo con lui un appuntamento questa notte a Samarra.»
Un ricco mercante di Baghdad mandò il suo servo al mercato per fare provviste. Al ritorno, tremante e stravolto, il servo disse di aver incontrato al mercato una donna vestita di nero. Era la morte che gli aveva fatto un gesto minaccioso. Allora il servo si fece prestare un cavallo e scappò al galoppo nella città di Samarra dove la morte non avrebbe potuto trovarlo. Il mercante quindi andò al mercato, incontrò la morte e le chiese come mai avesse minacciato il suo servo. «Il mio gesto era di stupore, non di minaccia – disse la morte -. Non mi aspettavo di vederlo al mercato di Baghdad, dato che avevo con lui un appuntamento questa notte a Samarra.»
Anni or sono un vecchio manufatto della Guardia di Finanza che giaceva abbandonato a due passi dalla casèra di Pian Formaggio in Val Digón (Comélico Superiore) fu riadattato a rifugio alpino a cura della Sezione Val Comélico del Cai e dotato di cucina, servizi, due dormitori per complessivi 31 posti letto e di tutto quanto occorreva per un dignitoso funzionamento. Situato poco sotto la cresta di confine con l’Austria, fu chiamato Rifugio Cavallino e adibito, primo in Italia, a soggiorni e corsi di Alpinismo Giovanile. In termini di marcia, l’iniziativa partì “in quarta” nel 1978, fu visitato dall’allora Presidente Generale Priotto e dal Consiglio Direttivo del Cai, poi passò alla “terza” e alla fine, come succede spesso anche alle lodevoli iniziative del Cai, si affievolì un po’.
Un giorno, anzi un pomeriggio d’inverno, raggiunsi il rifugio con mio fratello e due amici, tutti del Gruppo Rocciatori. Il nostro intento era di passare alcune ore in rifugio, cenare e poi salire fino al Monte Cavallino, da questo effettuare la traversata notturna al Passo Silvella, scendere all’Alpe di Némes, poi al Passo di Montecroce Comélico e infine a Valgrande. Una cosa tranquilla, ma con qualche incognita nel tratto Cavallino-Passo Silvella causa valanghe. Era chiaro a tutti che se ci fosse stato il benché minimo sentore di pericolo si sarebbe fatto dietro front, com’era già capitato e come capitò ancora in futuro.
Avevo portato dal trevigiano un bottiglione di merlot (forse erano due, non ricordo bene). Ma ricordo perfettamente che all’interno del rifugio c’era un freddo boia, molto più che all’esterno. Così accendemmo la stufa, mangiammo qualcosa e … bevemmo tutto il bevibile. Ciò a dire: il bottiglione di merlot (ma insisto nel pensare che erano due) e una bottiglia di grappa. Colpa del freddo, naturalmente. Fatto sta che, invece di partire per la nostra avventura notturna (cosa che doveva essere saggia se si voleva evitare il pericolo di valanghe), ci buttammo in branda e ronfammo in modo ignobile fino all’alba.
Un’alba radiosa che vide subito il ritiro di un compagno già sulla prima rampa sopra il rifugio; ufficialmente per la rottura di un attacco.
I tre superstiti, con l’alito da cantiniere e un po’ annebbiati (non tanto dal merlot, quanto da quella porcheria di grappa che era fuori da ogni seria distillazione che vuole “la testa”, “il cuore” e “la coda”), ma con “le antenne dritte”, proseguirono per l’erta controllando che il lungo cordino rosso da valanga legato in vita non si staccasse. Era il nostro unico mezzo di avvistamento nel caso fossimo stati travolti da valanga. Allora si usava così e non c’erano gli apparecchi Arva; si andava nello stile “alla divina provvidenza”. Sembra un paradosso, ma allora c’erano meno morti. Forse erano in pochi a fare sci alpinismo? Non so! So di certo che non esisteva quella moda, quella mania di oggi dell’ “andiamo ad ogni costo”. Questa sì che è una vera sciocchezza senza attenuanti.
 Dal Cavallino traversammo quelle maledette pale ripidissime che videro nel 1915 in nostri soldati morire a centinaia durante il tentativo di conquistare la cresta dove si annidavano al sicuro gli austro-ungarici.
Dal Cavallino traversammo quelle maledette pale ripidissime che videro nel 1915 in nostri soldati morire a centinaia durante il tentativo di conquistare la cresta dove si annidavano al sicuro gli austro-ungarici.
Tutto filò liscio. Si procedeva con molta cautela, staccati l’uno dall’altro di un bel po’ dove si intravedeva anche un minimo segno di pericolo, un cambiamento di neve, un accumulo a causa del vento, un sospetto qualsiasi. Giunti al Passo Silvella iniziammo finalmente la discesa, sempre concentrati, con molta attenzione. Non era tardi, ma il sole già riscaldava l’ambiente. Che pareva tranquillo, ben innevato da un “prodotto” compatto e sicuro.
Il primo pensiero fu di scendere a sinistra, direttamente lungo le falde del Quaternà, magnificamente candido come una meringa. Ma qualcosa puzzava; c’erano tracce di vecchie slavine e l’insieme non ci piacque. Istinto? Percezione di pericolo? Così procedemmo “sul facile”, o su quello che erroneamente credevamo sicuro, traversando sotto i Frugnóni fino al fosso delle Pale del Decano. Da qui prosegue una discesa abbastanza erta, ma non eccessiva, peraltro già percorsa molte volte. In fondo alla pala si scorgeva la capanna dei pastori dell’Hirtenhütte. C’era sempre nell’aria quel qualcosa che non convinceva. Cosa? E chi lo sa! Fatto sta che procedemmo uno alla volta, ben distanziati per non gravare contemporaneamente sul manto nevoso che, di tanto in tanto, non era più compatto come prima. Dal rumore sembrava che sotto ci fosse del vuoto. Usammo tutte le nostre conoscenze, tutta l’intelligenza che in questi casi si fa lucida, con o senza merlot. C’è la pelle di mezzo e non si scherza.
Il primo di noi passò bene e procedette tranquillo nella discesa. Disse anche che, secondo lui, il tratto era sicuro. Allora partì il secondo, ma giunto poco oltre la metà del pendio si fermò un po’; aveva udito un rumore secco, inconfondibile. Si stava staccando una valanga. Io ero abbastanza lontano, fermo come un masso al di sopra del declivio su una specie di pianerottolo, ma non mi sentivo per nulla sicuro. All’improvviso, con un boato che mi tolse il sonno per parecchie notti e ancor oggi sento distintamente se mi concentro, la superficie nevosa alla mia altezza si spezzò. Si staccò di mezzo metro, poi di un metro, poi di cinque, quindi di dieci metri e scivolò verso il basso con me sopra. Sembravo l’albero di una barca a vela o un naufrago sul pack. Credevo di essere fermo e invece mi muovevo. Subito mi prende un senso di vertigine, mi viene da vomitare, la montagna attorno sfila inesorabilmente verso l’alto. Invece sono io che scivolo verso il basso. Ma allora mi muovo, perdinci!
Vedo distintamente l’amico sul margine opposto che sembra salire, lo sento tirar giù una madonna delle sue… poi lo vedo saltare oltre il distacco e uscirne. È salvo. Io resto l’unico fesso ad essere dentro in questo escremento bianco fino al collo.
Dal rumore inconfondibile e dalla scena che mi si presenta capisco subito che si tratta di una valanga di lastroni, quella che ti sfugge sotto i piedi e dalla quale, se hai la fortuna di non cadere dentro fra i blocchi e possiedi un bel po’ di voglia di vivere, ti puoi salvare.
Mi sento prigioniero, non posso fuggire.
 Cadrei fra i blocchi che si stanno moltiplicando, e alcuni sono veramente giganteschi. Farei la fine della polpa nel tritacarne. Il blocco che mi sostiene è molto esteso, sembra un iceberg alla deriva. Se continuerà a scivolare senza spezzarsi mi porterà a spasso fino al capolinea, a fine corsa. Ora mi scopro equilibrista. La paura della morte fa brutti scherzi. Se qualcuno mi avesse filmato, oggi quello spezzone sbancherebbe su you tube. Il viaggio dura per circa duecento metri. Non finisce mai. Poco prima del traguardo, che è un breve falsopiano con un boschetto di basse latifoglie sul margine a valle, il lastrone va in frantumi infrangendosi sugli arbusti. Me l’aspettavo e sono pronto a vendere cara la pelle. Eccomi ora dentro una poltiglia bianca nella quale “nuoto” in stile molto libero e dalla quale, solo per una questione di gran “di dietro”, riesco a uscire indenne.
Cadrei fra i blocchi che si stanno moltiplicando, e alcuni sono veramente giganteschi. Farei la fine della polpa nel tritacarne. Il blocco che mi sostiene è molto esteso, sembra un iceberg alla deriva. Se continuerà a scivolare senza spezzarsi mi porterà a spasso fino al capolinea, a fine corsa. Ora mi scopro equilibrista. La paura della morte fa brutti scherzi. Se qualcuno mi avesse filmato, oggi quello spezzone sbancherebbe su you tube. Il viaggio dura per circa duecento metri. Non finisce mai. Poco prima del traguardo, che è un breve falsopiano con un boschetto di basse latifoglie sul margine a valle, il lastrone va in frantumi infrangendosi sugli arbusti. Me l’aspettavo e sono pronto a vendere cara la pelle. Eccomi ora dentro una poltiglia bianca nella quale “nuoto” in stile molto libero e dalla quale, solo per una questione di gran “di dietro”, riesco a uscire indenne.
Eravamo esperti, conoscevamo l’ambiente, la neve ci era amica e familiare fin da bambini eppure ci siamo cascati come imbecilli. Che è una categoria diversa da quella dei suicidi. Da allora mi sono convinto che esiste una specie di irresistibile richiamo del destino che ti dirige, senza che tu riesca a fermarti, là dove non saresti mai dovuto andare.
Ed è là che trovi la tua Samarra.
Tempo fa un signore, alla fine di una mia conferenza, chiese come ho fatto a descrivere il caso del soldato Faina coinvolto in una valanga in Popèra (vedi capitolo a lui dedicato nel libro “La valanga di Selvapiana”). «Lei non poteva essere presente (no! altrimenti avrei 120 anni); come ha potuto raccontare l’accaduto con particolari così verosimili?» Gli ho risposto che ho semplicemente descritto ciò che avevo vissuto in prima persona.
«Improvvisamente a Faina sembra di volare, di muoversi senza muoversi, di avanzare stando fermo, con le gambe che non ubbidiscono più agli ordini del cervello. Ora gli gira anche la testa, ha un senso di nausea, tenta di connettere, di controllarsi. È sicuro di essere fermo … Eppur si muove! Solo dopo un po’ si rende conto della realtà: si trova nel cuore di un enorme smottamento che prende via via velocità e si dirige inesorabilmente verso il fondo della valle. Faina capisce al volo; sta scendendo a cavallo … di una valanga. Valanga o slavina? Sia quel che sia, è una robaccia di quelle dette “di scivolamento”, cioè una grande massa di neve che non precipita massacrando, ma scivola – più o meno dolcemente – in base al pendio su cui si muove. Non si scherza con questo tipo di valanga. Faina sa che deve assolutamente stare “a galla”, così come gli ha insegnato quel bravo caporale di Belluno quand’erano sul fronte dei Frugnóni. Se si lascia andare verrà sommerso, stritolato, sepolto. Deve “nuotarci” sopra, deve cavalcarla, quella valanga bastarda. E ci riesce. Più in basso la valanga acquista velocità, galoppa sui dossi, sobbalza, salta, si allarga, si stringe, frena, riparte … ma il fante resiste, resta in groppa, cavalca, nuota, si dimena, rifiuta il seppellimento, reagisce alla violenza delle ondate bianche, si ostina … Giunge illeso in fondo al pendio. È tutto bianco, il bravo Faina, come nel giorno della prima comunione, come un eroico cavaliere medioevale di cappa e spada, come un templare pronto per una cerimonia. Un mito d’altri tempi, un guerriero della fantasia.»
L’appuntamento di Faina non era in Popèra come il mio non era a Némes.
Dove sarà la mia Samarra ?
Italo Zandonella Callegher
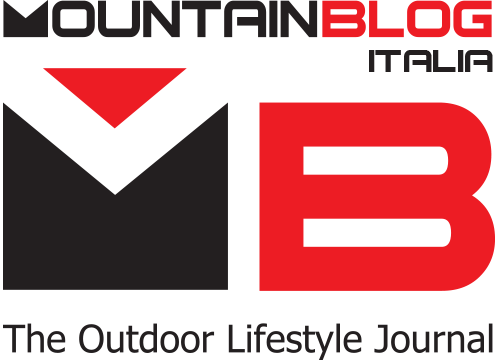




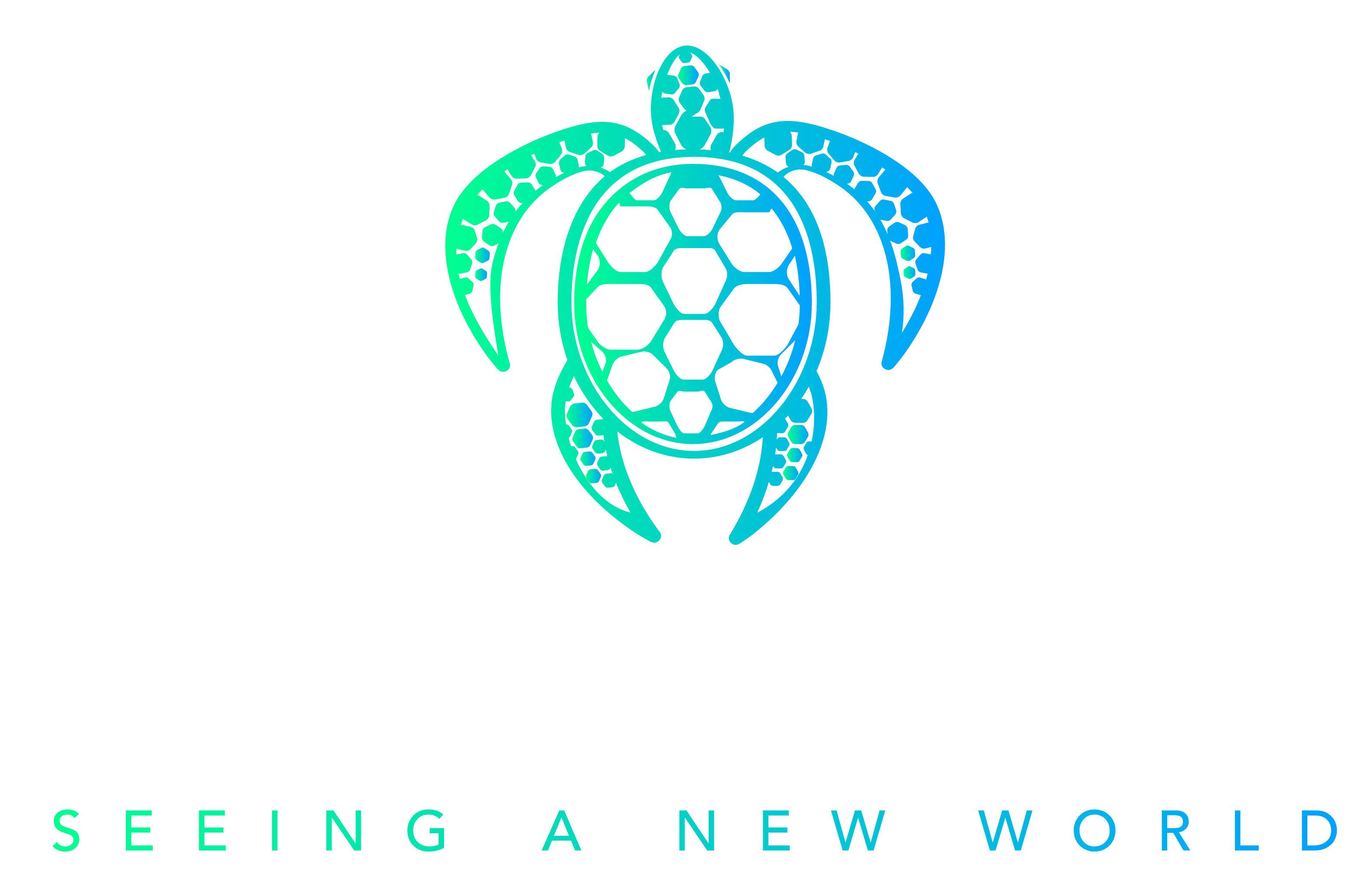










































bellissimo contributo Italo.. la penso esattamente come te in materia… quel suono che crea la valanga al momento del distacco l’ho provato anche io… nelle tue parole è facile rivivere quelle sensazioni… e quando sei sopra un lastrone chi sei e la tua voglia di vivere fanno la differenza…
Ciao Tommaso, sono contento che la pensi come me. La categoria va difesa nonostante i fatti le diano torto. Molta gente che dovrebbe e potrebbe parlare preferisce stare vilmente in silenzio. Verranno giorni migliori… Ciao, Italo
complimenti per il pezzo, molto semplice e significativo, che penso tanti di noi scialpinisti appassionati e più o meno esperti condividiamo.
Cara Paola, grazie per l’apprezzamento. Mi piacerebbe che gli sci alpinisti reagissero a questa querra dei media contro di loro. Invece tacciono e così… li bastonano. E tacendo danno ragione ai denigratori che di montagna non sanno nulla. Ciao, Italo
Caro Italo,
il tuo bel pezzo capita quasi “a fagiolo”. Uno dei nostri (della Giovane Montagna) è stato preso dalla morte bianca, il 20 marzo a Col Bechei… ma non era un suicida, nè un imbecille: era solo giunto alla sua Samarra.
Eravamo stati assieme a un corso “neve e valanghe” due mesi fa…
Grazie per la solidarietà a noi sci alpinisti (che tu dici silenziosi e succubi…, ma non tutti). Ciao.
Caro Andrea, non sapevo dell’amico della GM andato a Samarra. A te e agli amici di GM la mia vicinanza. Ciao, Italo
Grazie Italo per la difesa a spada tratta dello sci alpinista e in generale di chi frequenta la “montagna” con lo spirito libero da ogni impedimento, valutando coscientemente il rischio…..per se e per gli altri. L’imponderabile ci può essere, ma non è suicidio!!
Grazie GCarlo, per le tue sagge parole; spero che tutti le leggano. Ciao, Italo
Grazie italo x i tuoi bei commenti,ho girato quasi tutte le montagne del comelico in inverno e sono sempre stato fortunato,perchè di fortuna si tratta anche se si scia con molta cautela.Quando tieni una tua conferenza?
Ciao Edi,
credo che farò qualcosa questa estate in Comelico. Grazie per l’apprezzamento, Ciao a presto, Italo