 È il 24 febbraio del 1915. Su tutte le Dolomiti infuria una terribile bufera.
È il 24 febbraio del 1915. Su tutte le Dolomiti infuria una terribile bufera.
Alla sede del comando nella casèra di Selvapiana giunge l’ordine di rifornire gli uomini imprigionati dalla tormenta di neve nella baracca del Comando sul Crestón Popèra. I due sottufficiali del deposito riescono a radunare tutti gli uomini possibili. Sono i più forti, tutti amici o conoscenti, tutti “razza Piave”, provenienti dalla magnifica Marca Trevigiana, tutti vecchi richiamati e inseriti nel nuovo corpo della Milizia Territoriale, meglio conosciuta come “la Terribile” per via dell’età, dei vecchi fucili in dotazione e dell’abbigliamento non certo all’ultima moda. Sono 46 sventurati che provengono da San Zenone degli Ezzelini, da Altivole, da Montebelluna, da Crocetta Trevigiana, da Volpago del Montello, da Santa Lucia di Piave, da Fontanelle, da Codognè, da Gaiarine, da Conegliano, da Farra di Soligo, da Follina e da altri Comuni della Marca. Caricati sulle spalle gli zaini ben affardellati, i militari partono per il loro durissimo viaggio. In fondo alla valle, dove il bosco lascia il posto allo spazio sottostante gli spalti di roccia, iniziano a salire verso il Popèra.
La grande montagna non si vede, immersa com’è nell’ovattato biancore della neve. Non si vedono neppure le rocce giallastre sulla destra che fanno da piedestallo al Crestón, né quelle di sinistra, grigie e compatte, che formano le mura possenti del Sasso di Selvapiana. La pista è scomparsa e i fanti arrancano nella coltre bianca come naufraghi in un mare di neve o marinai alla deriva sul pack, ma sanno a memoria dove andare. Sono divisi in piccoli gruppi per non intralciarsi e scavano e spalano, e spalano e scavano, palata dopo palata, senza sosta. Su quel maledetto pendio sono passati decine e decine di volte e ritrovano subito la traccia ideale fra i sassi dove, più o meno, dovrebbe passare la mulattiera sepolta dalla neve. Sono consapevoli che senza il loro apporto e il loro umilissimo lavoro di portatori il caposaldo del Crestón Popèra non può resistere.
La prima parte della salita non è molto ripida poi, via via che si avvicinano allo spalto roccioso che d’estate fa da quinta alla cascata del Rìsena, i fanti incontrano sulla sinistra i salti che sostengono la fiumana di ghiaie dei Campanili, delle Guglie e dei Fulmini. Ora dovranno vincere senza indugio alcuni gradoni pericolosi coperti di vetrato. Le valanghe, che qui sono di casa, nel loro dannato volo polveroso non toccano i basamenti di queste rocce, ma le scavalcano, ci volano sopra. Se mentre passa ti trovi sul bordo vieni spazzato via, se stai un po’ sotto forse ti salvi. Sempre che il terribile respiro della valanga, il micidiale “soffio”, lo voglia.
Passato questo punto il cammino continua a destra, verso il Vallón Popèra, relativamente fuori dal pericolo.
Flagellati dalla tormenta, maltrattati dal vento, fiaccati dal gelo dei trenta gradi sotto zero, istupiditi dalla fatica dell’aprire pista, sfiniti dall’uso di quella corta pesante maledetta pala, dolenti nelle spalle, rotta la schiena dal peso dello zaino, i piedi di ghiaccio tanto da non sentirli più, dure e bianche le mani come ossa nel deserto, e altre dieci cento mille tribolazioni…i poveretti si ritrovano finalmente sopra i salti rocciosi, sul bordo, proprio là dove la fronte del vallone che scende dalla Sentinella si incontra con quello assai più ripido che giunge direttamente dalle Guglie. Sopra di loro si stende il lungo pendio che termina su, alla base delle rocce. Non è un bel posto per fermarsi, lo sanno bene, ma devono farlo per riprendere fiato. È difficile respirare nella tormenta che imperversa feroce e gela la barba incolta e i baffi spioventi. Il respiro si fa stentato, il nevischio penetra nel collo e nei buchi dei miseri indumenti militari. Lo stesso modello usato nella campagna di Libia del 1912.
Quando i fanti sono lì, fermi, e chiedono ai caporali un po’ di tregua, quando i poveri diavoli infreddoliti si girano verso valle per evitare la sferza del vento malandrino che soffia dal Passo della Sentinella, quando una luce strana si diffonde tra il biancore accecante della neve, quando un fante tira giù un’ostia che in quel contesto non è bestemmia ma preghiera e il Dio dei Soldati lo sa, quando un altro impreca contro i generali che stanno col culo al caldo e mandano al macello i poveri grami, quando un burlone lancia una palla di neve al pi mona della compagnia, quando il caporal maggiore Zoia dice «Tosat, andemo via, non me piase sto posto», quando l’ultimo della fila rimette nei pantaloni quel cosino che ha macchiato di giallo il biancore della neve, quando sta succedendo tutto questo…un rumore sordo li fa sobbalzare.
Pare un tuono lontano o un rombo di cannone. Ma non c’è temporale d’inverno e nessuno spara con questo tempo infernale. Poi sentono un soffio strano, simile a quello di un gatto arrabbiato, molto arrabbiato, mille, cento mila, un milione di gatti arrabbiati. È lo spostamento d’aria che precede l’enorme valanga che si è staccata dalla cuspide della Cima Popèra e si è incanalata nell’angusto corridoio roccioso che incide, come una enorme ferita, tutto il settore che sta fra le Guglie di Stallàta e i Fulmini di Popèra. Una massa mostruosa che si rinforza nella strettoia. Un Vajont di neve che acquista velocità e violenza e forza distruttrice.
Dal rumore inconfondibile i quarantasei fanti capiscono subito che non si tratta di una valanga di lastroni, quella che ti sfugge sotto i piedi e dalla quale, se hai la fortuna di non caderci dentro fra i blocchi e possiedi un bel po’ di voglia di vivere, ti puoi salvare. Non è neppure una valanga di scivolamento; i più bravi e i più fortunati riescono a cavalcarla senza farsi travolgere, dimostrando una buona dose di equilibrismo e di sangue freddo. Purtroppo questa è una valanga polverosa, la più micidiale. Con lei non è solo la neve che ti travolge, ma lo spostamento d’aria; la neve arriva dopo a coprire il mal fatto e a soffocarti.
Come un Vajont, dunque, non di acqua ma di neve polverosa, la valanga schizza fuori dal pertugio, si alza, si inarca, piomba sul pendio, si unisce alla neve dei Campanili, penetra nelle viscere del ghiaione, lo denuda, si rinforza. Poi corre verso valle a centocinquanta e più chilometri all’ora. Simile a quella nuvola di polvere mortale che scende velocissima dalla bocca di certi vulcani tropicali e che i vulcanologi chiamano “valanga incandescente” o “flusso piroclastico”. Insomma, una porcheria infernale, di gelo invece che di fuoco. Che sta piombando su quarantasei disgraziati inermi mentre il giorno diventa notte e la situazione si fa disperatamente drammatica.
I poveri cristi non vedono la valanga – c’è la bufera – ma la sentono, sanno che la nube di ghiaccio sta arrivando. Tutti sperano che prenda la via del canalone presso il Sasso di Selvapiana. Ha sempre seguito quel canalone fatto apposta per lei, perché dovrebbe cambiare itinerario proprio ora!? Non è possibile che cambi strada, Dio bon! Non è possibile che cambi…
E invece proprio quando Bepi dice: «Fioi, stavolta reston zenza ‘l telèr» [cioè senza lo scheletro], quando qualcuno cerca di fuggire ma sa che è inutile, quando si fa buio perché la valanga è un micidiale enorme batuffolo che oscura il cielo, quando il soffio strappa i berretti e fa volare gli zaini, quando i padri pensano ai loro piccoli che resteranno soli nella miseria, quando qualcuno si fa il segno della Croce, quando qualcun altro tira giù tutti i Santi e le Madonne del Paradiso, quando tutti insieme gridano «Mamma»… arriva la Morte Bianca.
Il terribile soffio che fa infuriare l’aria e la sconvolge. Subito il pulviscolo di neve si ribella, si alza, turbina attorno ai corpi, vola, scende, gira e rigira, si avvinghia, si attacca e si stacca, rotea, urla, rumoreggia, avvolge. Poi travolge, copre, nasconde tutto. Infine soffoca. Sono le ore 15 di giovedì 24 febbraio 1916.
I soldati rimasti nelle baracche di Selvapiana sentono distintamente il frastuono della valanga che è diventato ormai  qualcosa di familiare. Parte subito una squadra di soccorso al comando dell’Ufficiale Medico Pietro Galato, coadiuvato dal Sottotenente Carlo Canepa e dal Caporal maggiore Mariano Moraj. Saranno i testimoni chiave della tragedia. Giunti alla base del pendio ciò che appare subito ai loro occhi stralunati dallo stupore è straziante. I quarantasei soldati della corvè sono stati strappati dallo spalto dove si trovavano e spostati, spinti, trasportati con immensa violenza verso valle. Qualcuno, più fortunato è riuscito a rimanere a galla ed è stato portato dalla massa impetuosa fino in fondo alla scarpata, centinaia e centinaia di metri. Altri emergono dal caotico biancore; chi con una gamba, chi con un braccio, i più fortunati con la testa. Altri ancora vengono identificati da qualche straccio affiorante e sono i primi a essere tirati fuori. Tirati, letteralmente. Non c’è tempo per i complimenti. Meglio una spalla contusa o una gamba slogata che la morte per soffocamento. La squadra di soccorso sa cosa deve fare per tutti gli altri: scavare e scavare senza tregua. Ognuno ha in dotazione una piccola pala ed è ora di far vedere come la si usa. Nel frattempo, sotto una incredibile massa di neve, stanno lottando con la Morte Bianca quarantasei poveri corpi straziati.
qualcosa di familiare. Parte subito una squadra di soccorso al comando dell’Ufficiale Medico Pietro Galato, coadiuvato dal Sottotenente Carlo Canepa e dal Caporal maggiore Mariano Moraj. Saranno i testimoni chiave della tragedia. Giunti alla base del pendio ciò che appare subito ai loro occhi stralunati dallo stupore è straziante. I quarantasei soldati della corvè sono stati strappati dallo spalto dove si trovavano e spostati, spinti, trasportati con immensa violenza verso valle. Qualcuno, più fortunato è riuscito a rimanere a galla ed è stato portato dalla massa impetuosa fino in fondo alla scarpata, centinaia e centinaia di metri. Altri emergono dal caotico biancore; chi con una gamba, chi con un braccio, i più fortunati con la testa. Altri ancora vengono identificati da qualche straccio affiorante e sono i primi a essere tirati fuori. Tirati, letteralmente. Non c’è tempo per i complimenti. Meglio una spalla contusa o una gamba slogata che la morte per soffocamento. La squadra di soccorso sa cosa deve fare per tutti gli altri: scavare e scavare senza tregua. Ognuno ha in dotazione una piccola pala ed è ora di far vedere come la si usa. Nel frattempo, sotto una incredibile massa di neve, stanno lottando con la Morte Bianca quarantasei poveri corpi straziati.
«Svelti, fioi, svelti; moveve, par Dio » urla ai suoi uomini l’Ufficiale medico Galato; che l’è ‘n bon dotor, sa bene che ogni minuto può essere l’ultimo per chi è dentro quella vigliaccata. Non ci sono cani “sanbernardo” o d’altra razza che giocando annusano il sepolto; non ci sono sondini in lega leggera con i quali perforare la spessa coltre in cerca di qualcosa di molliccio; non ci sono cordini colorati legati in vita che conducono al corpo; non ci sono apparecchi Arva “cercapersone”, ché ancora devono essere inventati. Ci sono quarantasei uomini disperati, lì sotto, che sperano. Ci sono pochi uomini disperati, lì sopra, che scavano.
Il «Dio bon» dei fanti (ma è lo stesso che hanno anche gli alpini e tutti gli altri militari) permette il recupero, abbastanza veloce, di ventinove uomini. Per loro molta paura, una caterva di moccoli, ostie a non finire. Ma ci sono anche i timorati di Dio che trovano il tempo di inginocchiarsi nella neve e recitare qualche preghiera e fare un devoto sentito grato segno della Croce. Sono praticamente, miracolosamente illesi. Qualche distorsione, che loro chiamano ‘na storta, qualche ammaccatura, una buona dose di paura e la netta sensazione di aver visto in faccia la famigerata “Sorella Morte” di San Francesco. Nessuno poteva permetterselo, ma qualcuno forse pensò che un viaggio di preghiera a Lourdes, dove 58 anni prima erano successe cose strane, ci stava giusto giusto…
All’appello mancano ancora diciassette uomini.
Il tempo passa velocemente e l’intervento di salvataggio si fa sempre più spasmodico, affannoso, caotico. Lì sotto ci sono ancora degli amici, dei paesani, forse dei parenti, sicuramente dei fratelli di naia. Cosa si può fare?! «Scava, madona, scava», incita il Sottotenente Carlo Canepa mentre ‘l dotor Galato si allontana un po’ per curare il primo ferito che è appena stato estratto. Ha una gamba che gli gira sul collo e urla come un dannato quando il medico gliela tira giù. «Benon» brontola l’ufficiale mentre ricompone l’arto e lo deposita sulla neve morbida, «se te urla vol dir che te xe vivo; ringrassia l Signor, benedeto».
Nel frattempo altri cinque fanti vengono estratti vivi. Sono seriamente feriti, ma il medico dice che probabilmente se la caveranno. Dopo le prime cure del dotor di Selvapiana, i feriti vengono inviati d’urgenza all’ospedale militare n. 39 di Santo Stefano di Cadore.
All’appello mancano ancora dodici uomini.
Dall’ammasso enorme accumulato in fondo alla scarpata, ad uno ad uno, vengono estratti altri nove soldati. Ormai s’è fatto buio e continua a nevicare forte mentre il medico di Selvapiana li visita, li scrolla, poi si arrende. Per loro non c’è più nulla da fare. Per troppo tempo sono rimasti nella tomba di ghiaccio; per troppi minuti hanno sperato che giungesse qualcuno; per troppi minuti hanno creduto a un miracolo; per troppi minuti hanno pensato ai loro piccoli a casa, alle mogli, alle madri, ai padri; per troppi minuti si sono chiesti “ma perché proprio io?”; per troppi minuti hanno maledetto la guerra, il re, Ceco Beppe, i generali.
All’appello mancano ancora tre uomini.
Ormai degli ultimi tre dispersi non si nutrono più speranze, ma si continua a scavare con l’aiuto di forze nuove giunte da Valgrande. Le torce illuminano sinistramente il pendio. Viene sparato qualche razzo, ma poi si smette subito perché il boato potrebbe far partire un’altra massa di neve. Altri rombi di valanga si sentono lontani; qualche volta il rumore si fa sinistro e pericolosamente vicino, forse proviene dal canale di Cima Popèra, forse dalle pareti dei Campanili o dal canalone nord di Cima Bagni. I miliziani sperano che la razione già avuta sia sufficiente e che per oggi basti così.
Alle 23 e trenta, dopo otto ore e mezza di spalate e di ricerche, ecco finalmente un corpo sotto tre metri di neve. È rannicchiato dietro un masso, in un anfratto naturale, semi congelato, bianco come…un morto. Ma non lo è; si muove un po’, poi di più, ancora di più. È vivo. È sicuramente vivo perché tira giù una madonna che si sente per tutto l’anfiteatro roccioso. La sacca d’aria formatasi fra la piccola nicchia riparata del masso e la valanga gli ha salvato la vita. Un vero miracolo. Il medico controlla il soldato, lo visita a fondo, lo trova integro nel fisico, un po’ meno nella psiche, lo rincuora: «Lo sai che sei rimasto la sotto per quasi nove ore?; bravo soldato, hai battuto un record e gliel’hai messa in quel posto alla morte. Questo è un miracolo, ricordati; un vero miracolo. Nessuno, che io sappia, ha resistito tanto. Altro che tirar giù madonne. Dovrai tirar su preghiere, invece, e accendere tanti di quei moccoli alla Madonna delle Nevi fin che la sentirai dire “Basta, fiol, che te me brusa! Ora ti mando un po’ di giorni in osservazione all’ospedale di Santo Stefano, meglio essere prudenti; i miracoli non arrivano mai due volte e tu non hai più bisogno di un miracolo, ne hai già avuto abbastanza, ma solo di riposo e di cure.»
Il nome di questo soldato non appare sul diario, e neppure quelli degli altri feriti, ma da una frase par di capire che dopo alcune settimane fu rimandato al fronte e di lui non si seppe più nulla. Aveva ragione il medico: «I miracoli non arrivano mai due volte».
All’appello mancano ancora due uomini.
Rincuorata dall’ultimo fortunato salvataggio la squadra decide di continuare le ricerche. Durante la notte continua a nevicare. Il pericolo di nuove valanghe si fa sempre più concreto, ma nessuno ha il coraggio di dire «Basta, fermiamoci».
Dalla Cima Bagni giungono fragori assordanti, seguiti da altri più vicini. La montagna è di nuovo nervosa. Si scuote, si scrolla di dosso l’enorme peso della neve, rabbrividisce, scarica quella coperta che non vuole. Infine, ignuda, riprende il suo aspetto arcigno. I fanti continuano a scavare. Giunge l’alba. Qualche colata di neve arriva fino a pochi metri dai soccorritori, sempre più stanchi, sempre più infreddoliti, sempre più affamati. Ogni tanto si fa vivo un cuciniere con una gamella; dentro c’è un po’ di acqua calda color caffè che viene bevuta avidamente. Dei due rimasti li sotto nessuna novità. Ma dove diavolo saranno? Infine li trovano assieme, quasi abbracciati in un ultimo tentativo di scaldarsi. L’orologio da taschino di Galato segna le ore 10 di venerdì 25 febbraio 1916. I due sfortunati sono morti sotto quattro metri di neve dura, pressata, i corpi contorti, le membra rigide nella morsa del gelo. I visi sono sereni e l’espressione non è di incredulità, ma di rassegnazione.
Sono trascorse diciannove ore dalla caduta della valanga di Selvapiana. Era impossibile trovarli vivi.
All’appello non manca più nessuno.
Verranno sepolti tutti undici nel piccolo e lindo cimitero di Dosolédo di Comélico Superiore dove c’è ancora la lapide. Vi si legge: «…miseramente perirono mentre serenamente assolvevano l’arduo compito loro affidato con coscienza del loro dovere con incrollabile fede nei maggiori destini della Patria…»
Difficile immaginare che fossero veramente sereni…
(Italo Zandonella Callegher, La valanga di Selvapiana, Corbaccio, 2008)
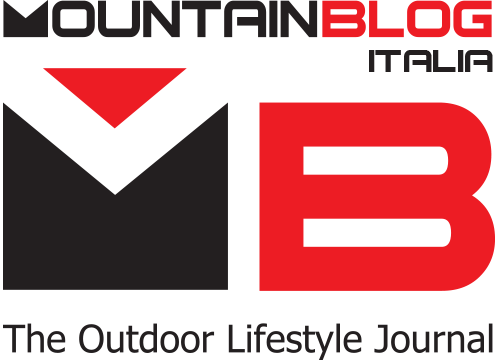




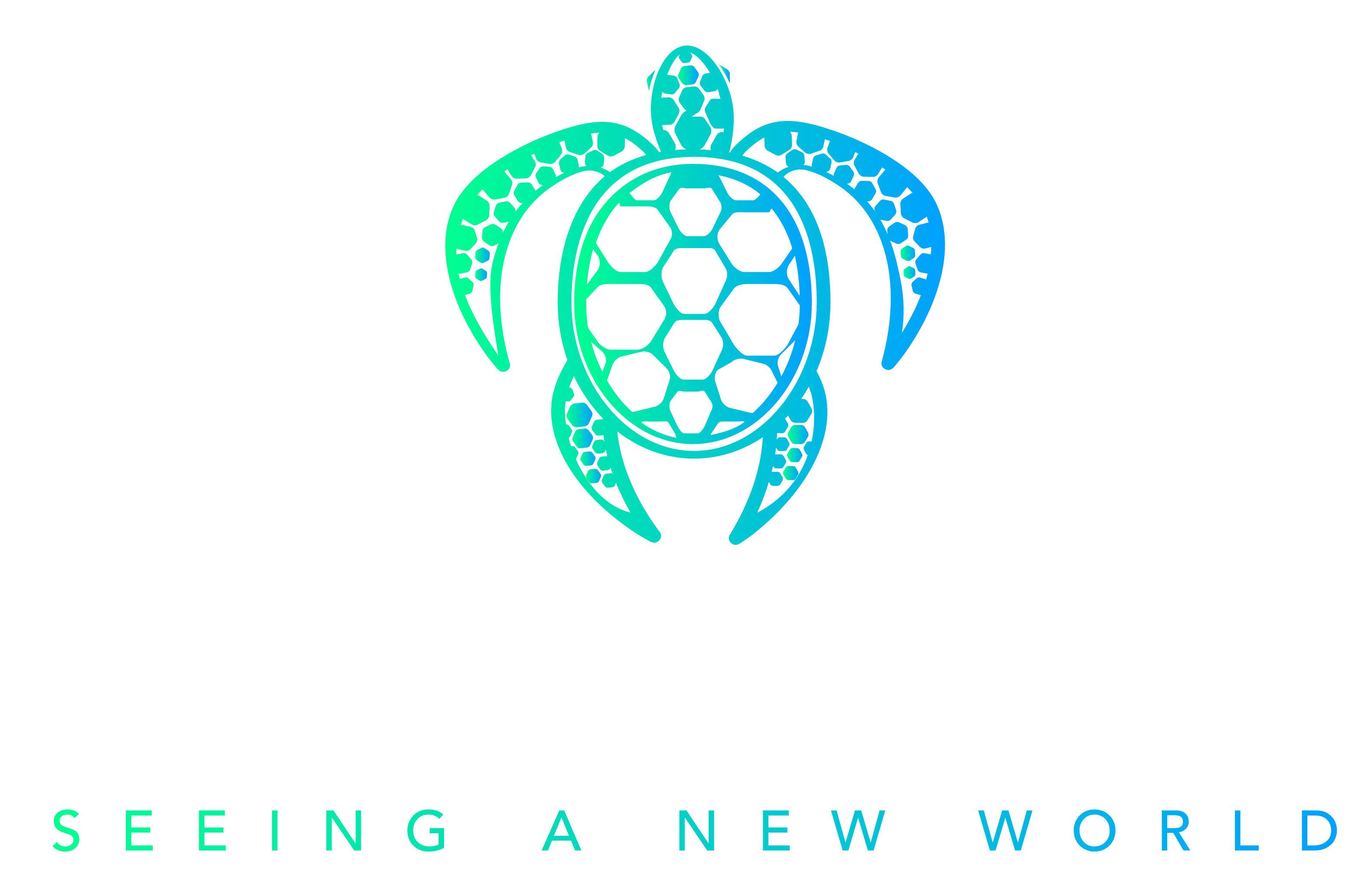










































Vivissimi complimenti.
Questo testo è semplicemente perfetto. Mi piace il ritmo, l’intensità con la quale descrive, il coinvolgimento e, al contempo, i tratti tragicomici inseriti che servono – a mio parere- a rendere il racconto ancor più realistico. Sembra quasi di essere lì, in quella tremenda situazione. Di respirare il freddo, la paura. Anche solo leggendo ci si sente piccoli ed incapaci di agire-reagire all’evento.
Sono veramente contenta di poter leggere i suoi contributi. Io non conosco la montagna, non l’ho mai veramente vissuta ma grazie ai suoi racconti, a costo di ripetermi, mi “sento partecipe” di avvenimenti e fatti che sebbene siano lontanissimi dalla mia giovane età, mi ricordano la gratitudine che si deve provare nei confronti dei personaggi dei suoi racconti. Grazie.
Cara Jessica, queste parole mi riempiono di soddisfazione. E’ bello constatare che i giovani desiderano conoscere il passato (perchè da quello veniamo e da quello procederemo sereni verso il futuro).
Grazie e cari saluti,
Italo
Narrazione avvincente e drammatica che rende bene lo spirito di solidarietà e non rassegnazione dei più semplici e genuini “figli della patria”.COMPLIMENTI!
PS. come rianimatore ho vissuto esperienze di rianimazione in congelati in montagna, in Valtellina,ed è stata dura…sembravano “vite sospese”.
Proprio ieri pomeriggio sono andato a fare una scialpinistica sul Grappa, cercando quel firn che tanto ci piace, che tanto ci fa godere disegnando curve sulla massima pendenza….
Sono salito, sceso da un versante, risalito, ridisceso da un’altra parte in attesa di godermi l’ultima discesa all’imbrunire, visto che la neve teneva bene.
Ma per tutto il tempo ho sentito solo un RESPIRO profondo, intenso, di quei soldati che combatterono lassù, per NULLA.
E in Cima mi sono soffermato ad ASCOLTARE quel respiro….
Proprio intense Parole, Italo.
Che restano.
Che DEVONO restare.
Gianlu
A differenza di Jessica,ho praticato la montagna su ogni terreno per un sacco di tempo.Ora che per svariati motivi(non ultimo l’età!) mi limito al trekking,il tuo pezzo mi ha fatto ritrovare la montagna severa della gioventù.Grazie! Luigi
La montagna ha chiesto un tributo in vite umane come, putroppo, ogni tanto fa. E ogni volta l’uomo risponde, pur non volendo, con onore e con un altrusmo senza pari. Spero che il sacrificio di questi uomini non sia dimenticato.
Grazie dell’attenzione,
Roldano
Lo hanno già detto altri, ma è un testo che merita questi ripetuti complimenti: sono parole intense, Italo, grazie!
A Luigi Vignale, a Gianluca, Luigi, Roldano, Andrea un grazie di cuore per le belle parole. Ora sto scrivendo la seconda parte della Grande Guerra in Comélico, quella avvenuta sul confine di Stato (Cresta Carnica Occidentale) che nessuno ricorda mai e che ha avuto migliaia di morti. Anche le guerre hanno la loro serie A e le altre serie. Per esempio la Grande Guerra sulle Tofane era di serie A, quella in Comélico era di serie C. Perchè i morti delle Tofane erano eroi e quelli del Popèra erano “mona”? Cercherò di spiegarlo nel prossimo libro. Ciao a tutti, Italo
Il libro è bellissimo. Inoltre, dato che conosco la zona riesco a “vivere gli avvenimenti” con grande emozione. Ancora complimenti. Aspetto con emozione la seconda parte sulla Cresta Carnica.
Grazie Marcella per l’apprezzamento. Spero di riuscire a suscitare emozioni anche con la seconda parte. Cordialità, Italo
Anche a me è piaciuto molto il suo libro.
Mi ha emozionato sentir parlare dei Mascabroni. Io sono la nipote di uno di essi. Mio nonno era Da Col Fedele. Sono convinta che anche a mio papà farebbe piacere parlare con lei….Se ha voglia e tempo di mettersi in contatto con noi ci farebbe un enorme piacere. Cari saluti Chiara
Gentile Chiara, grazie per l’apprezzamento. Sento con piacere che è nipote di uno dei protagonisti della Sentinella, quel Da Col Fedele bravissimo. Con piacere vi contatterò. Mi faccia avere il suo indirizzo e troveremo il modo per incontrarci. Un caro saluto, Italo