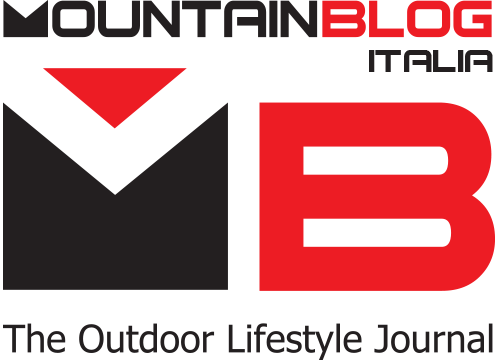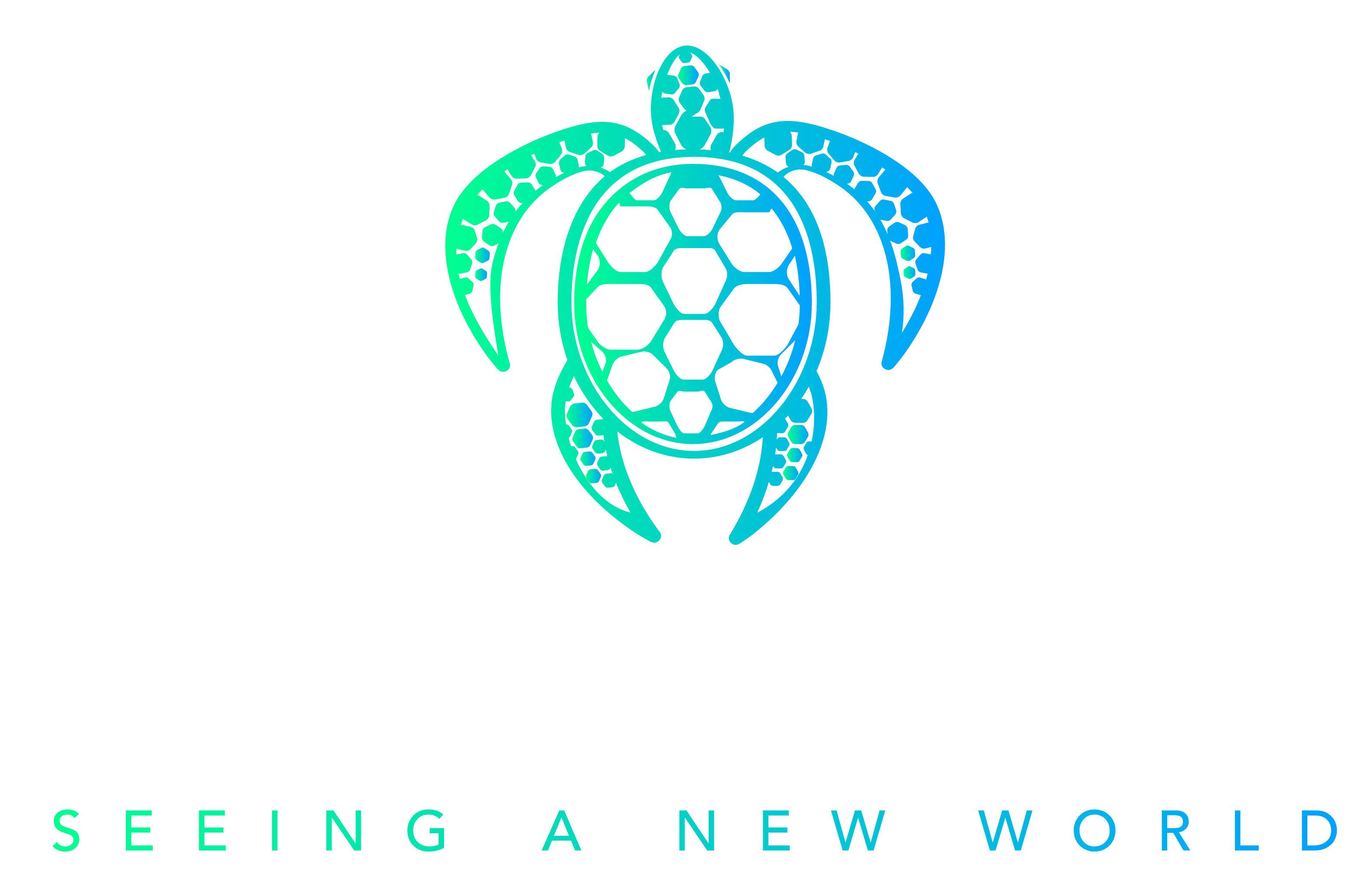Quando ero bambino mi capitava spesso.
Mi capitava di spingere libri, quaderni e parte della cancelleria presenti sulla mia scrivania per stiparli in modo frettoloso e confuso verso il bordo della stessa che coincideva con un copricalorifero di legno laccato, bianco.
Una volta liberato il presunto piano di studio vi appoggiavo le mani e facendo perno su di esse – con un salto deciso – mi ritrovavo in ginocchio sul tavolo con i gomiti appoggiati al davanzale della finestra che si trovava appena sopra e la fronte che premeva sul vetro.
Ho passato delle ore in quella posizione. Ore intere. Ore vere.
Mi capita ancora di pensarci e di pensare a quello che mi passava per la testa in quelle ore. Quella posizione era una posizione da sogno.
Abitavo a Milano quando ero bambino; ci ho abitato fino all’età di diciotto anni, più o meno. E’ una cosa di cui a volte mi vergogno, ma non per davvero – non fino in fondo – perché anche questo nel bene o nel male, fa parte della mia traccia.
Abitavo in un quartiere di periferia, a Milano. Uno di quei quartieri in cui d’inverno c’è la nebbia che ti impedisce di vedere cos’hai intorno e anche quando non c’è la nebbia fai comunque fatica a percepire la reale profondità delle cose per colpa dei palazzi che ti circondano.
Una realtà abbastanza opprimente, ripensandoci.
Io, per fortuna, avevo la mia finestra. Già perché in quella posizione – quella con la fronte appoggiata al vetro – io vedevo.
Quello era il mio punto di vista privilegiato – una visuale inusuale per quel chi e quel dove – che mi permetteva di scrutare un’infinità di tetti, strade ed automobili; persone, alberi e gatti; viadotti, fabbriche ed autostrade.
Montagne.
All’orizzonte, lontane – ma vicine per la loro imponenza durante le rare giornate terse della pianura – loro. Insieme ad esse una necessità irrefrenabile di raggiungerle ed esplorarle, toccarle, conoscerle più di quanto non le conoscessi già.
Le vedevo lì, calme ed immobili; incuranti della frenesia che ci separava. Mi aspettavano, talvolta verdi talvolta, stupendamente bianche.
Mio nonno lo diceva sempre che quelle erano le sue montagne ed io, di conseguenza, le sentivo anche un po’ mie perché si sa, non c’è nulla che un nonno non spartirebbe con il proprio nipote.
La mia vita – penso a volte – è incominciata da quella finestra; da quegli sguardi, da quei sogni. E’ come se tutto avesse preso una forma precisa durante quelle ore intere; quelle ore vere.
Momenti passati a riflettere sul come sarebbe potuto essere e su come sarebbe effettivamente andata se avessi deciso – definitivamente – di rincorrerle.
Frammenti di entusiasmo e di paura, come chi cerca di osare ma non riesce ad osare fino in fondo.
Se penso a quello che mi separa da quei momenti non mi sembra di ripensare a degli anni ma a delle vite intere.
Sono partito.
Ho vagabondato, conosciuto. Ho sbagliato e ritentato.
Mi sono fermato e sono ripartito di nuovo. Ho fallito ed ho avuto successo.
Ho studiato, ho visto ed ho perso di vista. Ho rincontrato ed ho perso per sempre.
Non sono mai tornato indietro né intendo fermarmi.
Se ripenso alla mia finestra mi sembra di sentire ancora il dolore alle ginocchia per il troppo tempo passato in quella posizione; gli spifferi freddi che penetravano dai serramenti poco sigillati e mia madre che mi urlava di studiare.
Se ripenso alla mia finestra ripenso ai miei sogni ed alle mie paure, ai miei successi ed ai miei fallimenti.
Nel tempo molte cose sono cambiate, al di fuori e dentro di me.
Le montagne sono sempre rimaste lì – se pur diverse e più vicine – a permettermi di sognare e di sognarle.
La mia traccia appartiene ad esse ed esse appartengono alla mia traccia.
[da Soul Rider 03 – Gennaio 2012]