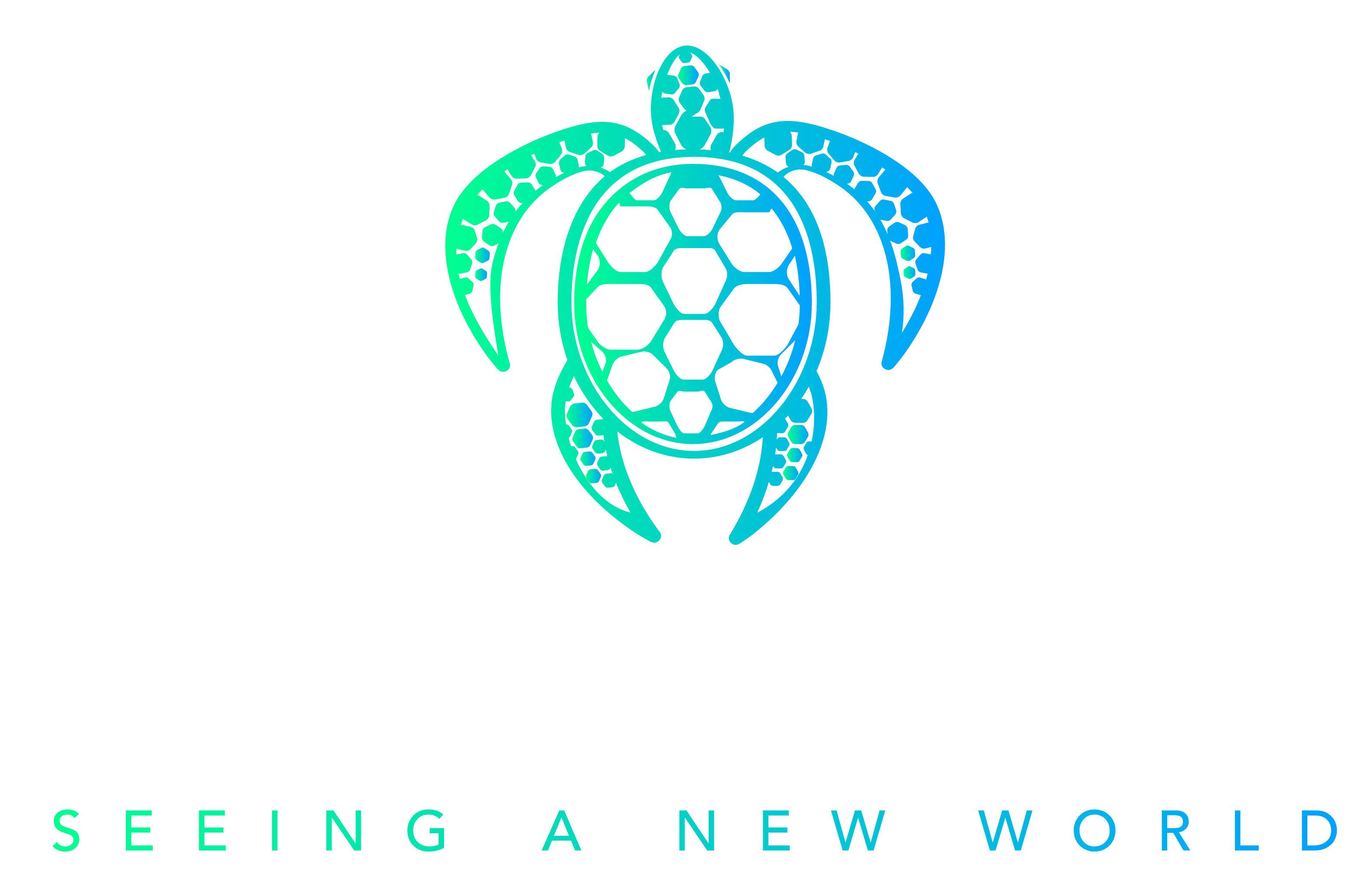A distanza di anni Franco Miotto ripercorre la cengia Sud-Ovest del Burèl incrociando le vie che lui stesso aveva aperto. Foto: Vittorino Mason
Omaggio a Franco Miotto. Contributo di Vittorino Mason
Ci eravamo dati appuntamento alle sei del mattino a casa sua. Per tutta la notte non ero riuscito a prendere sonno, forse un’inconscia tensione della giornata che mi aspettava mi aveva tradito. Nel buio presto di ottobre ero partito in macchina verso Belluno ma, arrivato a Limana, andai oltre giungendo quasi alle porte della città. Tornai indietro e finalmente imboccai sulla destra la via giusta di Praloran. In lontananza un’ombra camminava sulla strada verso di me, quando mi fu vicina riconobbi Franco. Ero emozionato a vederlo vestito d’alpinista. Scarponi, calzettoni alle ginocchia, pantaloni rossi alla zuava, una maglietta di lana con le maniche corte e, sulle spalle, uno zaino consunto da tante avventure vissute in montagna.
Franco l’avevo conosciuto due anni prima e, dopo averne tanto sentito parlare, una domenica con degli amici decisi di andarlo a conoscere. Fu amicizia a prima vista, anzi a stretta di mano. Ricordo che gli piacquero molto le mie mani. Disse “sono mani forti, robuste, mani da lavoro, mani da montagna, da roccia”. Non di meno erano le sue che avevano conosciuto mille mestieri e un’infinità di appigli.
Da allora ci incontrammo spesso e quando tornavo dai miei giri in montagna mi fermavo a trovarlo.
Nel corso degli anni più volte gli proposi di fare qualche salita, ma per un motivo o per l’altro, non si riusciva a combinare nulla. Solo promesse di andare a percorrere il suo famoso e bellissimo Viàz dei camòrz e camorzieri, ma senza mai partire. Cominciavo a dubitare delle sue capacità, mi dicevo “Forse non ha il coraggio e la forza di andare a ripetere certe sue imprese e, dopotutto ha sessantacinque anni”. Ma quella volta, dopo una settimana di attesa perché venisse il bel tempo, partimmo. Era arrivato il grande giorno, per me e anche per Franco.

Sui propri passi Franco incontra una vipera e la raccoglie solo per mostrarla ai compagni. Foto: Vittorino Mason
Salimmo alle Case Bortòt ai piedi della Schiàra, lasciammo l’auto al parcheggio e ci incamminammo per un trói verso il Pra de Luni. Franco camminava con passo spigliato, io lo seguivo assonnato e timoroso non sapendo se il polpaccio della gamba sinistra, reduce da una contrattura e una pausa di venti giorni, avrebbe retto alle fatiche. Nell’oscurità il bosco si presentava come un intricato labirinto di rami dove noi eravamo un disordine in quell’ordine scomposto. Nocciole ancora verdi bucate dai denti veloci dei ghiri erano disseminate sul terreno a far compagnia ai nostri passi. Giunti a una vecchia casa Franco capì di aver sbagliato sentiero, imprecando optò per un altro che ci portò su un terreno bagnato, ripido, coperto di lastre scivolose. Ci tirammo su con le mani annaspando sul muschio e l’humus, scivolando tra le foglie senza tregua. Ancora non andava bene, allora giù, indietro, su per un altro trói che ci portò in mezzo a cespugli di rovi, un’ape non so come entrò in un calzettone e mi punse, ma Franco non mi lasciò neppure il tempo per togliermi il pungiglione. Via, avanti, bestemmiando, col sangue che gli colava sulle braccia passò oltre, ma niente. In silenzio io lo seguivo con molta preoccupazione. Avrei voluto dirgli “Torniamo indietro, andiamo a prendere il sentiero battuto”, ma non avevo il coraggio di contraddirlo. Come un pugile sconfitto che ormai non ha più nulla da dire, continuava con una forza inaudita a camminare e scostare con le mani e i piedi ogni ostacolo di ramo che gli si presentava dinanzi.
Dopo quasi un’ora di lotta, con le prime luci dell’alba che sopraggiungevano a dare coraggio, “la bestia” si arrese. Tornammo indietro al punto di partenza e prendemmo un trói che in breve ci portò a una vecchia casa con un piccolo capitello. Era questa che Franco cercava nel bosco di faggi per riconoscere la via giusta e imboccare la Valle del Medón. Ero un po’ più tranquillo e apparentemente anche lui lo era. Camminando mi indicò dall’altra parte della valle il salto della Pissa, una bella cascata dove, nei pressi, si erano rifugiati un gruppo di tedeschi nell’ultima guerra mondiale. Tra le foglie d’autunno, che gialle e rosse cadevano, salimmo fino alla Casèra del Medón. Franco mi raccontò di quando la gente veniva a far legna, di come erano belle quelle casère che stavano andando in rovina.
Il bosco era silenzioso, incantato, alti, gli abeti punzecchiati dagli uccelli lasciavano cadere gli aghi. Sbucammo in un punto dove un grande pezzo di montagna del Tirón, staccatosi molti anni prima, era scivolata a valle tracciando, con le rocce e i grandi massi, un canalone, una bianca ferita che tagliava il bosco a metà. Piegammo a sinistra alzandoci in un erto pendio di pini che ci fece sputare sudore. Franco, di tanto in tanto, con la scusa di dirmi qualcosa, si fermava a prendere fiato. Ne approfittavo anch’io per guardare attorno, per approfondire lo sguardo su quei posti che mi erano cari e famigliari e che, già altre volte, avevo scrutato da altre angolature. Giunti a un torrente che scendeva tra salti di roccia dal Lastregàl, invece di seguire il trói segnato con gli ometti di pietra, disse che era meglio andare su diritti, in mezzo al corso dell’acqua, «Sulle rocce scivolose è più facile», soggiunse poi. Non potendo contraddirlo lo seguii in quel terreno non certo facile e in breve ci portammo molto in alto sui mille e duecento metri. Non si vedeva alcun camoscio e per invitarli all’incontro cominciò a fischiare con un richiamo che solo un vecchio cacciatore come lui sa fare.
Gracchiando passarono due corvi reali sopra di noi. Bevemmo un sorso di quell’acqua buona e fresca, poi proseguimmo. Pochi passi più in là, sotto un salto d’acqua, il corpo bianco di un animale morto ci fece sussultare, era un camoscio. Franco d’impulso sputò e imprecò, avevamo appena bevuto dell’acqua più sotto. “Prenderemo il colera!”, disse. Ma il camoscio in quella fredda veste bianca, che presentava la sua nuda pelle, era integro, non putrefatto, forse la temperatura costante dell’acqua gelata l’aveva preservato. Ci arrampicammo su delle roccette e in breve sbucammo sopra la Forcella del Medón. Un grande respiro di montagne e gioia ci attendeva tra i mughi.

Franco in arrampicata vegeto-minerale sulle lòppe del suo Viàz dei camòrz del Monte Coro (Gruppo della Schiara). Foto: Vittorino Mason

Risalendo in libera un canale che conduce alle Pale del Balcòn (Vià dei Camorz e camorzieri). Foto: Vittorino Mason

Franco durante un passaggio acrobatico nella cengia Nord-Ovest del Burèl. Foto: Vittorino Mason
Ero emozionato, davanti a me alcune tra le cime più belle della storia alpinistica di Franco. Con il dito mi indicò l’impressionante parete sud-ovest del Burèl, mille e cinquecento metri che precipitavano sulla Val de Piero. In quella parete di grigi, giallo, rosa, di tetti, fessure, diedri e camini, lui aveva aperto alcune delle più severe e impegnative vie dell’alpinismo dolomitico. Neanche Reinhold Messner osò tanto in quella montagna! Anche Franco era emozionato e continuava a osannare quei monti e quelle valli a lui tanto care, così lontane dal turismo di massa. Mi parlò di quando, cacciatore, si appostava in quei luoghi per sparare ai camosci e poi, a spalle, se li portava giù. Non era ancora ufficialmente un alpinista, ma aveva un’insana passione per la caccia che lo portava a frequentare le crode e le cime più ardite per cacciare camosci e poi scappare ai guardiacaccia. La “primula rossa”, così veniva chiamato a Belluno, riusciva sempre a farla franca. Centinaia di appostamenti e trappole per prenderlo in flagrante, ma mai una volta andati a bersaglio. Lui, per scappare, ne inventava una più del diavolo, si arrampicava dove passavano solo i camosci e andava dove solo gli impavidi e coraggiosi osano. Solo più tardi, per sfida, indossò i panni dell’alpinista. Lui che, senza saperlo, per due decenni aveva toccato senza corda gli alti gradi della scala dell’alpinismo. Nella sua casa una foto lo ricordava in un passaggio di quarto grado sul Burèl con un camoscio sulle spalle. A quarant’anni iniziò a ripetere ed aprire vie di grande difficoltà, alcune delle quali mancavano ancora di una ripetizione.

Una pausa sotto le Pale del Balcòn nel Viàz dei Camorz e camorzieri. Foto: Vittorino MAson

Una pausa sotto le Pale del Balcòn nel Viàz dei Camorz e camorzieri. Foto: Vittorino Mason

Non dimenticherò mai quel giorno che Franco, prima di affrontare la cengia nel Van del Castel del Monte Coro, si premurò di allacciarmi bene i ramponcini. Foto: Vittorino Mason
Ci sdraiammo sull’erba fresca, Franco tirò fuori due pere di casa sua e a morsi gustammo in silenzio il momento. Scattai delle foto e contemporaneamente sentii un rumore metallico di bastoncini, dai mughi sbucò un uomo. Franco lo riconobbe, si riconobbero, era Ruggero, un suo vecchio amico, anche lui consumato frequentatore di sentieri selvaggi. «Che onore essere qui sul Viàz dei camòrz e camorzieri con colui che l’ha trovato fuori» disse Ruggero. Era da tempo che non si vedevano e dopo alcuni scambi di opinioni su quello e quell’altro percorso fatto nel passato, anche Ruggero decise di venire con noi. Eravamo esattamente all’inizio del secondo tratto del viàz che va da Forcella del Medón alla Forcella Odèrz. Il cuore del viàz, il tratto preferito da Franco. Ora eravamo in tre, un numero perfetto, tale che ci iniettò una buona dose di fiducia. Senza perdere tempo Franco prese zaino in spalle e partì. Noi dietro il maestro seguivamo i suoi passi e i suoi occhi che, talvolta incerti, venivano traditi dalla memoria e dall’età.
Spesso c’era da mettere giù le mani per aggrapparsi a fessure e tacche, per scendere salti e salire gradoni di roccia. Stavamo attenti a dove mettere i piedi sulle cenge esposte per non scivolare sui baratri profondi. Franco era sempre davanti a indicarci la via, era l’ideatore, non poteva sfigurare di fronte a noi. Continuava a dire che non credeva di aver scoperto un simile viàz, che senza i segnavia giallo-rossi neppure lui sarebbe riuscito a districarsi nel groviglio di crode, cenge e canalini. Facemmo scorta d’acqua in un antro, Franco tirò fuori una vecchia borraccia rivestita in pelle di vacca che lui stesso aveva fatto. Maldestramente perse la guarnizione del tappo, così ci mettemmo a cercarla invano tra le pozze d’acqua e le rocce. Un po’ di imprecazioni e via, un’arrampicata su una paretina bagnata, poi su in alto, verso la luce. Un passaggio, forse di terzo, dove Franco senza fiatare lasciò appeso allo spigolo di una roccia, un ciuffo di capelli bianchi. Neppure una goccia di sangue! Quel ciuffo sembrava un fiore di montagna cresciuto senza timore all’estremità del grigio.
Presto fummo sulla cima dei Sabiói a 1997 metri. Il sole avaro irradiava i suoi caldi raggi su di noi che, sdraiati sulle rocce, ci riposammo un po’. Mangiammo qualcosa e parlammo di tante storie, delle sue storie, guardando in ogni dove quello spazio di luce che navigava senza confini in qua e in là, di orizzonti senza nome. Che pace, che sensazione stare posati come aquile in quei dirupi, calando gli occhi sulla pianura di Belluno. Movimenti alterni di nubi si dimenavano nella pozza del cielo e un gregge di nebbie cominciava a salire le pareti del Tirón. Il Serva era coperto e sul Coro iniziavano ad addensarsi le nubi.

Viàz dei Camorz e camorzieri) Franco si cala in corda doppia alla Piaz. Foto: Vittorino Mason
Riprendemmo il cammino calandoci tra i mughi e le roccette. Ora Franco procedeva in sicurezza, scaltro, passo fermo, gesti atletici che smentivano la sua età. Era bello vederlo muoversi come un ragazzo, come un camoscio. Il percorso cominciava a diventare più insidioso. Ad ogni passo un rotolare di massi, su molti appigli si staccavano rocce friabili, bisognava prestare attenzione. Salimmo ancora un canalino e poi un traverso molto esposto di cinque, sei metri, con delle belle maniglie per le mani. Poi giù, su, dietro un torrione, di qua di una croda, in un continuo, vibrante muoversi attanagliati da una tensione senza pause. E Franco parlava, era una incessante radio che trasmetteva a onde corte centinaia e centinaia di aneddoti, storie e fatti della sua vita e di molti altri personaggi che avevano vissuto e vivevano in quei monti. Io, zitto ad ascoltare, mi limitavo a chiedergli ragguagli sul viàz e a correggergli la direzione in qualche svista. Ogni tanto mi chiedeva “Come ti sembra questo viàz?” e io “Decisamente il più impegnativo dei tanti che ho percorso”. Stavamo attraversando le cime dei Pinèi in un labirinto di roccia che sembrava non aver mai fine. Solo il filo d’Arianna colorato di giallo e rosso ci poteva insegnare la via, sorridendoci, in quel intrigo di rebus e incognite in cui si muoveva quell’ardito e geniale Viàz dei camòrz. Eravamo continuamente appesi a un sibilo, a un respiro che poteva in ogni momento rompere quegli equilibri così tanto faticosamente raggiunti. La vita non era sulle nostre mani e piedi, ma su un imponderabile, incalcolabile gravità e morfologia degli eventi, che non ci era neanche lontanamente parente. In ogni istante tutto poteva crollare e precipitare in quel vuoto azzurro, dove neppure i bianchi alianti fanno rumore nel loro andare silenzioso.
Il più era fatto, non mancava molto alla Forcella Odèrz. Ancora qualche passaggio e qualche calata delicata dove minuscoli appigli cacciavano via le punte dei piedi. Un ultimo sguardo alla parete del Burèl ancora sgombro, alla gobba del Coro che iniziava a incappucciarsi di nebbie e poi giù alla forcella. Quasi d’improvviso capii che avevamo finalmente terminato il secondo tratto del viàz. Dopo tante ore di marcia si poteva finalmente liberarsi da ogni tensione. Alla base della parete una piccola targhetta portava scritto “Percorso alpinistico molto difficile”. Ci lasciavamo andare a reciproche congratulazioni, la gioia e la soddisfazione coloravano i nostri volti stanchi. Ruggero tirò fuori salame e vino e fu festa, lì, tra il profumo di mugo e libertà.

Viàz dei Camorz e camorzieri) Franco che guarda a ritroso l’esile cengia della Pala Alta appena percorsa. Foto: Vittorino Mason
Erano le tre del pomeriggio e il tempo incupito già ci consigliava di scendere. Fecero un altro giro di chiacchiere e poi partimmo, giù al Rifugio 7° Alpini che era chiuso, la stagione estiva era terminata. In alto, verso la Forcella del Pis Pilón si scorgevano le sagome di due persone, attorno a noi faggi di ottobre consolavano la madre terra con una metamorfosi di colori concentrata sulle tonalità del giallo e il rosso. “Quante volte sono passato di qui, quante volte ho schivato il rifugio per non farmi prendere”. Franco ci raccontò che più di una volta era passato sopra il tubo dell’acquedotto, vicino al rifugio. Con un camoscio e il fucile sulle spalle si faceva quei trepidanti trenta, quaranta metri, che distanziavano i due fianchi della stretta valle, sospeso a un centinaio di metri dal suolo. Quante storie da raccontare, quanti giorni ad ascoltare. Rimaneva da scendere tutta la lunga, infinita, bellissima Val dell’Art. Ancora due orette, poi, i nostri piedi puzzolenti con vesciche, calli e duroni avrebbero potuto respirare. A stento riuscivo a tenere aperti gli occhi, le mie gambe barcollavano senza ritegno in qua e in là, l’ora della “nona” era sopraggiunta. È quell’ora in cui, dopo una impegnativa giornata in montagna, le mie difese vengono meno e sono preda di una stanchezza e un sonno senza eguali che mi portano quasi a sprofondare in un’catarsi senza fine.
Franco e Ruggero sembravano ancora in forze, continuavano a raccontarsene di tutti i colori e ogni qualvolta Franco voleva sottolineare l’importanza di ciò che stava dicendo, si fermava. Tirò fuori la storia del pastore Ugo che passò quasi tutta la vita in montagna in mezzo alle fede. Giravano voci che di tanto in tanto, visto l’isolamento, mettesse i suoi stivali alle fede per farle apparire più umane, poi se le scopava.
Incontrammo una copia di giovani che salivano al bivacco del 7° Alpini e alcuni tritoni neri dalle chiazze arancioni che ci attraversarono la strada. Il cielo tra le fronde degli alberi mostrava i segni del cambiamento. Il tempo stava peggiorando promettendo acqua per l’indomani. Le parole di Franco, sovrapposte al suono del torrente che scendeva con noi, sembravano la voce di uno di quei canzonieri che giravano per i rioni in un tempo antico. Passammo davanti a delle lapidi e giunti a una curva Ruggero ci raccontò che una volta c’era un ponte sospeso e che più di qualcuno precipitò nel baratro. Tra questi ci fu anche Luigi, un soldato partigiano che cadde con il suo mulo. Nell’ultima guerra gli alleati americani appena faceva buio sorvolavano con gli aeroplani le montagne di Belluno lasciando cadere nella zona grandi pacchi e bidoni di viveri. La gente che li vedeva passare gridava felice “Le qua Pipo”. Luigi era uno dei tanti soldati che andavano a rastrellare la montagna per raccogliere il bene prezioso. Se lo caricava sul mulo e lo portava a valle, solo che, quella volta, uno sparo spaventò il mulo e a valle ci arrivarono entrambi volando. Tutte queste storie riempivano ogni angolo del mio cervello, così tante da averne quasi nausea, confusione.

Franco commosso nel posto da bivacco che lui stesso aveva costruito sul versante ovest del Burèl dedicandolo all’amico Piero Rossi. Foto: Vittorino Mason
Oramai eravamo già alle Case Bortòt, un altro piccolo strappo in salita e poi finalmente pace. Ruggero propose una divagazione nella sua baita per bere qualcosa, non potei rifiutare, erano due contro uno. Girammo per un trói fatto da Ruggero che tagliava il bosco in costa e in pochi minuti fummo sul posto. Ci stiracchiammo per terra senza alcun pudore, ognuno si tolse le sue puzze mostrando i segni della fatica e del dolore. Ruggero ci portò una birra, poi un’altra e per tenermi sveglio mi preparò una grande tazza di caffè. Poi giù ancora storie di uomini, di montagne, di caccia. Franco partì a raccontare delle sue battute di caccia. Proprio in quel periodo ogni anno si prendeva trentaquattro giorni di ferie e quasi tutte le mattine partiva di buon’ora per andare sui monti a inseguire camosci, caprioli, coturnici, galli forcelli e cedroni. Era un abile cacciatore, forse il migliore di Belluno, ma questa passione si era trasformata in una droga della quale non sapeva più farne a meno. Solo più tardi si ravvide.
Un giorno portò con sé Gianni, un amico che aveva una locanda dove passavano tanti cacciatori. Molti lo prendevano in giro, dicevano che non sapeva andare a caccia e in realtà Gianni non era proprio quel che si dice un esperto. Franco, che sapeva di questa diceria, per rivalsa, volle portarlo con sé in una battuta di caccia. Andarono sul monte Zervói in una zona di confini tra i comuni di Belluno, Longarone e Ponte Nelle Alpi. La caccia fu buona, uccisero quattro camosci, due li nascosero per bene in modo da poterli in seguito riprendere, gli altri due se li caricarono sulle spalle. Mentre scendevano dalle creste Gianni scivolò giù per i dirupi della montagna, un capitombolo di trecento metri che lo portò in fondo al vallone. Nel vedere l’amico rotolare come una palla, rimbalzando sul terreno e volando per aria, Franco non credeva ai suoi occhi, era come imbambolato. Gianni era giù immobile, aveva perso coscienza. Franco scese subito ma correndo si storse una caviglia. Quando arrivò dall’amico si assicurò delle sue condizioni, aveva una brutta botta alla testa, allora prese della neve fresca e, con una fasciatura, lo bendò per bene facendogli sopportare meglio il dolore. Poi si accertò che non avesse ossa rotte e con un gesto deciso si raddrizzò il piede storto. Se lo caricò in spalle e fece tutti i trecento metri di dislivello fino alla cima del Zervói. Recuperò i camosci, li nascose e andò giù fino alla Casèra Zervói con Gianni sulle spalle. Da lì chiamò i soccorsi che arrivarono poco dopo. I soccorritori vollero sapere dell’accaduto, allora Franco raccontò che stavano facendo un’escursione e a un certo punto Gianni mise male un appoggio del piede scivolando via. Conoscendolo, quelli del soccorso non la mandarono giù tanto in fretta. Quello che invece mandarono giù subito fu la forma di formaggio e il salame che il povero Gianni si era portato nello zaino.
Ruggero tirò fuori anche un fiasco di vinello fresco e dall’uscio della casa passarono dentro per sedersi al tavolo. Io assaggiai un grappolo d’uva nera oramai andata, preda di api e calabroni che combattevano senza tregua per ogni acino. Lasciai la pergola agli insetti e mi spostai sullo steccato ad ammirare la valle e respirare la sera che calava il suo crepuscolo di preghiera sulle prime luci della città. Impaziente di tornare a casa, sulla soglia ascoltavo ancora altri racconti. Avrei voluto perdermi con loro tra le onde del vino, tra il miscuglio di parole e bestemmie, tra quegli occhi stanchi, affascinanti e sinceri, avrei voluto inebriarmi di quel sapore che consuma l’uomo quando i muscoli cedono la forza alla poesia, avrei voluto dormire per non fermare il giorno e quella storia, ma Piera mi aspettava e con lei i “Camòrz”.
Franco lesse la mia impazienza, si alzò, ringraziammo Ruggero e con l’accordo di ritrovarci per andare a fare un altro viàz sui Monti del Sole, felici scendemmo alla macchina. Depositando lo zaino nel bagagliaio Franco tirò fuori il suo martello che tanti chiodi aveva conficcato nella roccia, che tante battaglie vinse. Me lo mostrò facendomi notare un particolare. Sul retro della testa erano incise la falce e il martello e sotto le sue iniziali. Accompagnai a casa Franco e, senza entrare, prima di andar via volle darmi le due mele che gli erano rimaste nello zaino. Con gli occhi lucidi mi abbracciò dicendo: «Grazie, oggi sono tornato giovane come un ragazzo di vent’anni. Dobbiamo tornare ancora lassù, vedrai, ti porterò a fare dei giri bellissimi». Sulla strada buia, tra gli abbaglianti e le luci dei paesi, col finestrino basso assaporavo il profumo di caldarroste e vendemmia nell’aria del sabato sera. Tra i fumi autunnali la terra arata già preparava un nuovo, lungo letargo.
Vittorino Mason, 3 ottobre 1999

Una delle ultime foto di Franco in compagnia di amici nella tana di legno chelui stesso si era costruito. Fonte: Vittorino Mason
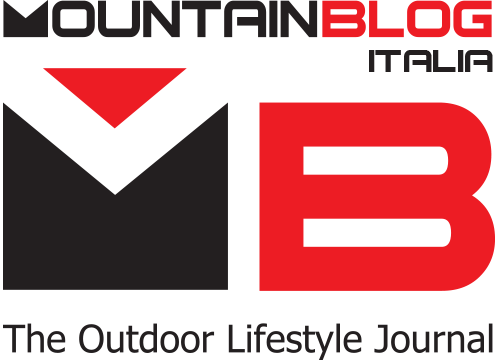




 Action
Action