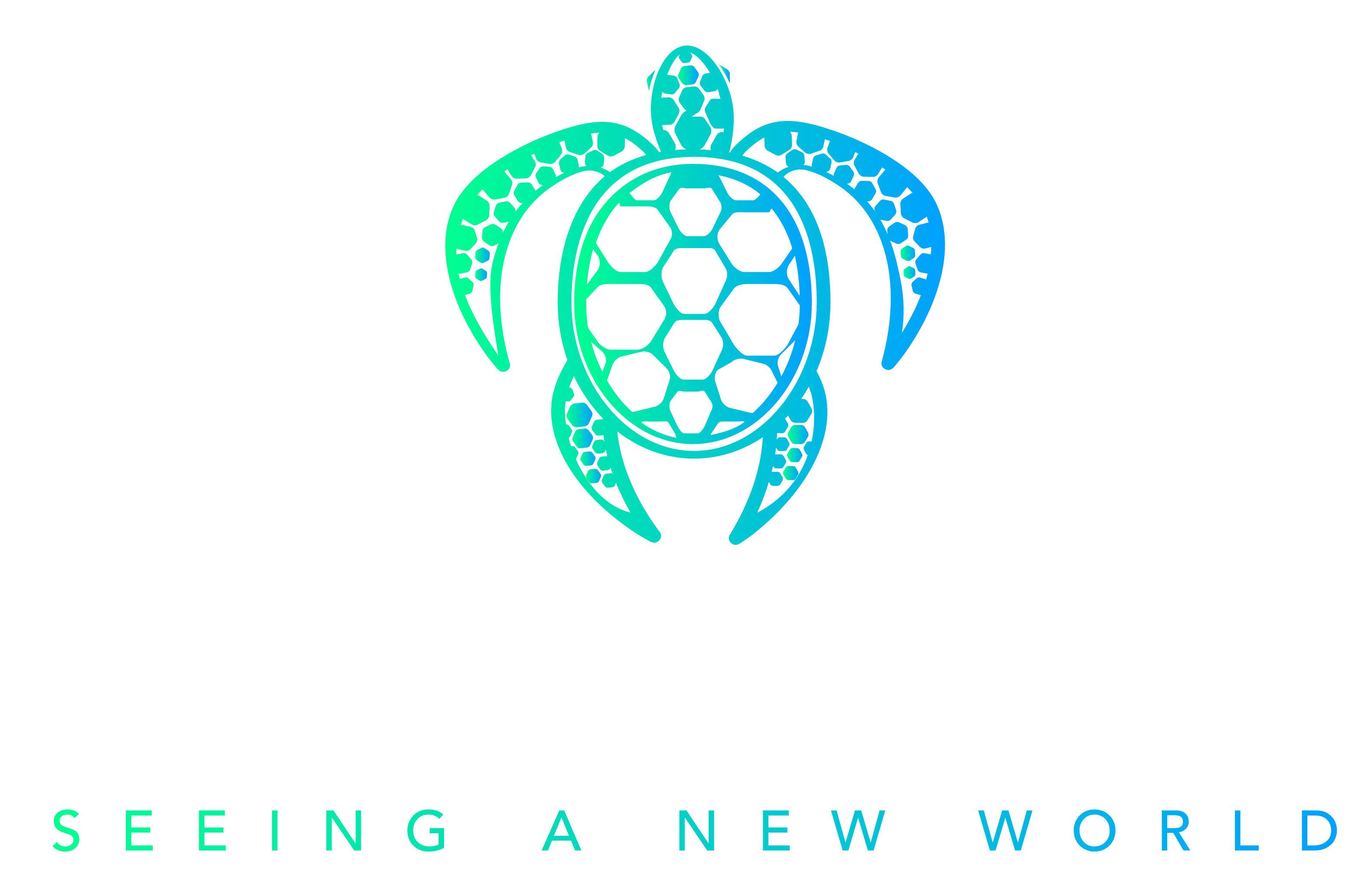L’alpinista non professionista è stato protagonista di numerose e difficili ripetizioni su roccia e ghiaccio in tutto l’arco alpino e di spedizioni extraeuropee. Sei gli ottomila da lui scalati: Manaslu, Cho Oyu, Lhotse, Dhaulagiri, Makalu, Broad Peak
Nei social, e non solo, ormai da tempo assistiamo a un continuo di notizie sul mondo dell’alta quota. Code di gente che paga cifre astronomiche per essere condotta in cima all’Everest con le bombole di ossigeno, portatori che vengono lasciati morire perché non si può perdere tempo a soccorrerli e il record da esibire allo sponsor e all’opinione pubblica è molto più importante, campi base presi d’assalto da centinaia di persone, alpinisti che a tutti i costi inseguono il completamento dei 14 ottomila, elicotteri che vanno e vengono, file di portatori sempre in viaggio per rifornire gli alpinisti da un villaggio a un campo base e a stendere corde da un campo alto alla cima.
Anche in quota, laddove la natura si difende bene da sé, si cercano di scardinare i principi e le leggi che regolano la vita uccidendo lo spirito e i valori che avevano fatto dell’alpinismo himalayano una pratica elitaria, per pochi, preparati, forti e soprattutto onesti alpinisti.
Nell’approccio e frequentazione dell’Himalaya molto è cambiato. Si è passati da quelle che erano le spedizioni quasi militaresche per la conquista di un ottomila in prima assoluta, che significava prestigio internazionale per il paese dei salitori, alla corsa del primo uomo Reinhold Messner su tutti gli ottomila, alle spedizioni commerciali dove non è necessario essere un provetto alpinista per salire in cima e in ultima, forse, alla corsa sfrenata per scalare tutti gli ottomila nel minor tempo possibile, con ogni mezzo, ad ogni costo.
È questo l’alpinismo? È questo l’Himalaya?
Con Giampaolo Casarotto, alpinista vicentino con alle spalle numerose e difficili ripetizioni su roccia e ghiaccio in tutto l’arco alpino, spedizioni extraeuropee che l’hanno visto salire il Nevado Alpamayo 5946m, l’Huascaran 6768m, il Nevado Pisco 5756m, l’Urus 5495m, il Nevado Ishinca 5553m, l’Aconcagua 6962m, il monte Kenya 5199m, il Denali o McKinley 6194m, il Pik Lenin 7134m, il Khan Tengri 7005m e con dieci viaggi in Himalaya e sei ottomila raggiunti – Manaslu 8163m, Cho Oyu 8201m, Lhotse 8516m, Dhaulagiri 8167m, Makalu 8481m, Broad Peak 8047m -, vogliamo indagare e cercare di capire i vari aspetti e le situazioni che si verificano e si vivono al campo base e lungo la via di salita di un ottomila.
Un’intervista che ci permette di conoscere l’esperienza di un himalaysta non professionista, le difficoltà economiche per organizzare un viaggio, il suo rapporto con l’alta montagna e con una compagna di viaggio, Cristina Castagna, che ha visto morire durante la discesa dalla cima del Broad Peak. La sua resistenza, la lucidità e freddezza nelle situazioni più difficili gli hanno permesso di cavarsela sempre e di essere ancora qui a raccontare.
L’intervista

Broad Peak – Campo 1. Una scritta di Cristina Castagna, come spesso era solita fare….Foto arch. Giampaolo Casarotto
Ti vengono riconosciute qualità come la saggezza, la calma e il silenzio; per questo ti hanno sopranominato Gandalf, il mago saggio del Signore degli Anelli…
Sì, e stata Cristina Castagna a darmi questo soprannome. Calma e silenzio sono due qualità che mi appartengono, ma da qui a sentirmi un saggio…
Normalmente prima di parlare ascolto e rifletto, non sono impulsivo. Sai, quando sei al campo base di un ottomila, magari con compagni di viaggio che non conosci bene, è facile che nascano contrasti, ma io ho sempre cercato il dialogo per non arrivare allo scontro.
Qual è stato il tuo percorso per arrivare in Himalaya?
Prima sono passato per le esperienze nelle Dolomiti e nelle Alpi Occidentali, poi, quasi per caso, è arrivato l’Himalaya. Nel 1980 Piero Radin mi propose di partecipare a una spedizione all’Everest. Pur senza esperienza dissi di sì. In quei tre mesi arrivai solo a 7300 metri, ma mi hanno permesso di entrare nel mondo dell’alta quota e sono stati fondamentali per il seguito.
Hai avuto dei maestri o degli alpinisti che per te sono stati di stimolo e riferimento?
Agli esordi ho fatto delle salite in Dolomiti con Piergiorgio Franzina e Piero Fina, due accademici del Cai di Vicenza. Quest’ultimo m’invitava spesso e per me, oltre che un onore, era uno stimolo. Poi ho conosciuto Renato Casarotto con il quale ho fatto alcune salite, ma soprattutto mi sono limitato a fargli da portatore di materiale per le sue salite alla Busazza (Civetta); seppure inimitabile, lui è stato un riferimento e da sprone per il mio andare.
Salire un ottomila costa. Un non professionista come riesce a far fronte ai costi di una spedizione himalayana?
Fino a una decina d’anni fa, riducendo tutto all’essenziale, niente sherpa, niente ossigeno, per una salita himalayana spendevo circa quattromila euro. Adesso i prezzi sono molto lievitati. Pensa che l’ottomila più facile costa attorno ai diecimila euro, l’Everest una cifra astronomica. In sole due occasioni ho avuto degli sponsor che mi hanno permesso di andare via a costo zero. Ad esempio, la spedizione scientifica al Cho Oyu con l’alpinista Marco Peruffo che poi è diventato il primo italiano diabetico a salire una montagna di ottomila metri. Per risponderti: o sei un benestante, o hai uno sponsor, o te ne stai a casa.
Inoltre, bisogna avere a disposizione almeno cinquanta, se non settanta giorni, il che vuol dire assentarsi dal lavoro con permessi, aspettative o ferie accumulate.
Cos’è che ti attrae dell’alta quota?
L’esperienza totalizzante del viaggio. Conoscere un altro paese, il Nepal, piuttosto che il Pakistan o il Sud America, mi ha sempre affascinato. La montagna era l’obbiettivo che mi proponevo, ma tutto il contesto, ciò che le stava attorno, l’essenza stessa del mio andare. Avere la possibilità di immergermi per uno spazio-tempo in un mondo e cultura altre, dove assorbire modi, usi e costumi di vivere diverse dal mio quotidiano, assaporare l’ospitalità delle genti dei villaggi valeva il costo del viaggio. Poi devo dire che giungere in vetta a una montagna di ottomila metri e vedere la terra curva è un’emozione che ti toglie il fiato.
Durante una spedizione di uno o due mesi si trascorrono molti giorni rimanendo inoperosi in tenda. Come passi il tuo tempo?
Soprattutto leggendo: l’ultimo viaggio con Cristina ho letto i dodici che mi ero portato più i quattro suoi. Quando sei al campo base perché nevica o comunque non ci sono le condizioni per salire, il tempo non passa mai e leggere è un ottimo passatempo. Pensa che di una salita a un ottomila il momento più difficile è quello di rimanere inoperoso al campo base; è qui che ti giochi la salita. Se ci sei con la testa, se rimani calmo, se non ti deprimi e mantieni un certo equilibrio e positività, allora puoi farcela.
Di solito, in una giornata al campo base, facevamo colazione alle otto e poi una camminata verso valle o verso il monte per conservare una buona condizione fisica. Poi a mezzogiorno si pranzava, si ritornava in tenda a riposare o a leggere, più tardi ci si ritrovava nella tenda-cucina con gli altri alpinisti per una partita a carte o delle chiacchiere, alle sei si cenava e poi ci s’infilava dentro al sacco a pelo a leggere e dormire fino alla mattina dopo. Sono davvero logoranti e difficili le giornate che si trascorrono al campo base.
Tu definisci i campi base degli ottomila come dei “villaggi dei bugiardi”, perché?
Sai, ai campi base, ognuno porta quello che è nel quotidiano: sogni, ambizioni, aspettative, ma anche meschinità. Quello è un luogo difficile da abitare. Si sta lì anche trenta giorni, lontano da casa, dai propri cari, ci si sente soli e allora è facile che nascano tresche amorose, che si esprimano giudizi poco lusinghieri nei confronti degli altri alpinisti ed emergano invidie e gelosie che mettono in mostra tutte le bassezze umane.
Questo avviene lì perché è stressante rimanere inoperosi, stare chiusi in tenda col brutto tempo che ti porta nostalgia e tristezza. Mentre quando sei impegnato nell’ascesa, per assurdo, tutto diventa più facile perché sei attivo e concentrato.
Molti anni fa sul Monte Bianco hai subito dei congelamenti; è stato l’unico episodio?
Sì, è stato l’unico episodio. Ero arrivato in vetta con degli amici e in discesa, centocinquanta metri più in basso, abbiamo deciso di aspettare qualcuno del gruppo che si era attardato. Poi ha cominciato a nevicare e abbiamo perso le tracce. Siamo stati costretti a bivaccare dalle cinque del pomeriggio alle sei della mattina dopo, dentro una truna, fermi a meno trenta sottozero. Mi sono congelato il piede sinistro ma all’ospedale di Chamonix sono riusciti a salvarmi le dita dall’amputazione.
È vero che durante una scalata di un ottomila si è sempre soli anche se in compagnia?
Sì. In Himalaya quasi mai si sale in cordata. Si installano delle corde fisse ma poi, a parte i punti più critici, si procede slegati: uno avanti, uno indietro, perché si è più veloci. Anche perché, se uno sale più veloce, attendere l’altro gli costa più fatica fisica, così ognuno procede con la sua andatura avendo come riferimento il compagno. Per chi sta dietro, guardare il compagno più in alto è sempre uno stimolo, oltre che un riferimento. Chiaramente non si può fare affidamento sul compagno in caso di pericolo e il rischio che si corre è sempre alto, ma se non si adottasse questo sistema i tempi di salita si dilaterebbero di molto mettendo ancora più a rischio la vita stessa degli alpinisti.

Lungo il trekking di avvicinamento al Makalu Cristina Castagna non perde occasione per medicare la gente dei villaggi. Foto arch. Giampaolo Casarotto
Hai condiviso diverse spedizioni agli ottomila con Cristina Castagna “El Grio”, com’era il vostro rapporto?
Abbiamo fatto cinque viaggi assieme e sono state delle esperienze bellissime. Ho conosciuto Cristina nella spedizione all’Everest del 2003 e da subito siamo entrati in sintonia. Lei mi raccontava della sua vita, dei suoi sogni, salire tutti gli ottomila, del suo lavoro di infermiera, delle sue amicizie e io, più vecchio di lei, l’ascoltavo e cercavo di consigliarla.
Per noi salire un ottomila era andare in viaggio, ed era così bello che la definivamo gita perché era diventata una normalità partire ogni anno e salire una montagna che ci faceva stare bene assieme. Avevamo una tale empatia che spesso non servivano le parole per dire qualcosa.
Di lei cosa ti colpiva particolarmente?
La determinazione. Era una donna tenace, forte, capace di sopportare fatica e dolore, di affrontare le difficoltà senza mai perdersi d’animo. Aveva davvero le capacità per realizzare il suo sogno.
Nel 2009, dopo la salita al Broad Peak, durante la discesa Cristina è volata via…
Nonostante fosse stata una salita difficile dal punto di vista fisico, aveva nevicato e nella neve fresca abbiamo dovuto battere traccia, fino alla vetta era andato tutto bene.
Avevamo fatto tardi, era ormai sera, quando stavamo scendendo con una corda fissa lungo un breve camino roccioso, a circa 7900 metri. C’era poca luce, io ero davanti, lei subito dietro. La corda fissa finiva in un ripido lenzuolo di neve. Ad un certo punto mi accorsi di essere sceso qualche metro di troppo rispetto le tracce di salita, così sono tornato sui miei passi e ho ripreso la traccia giusta. Cristina fece il mio stesso sbaglio ma invece di risalire decise di attraversare questo lenzuolo di neve per raggiungermi.
Poi la vidi scivolare via. Forse uno zoccolo di neve sui ramponi, una lastra di ghiaccio… «Pianta la piccozza» le urlai. Lei ha cercato di girarsi, fare qualcosa, ma c’era subito il salto ed è volata nel vuoto. Sono sceso per cercarla, ho visto le tracce di sangue, ho incontrato una guida che era nei pressi del suo corpo e mi disse che non c’era più niente da fare.
Nel tuo alpinismo hai sempre messo in conto un incidente mortale?
Chi fa dell’alpinismo sa che ci sono rischi ad ogni passo e che la posta in gioco è alta. Io sono consapevole che in qualsiasi momento può succedere l’irrimediabile, ma ho scelto io questa attività. Il rischio è implicito, ma non vado in montagna pensando di morire, ma per divertirmi. In cinquant’anni di attività ho avuto solo due incidenti: quello del congelamento e la rottura di un crociato del ginocchio la primavera scorsa sciando. Nessuno parte per la montagna pensando di andare a morire; come nessuno esce di casa pensando di dover morire attraversando le strisce pedonali, eppure succede.
Come giustifichi questo rischio, non strettamente vitale, in rapporto a una moglie e a dei figli?
Diciamo pure che, come quasi tutti gli alpinisti, sono un egoista. Ma la stessa cosa si potrebbe dire di un ciclista che ogni giorno esce quattro, cinque ore in bicicletta con tutti i rischi che corre sulla strada. Ho la fortuna di avere una moglie che ama la montagna e comprende questa mia esigenza. Lei non mi ha mai frenato, ma immagino che possa essere stata più volte in apprensione quando ero su un ottomila. Per contro, quando sono a casa, cerco di essere sempre presente: marito e padre. Qualche anno fa, per la prima volta, abbiamo vissuto assieme la salita di una montagna di settemila metri e lei si è resa conto cosa sono andato a cercare in tutti questi anni: la bellezza e le culture che mi hanno riempito il cuore.
Hai vissuto molte esperienze himalayane a stretto contatto con una donna affascinante. Tua moglie come viveva questa vostra relazione alpinistica?
Mia moglie ha sempre avuto fiducia in me e in Cristina che conosceva e frequentava. Non mi ha mai fatto pesare le spedizioni con un’altra donna. Solo alcuni suoi colleghi di lavoro facevano battutine stupide e fuori luogo. Poi io nei confronti di Cristina sono sempre stato corretto e lei anche, c’era un rispetto reciproco. Se un uomo vuole tradire sua moglie credo non debba necessariamente andare fino a un campo base a cinquemila metri.
Sei stato un educatore scolastico: questa professione ti è servita per le tue scalate?
Direi che è stato l’andare in montagna che mi ha aiutato a fare l’educatore e a vivere il quotidiano. I viaggi in luoghi estremi, visitare e conoscere altre culture, materialmente più povere di noi, mi hanno fatto capire quanto poco basta per vivere e soprattutto a dare un valore ad ogni cosa e a non sprecare. Quello che ho imparato, ho cercato di trasmetterlo anche ai ragazzi con i quali operavo. Non sprecare l’acqua lasciando aperto un rubinetto, non reclamare continuamente giocattoli quando ci sono altri bambini o ragazzini che i giocattoli se li costruiscono oppure giocano con niente e si divertono lo stesso.
Qual è la dote più importante per riuscire a scalare un ottomila?
La testa. La testa intesa come capacità di autocontrollo, equilibrio mentale, pazienza. Saper attendere il momento giusto, quelle famose finestre di bel tempo per poi spiccare il volo verso l’alto. Ma pochi sono disposti a trascorrere trenta giorni in tenda per poi averne solo tre o quattro a disposizione per tentare la cima.
E l’elemento o il fattore che può pregiudicare o favorire la riuscita di una salita?
Il tempo, le condizioni meteorologiche! Puoi allenarti, essere forte quanto vuoi, ma se soffia il vento, nevica o grandina, tu non vai da nessuna parte.
Non riuscire a raggiungere la vetta di un ottomila è un fallimento?
No. Una delusione perché non sei riuscito a raggiungere l’obbiettivo, ma non un fallimento. Io sono sempre partito sapendo che c’era il cinquanta per cento di possibilità di andare in cima. Ho fatto dieci viaggi agli ottomila con sei vette raggiunte, per cui mi ritengo fortunato. In ogni caso mi sono sempre portato a casa una grande esperienza per quello che ho vissuto in mezzo ai ghiacci e alle persone.
Il momento più bello che hai vissuto in Himalaya?
Le persone sono portate a pensare che il momento più bello di una scalata sia l’arrivo in vetta. Sì, anche, a volte ti viene da piangere quando arrivi lì, ti senti appagato sei contento, ma paradossalmente i momenti più belli dei miei viaggi in alta quota li ho vissuti in basso, nei villaggi. Ho un ricordo indelebile di quella volta in Karakorum; stavamo scendendo dal campo base e alla vista di uno spiazzo d’erba abbiamo steso un telo per terra e siamo rimasti lì tutta la notte a guardare le stelle. Dopo giorni e giorni di bianco, assaporare il colore e il profumo dell’erba è stato meraviglioso.
Un altro momento indimenticabile, quando sono stato con il fortissimo scalatore francese, François Damilano, a vedere un villaggio vicino a Kathmandu che lui aiuta tramite una sua associazione. Lì, dove molti bambini e ragazzi erano rimasti orfani del padre portatore morto in montagna, François sembrava il padrino di tutti. Ecco, questo mi commuove e mi fa dire che è molto importante che l’alpinista volga il suo sguardo verso l’alto, ma dovrebbe guardare anche in basso, saper aiutare e condividere le sofferenze e i bisogni degli altri.
E una situazione in cui hai visto la morte in faccia?
Per fortuna mia ho vissuto solo diverse situazioni potenzialmente molto pericolose in cui ho avuto la sensazione di potermi anche far male, ma non rischiare la vita.
Com’è il ritorno a casa dopo mesi trascorsi in mezzo al ghiaccio e la neve?
Devo dire che la cosa più bella è tornare a dormire in un letto. Poter distendere e allargare le gambe perché, dopo venti, trenta giorni di sacco a pelo ti senti il corpo compresso. Poi un’altra cosa che apprezzo molto è quella di andare in bagno di notte senza dovermi vestire come invece devi fare quando sei in tenda, una delle operazioni più difficili in alta quota.
Ti ho visto scalare con una reflex appesa al collo. Cosa ti affascina dello scatto?
Fin dall’uscita nel mercato della mitica Rollei 35, ho avuto una macchina fotografica. Andare in montagna o in viaggio con una macchina fotografica significa essere intenzionati a catturare un momento o qualcosa di importante. Da uno scatto o più, vengono fuori delle storie che poi cerco di trasmettere, magari durante le mie serate.
Se non ci fosse la montagna con la neve e il ghiaccio saresti comunque un viaggiatore-esploratore?
Sì. Ho viaggiato diverse volte anche nel deserto e ultimamente per mare provando l’esperienza della barca a vela; ho, inoltre, viaggiato in bicicletta andando a Santiago di Compostela.
Sono curioso di natura per cui scoprire nuovi paesaggi e conoscere il pianeta che mi ospita per me è sempre motivo di esperienza e avventura. Ma non vado in giro perché l’ambiente dove vivo è brutto, semplicemente perché il mondo è bello.
Il tuo futuro è sempre in alto oppure l’avanzare degli anni piano piano ti costringerà a rimanere più in basso, da un’altra parte?
Sono, come si dice, nel terzo tempo della mia vita e cerco di viverlo nel modo migliore possibile. I sogni sono sempre tanti e qualcuno riesco ancora a realizzarlo. Il fascino dell’alta quota è sempre presente nei miei pensieri e se non sarà un ottomila, comunque continuerò a salire sui monti fino a che il fisico me lo permetterà. I momenti vissuti in montagna hanno qualche cosa di affascinante: il corpo e la mente si riappacificano con il mondo e quindi donano energia per continuare a guardare ciò che mi circonda con serenità e ottimismo.
Vittorino Mason
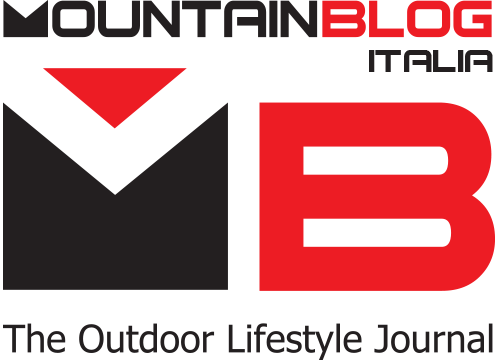



















 Action
Action