 Rieccoli gli “esperti”, i commentatori, inesorabili e puntuali ogni qual volta accade una disgrazia in montagna. Impietosi, appartengono a una categoria piuttosto variegata e trasversale che va dall’omino della strada, all’alpinista che se va bene ha preso una volta nelle vita due piccozze in mano, al giornalista, al professionista, al blogger. “Non dovevano essere lì…”, “le temperature erano troppo alte”, “E’ stata una scelta azzardata”, “Non bisogna rischiare in quel modo“… Gianni Comino, guida alpina e fuoriclasse indiscusso sul ghiaccio, morì sfidando in solitaria la seraccata della Poire, l’amico e guida alpina Ezio Cavallo, pioniere dell’ice-climbing, precipitò a Bard per il rialzo delle temperature su una cascata di bassa quota, Gian Carlo Grassi, maestro di tutti noi, fu tradito dalle temperature alte, gli amici Mauro, Diego, Angelo, furono spazzati via da una slavina alla Grand Hoche, pericolo piuttosto individuabile dal basso per via delle cornici da accumulo. Eppure erano molto esperti. Chi accetta di misurarsi con il ghiaccio verticale e con l’alpinismo in generale, accetta appieno e in modo incondizionato tutte le regole del gioco, compresa la possibilità di morire. E’ una scelta individuale, libera, dove il confine tra il rischio eccessivo e quello ponderabile è spesso poco definito. I commenti, di qualsiasi tipo, sono chiacchiere inutili. Finché in quest’attività saremo liberi di scegliere se oltrepassare quel confine oppure no, i morti meritano una sola cosa, silenzio e rispetto.
Rieccoli gli “esperti”, i commentatori, inesorabili e puntuali ogni qual volta accade una disgrazia in montagna. Impietosi, appartengono a una categoria piuttosto variegata e trasversale che va dall’omino della strada, all’alpinista che se va bene ha preso una volta nelle vita due piccozze in mano, al giornalista, al professionista, al blogger. “Non dovevano essere lì…”, “le temperature erano troppo alte”, “E’ stata una scelta azzardata”, “Non bisogna rischiare in quel modo“… Gianni Comino, guida alpina e fuoriclasse indiscusso sul ghiaccio, morì sfidando in solitaria la seraccata della Poire, l’amico e guida alpina Ezio Cavallo, pioniere dell’ice-climbing, precipitò a Bard per il rialzo delle temperature su una cascata di bassa quota, Gian Carlo Grassi, maestro di tutti noi, fu tradito dalle temperature alte, gli amici Mauro, Diego, Angelo, furono spazzati via da una slavina alla Grand Hoche, pericolo piuttosto individuabile dal basso per via delle cornici da accumulo. Eppure erano molto esperti. Chi accetta di misurarsi con il ghiaccio verticale e con l’alpinismo in generale, accetta appieno e in modo incondizionato tutte le regole del gioco, compresa la possibilità di morire. E’ una scelta individuale, libera, dove il confine tra il rischio eccessivo e quello ponderabile è spesso poco definito. I commenti, di qualsiasi tipo, sono chiacchiere inutili. Finché in quest’attività saremo liberi di scegliere se oltrepassare quel confine oppure no, i morti meritano una sola cosa, silenzio e rispetto.
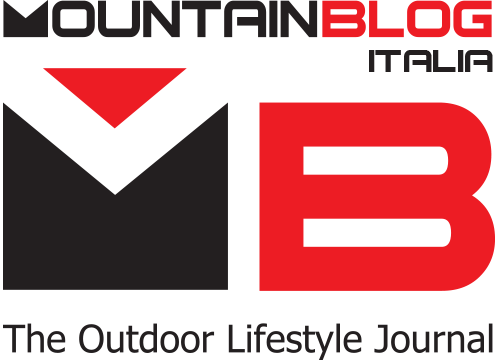




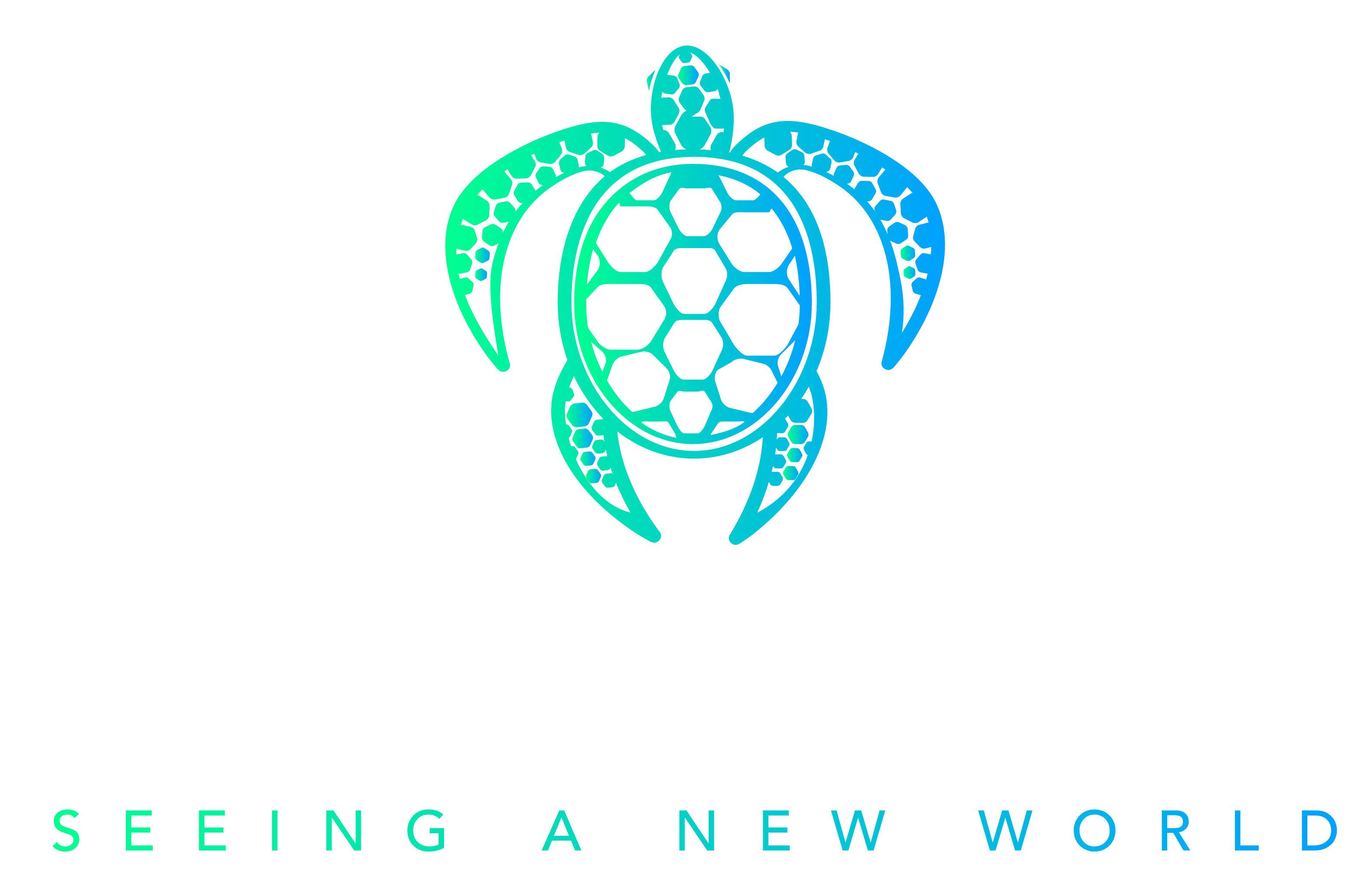





















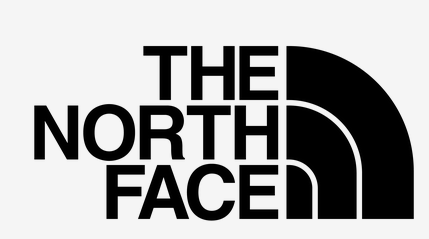




















dopo un doveroso,rispettoso silenzio e la vicinanza ideale a chi resta privato degli affetti che mancheranno per sempre credo si possa e si debba ,invece ,discutere.
discutere circa il limite a cui spingere il rischio di una scelta ,di una sfida. e per fare questo non serve essere esperti alpinisti poiche’ la cosa riguarda tutti gli ambiti della nostra vita.la scelta.
ciascuno e’ responsabile della propria vita e spesso anche della propria morte.
la scelta di certe imprese mi fa pensare che abbia poco a che vedere con la passione.a volta sembra ci si faccia prendere da uno smisurato e delirante senso di onnipotenza e allora io tirerei in ballo la parola RISPETTO :per la vita propria e altrui.
discutere se tutti gli esperti di alpinismo non debbano avviare una riflessione , darsi un codice etico, cambiare un innaturale senso dell’amore per la montagna in un piu’ vasto senso di amore e rispetto per la vita e anche per la natura in modo da non doverla concepire come una continua sfida che spesso finisce con una tragica fatale e definitiva sconfitta.
non molto tempo fa persi un caro amico travolto da una slavina a Fai della Paganella. al suo funerale vidi tanto dolore ma anche tanta rabbia per la sua scelta di un percorso che innesco’ una serie di tragiche fatalita’.
allora anche io,omino della strada ,con qualche bella escursione alle spalle, ma con un discreto senso della realta’ e concsio dei miei limiti voglio poter parlare ,senza che nessuno possa zittirmi, voglio essere libero di manifestare la mia “rabbia” e il dolore per queste morti assurde,per queste vite spezzate per tutto il dolore e il vuoto incolmabile che resta ai loro cari.
I questi casi è facile innescare una sorta di pericoloso e inutile confronto tra la sacrosanta cultura della sicurezza e la libertà di rischiare. Spesso l’alpinismo viene considerato esclusivamente come uno “sport” e ciò comporta che la “massa”, alla fine, ritenga il rischio insito in quest’attività eccessivo rispetto a quello, per esempio, della Formula Uno, del motociclismo, del pugilato. Non è un caso che abbia preso piede sempre di più una cultura della sicurezza che passa anche da una giurisprudenza colpevolista e volta alla ricerca della “responsabilità” e talora del “dolo”. Il che innesca anche azioni impositive come i divieti. Tuttavia, è anche una buona parte del mondo alpinistico – figlio di questa società che mira sempre di più al controllo dell’individuo e che ha dispensato caduchi modelli di benessere – a riconoscersi in questa cultura. Si guarda con favore la messa in “sicurezza” di vie di arrampicata e di itinerari di ascensione, con l’idea di garantire a più gente possibile “la riuscita” o la “vetta”. I passaggi rischiosi di certe vie “classiche” in alta montagna sono “azzerati” da protezioni solide e fisse. Su alcune montagne si attrezzano vie di rientro con calate e corde fisse per evitare tragitti lunghi, pesanti e magari più rischiosi, si ideano e si propagandano sistemi di geo-localizzazione per conoscere sempre la nostra posizione in caso di soccorso. Quasi un “grande fratello della montagna”. Soluzioni che abbassano il rischio oggettivo, eliminano l’incertezza della riuscita ma non favoriscono affatto una vera cultura della sicurezza che passa dall’adattamento della capacità dell’individuo alla montagna e non il contrario. Si ritiene così che sia sempre giusto ridurre i rischi con artifici e all’occorrenza “vietare”. E’ questa società a chiederlo, sono i titoli dei giornali che parlano di “montagna assassina”, con la corresponsabilità anche di tanti alpinisti-opinionisti che dimenticano che l’alpinismo non è solo uno sport ma è un fatto etico (superamento di sé stessi) ed ideale (gratuità del gesto, anche rischioso). In oltre duecento anni di storia l’uomo ha risposto al suo innato senso di salire verso l’alto, che fosse una “vetta” o il termine di una parete. Ha superato inconsciamente “la scusa scientifica”, “l’idealismo nazionalista” e anche “l’idea sportiva”, accettando che anche la morte è parte del gioco. Non è la “bella morte” ricercata ma è una possibilità reale. Oggi possiamo discutere dicendo che alcuni incidenti sono frutto di imperizia altri di “over – confidence” ma dietro c’è sempre l’irresistibile richiamo di quello spirito odisseico che è innato nell’uomo, sopito molto spesso ma innato. Nel caso dell’imperizia manifesta parliamo di imprudenza e lo stesso facciamo quando è l’eccesso di confidenza a tradire. Quasi mai ci chiediamo cosa ci sia realmente dietro a questo desiderio di mettere a repentaglio la propria incolumità. Si sprecano allora i commenti: “erano troppo impreparati”, oppure: “erano esperti (ma incoscienti)”. Da Preuss a Comici a Gervasutti a Comino, le morti sono state dovute in qualche modo all’eccesso di confidenza, e quando è andata bene (per esempio Bonatti nel famoso lancio delle “bolas” di corda al Dru in solitaria”) si è parlato di grande impresa. Questo è l’alpinismo e il rischio, così come gli “errori” e anche la morte, ne sono parte integrante. Rispetto per la vita certo ma rispetto per le scelte individuali e per lo spazio di libertà che ancora quest’attività rappresenta.
Dal tuo punto di vista puoi anche aver ragione. Ma io ho visto un’amica morire in un tranquillissimo trekking solo perchè inciampando banalmente è caduta e ha battuto la testa su un sasso. Secca.E qui cosa diresti? non doveva fare trekking? doveva stare a casa a fare la calza? Non ha avuto rispetto per la sua vita e quella degli altri?
La società attuale ricerca l’emozione più che la conoscenza. Abbiamo creato uno squilibrio e tutti argomentano, però qualcuno muore più spesso da giovane.
L’emozione però è un fatto irrinunciabile in alpinismo, il che non esclude affatto la conoscenza. Non vedo squilibri rispetto a 50 o 100 anni fa. Dopo la tragedia del Cervino la Regina Vittoria si chiese se fosse giusto vietare l’accesso alla montagna ai suoi sudditi e dopo la tragedia del Freney, qualcuno scrisse che per Bonatti e compagni “ci volevano i lavori forzati”. Quello che è davvero cambiato oggi è il modo di fare comunicazione.