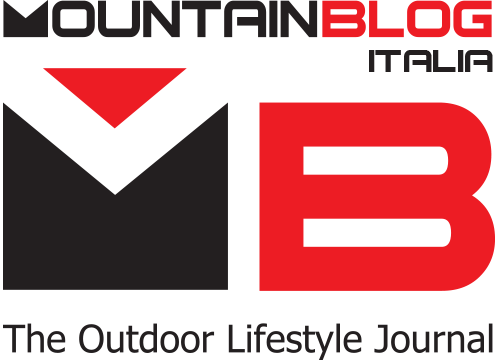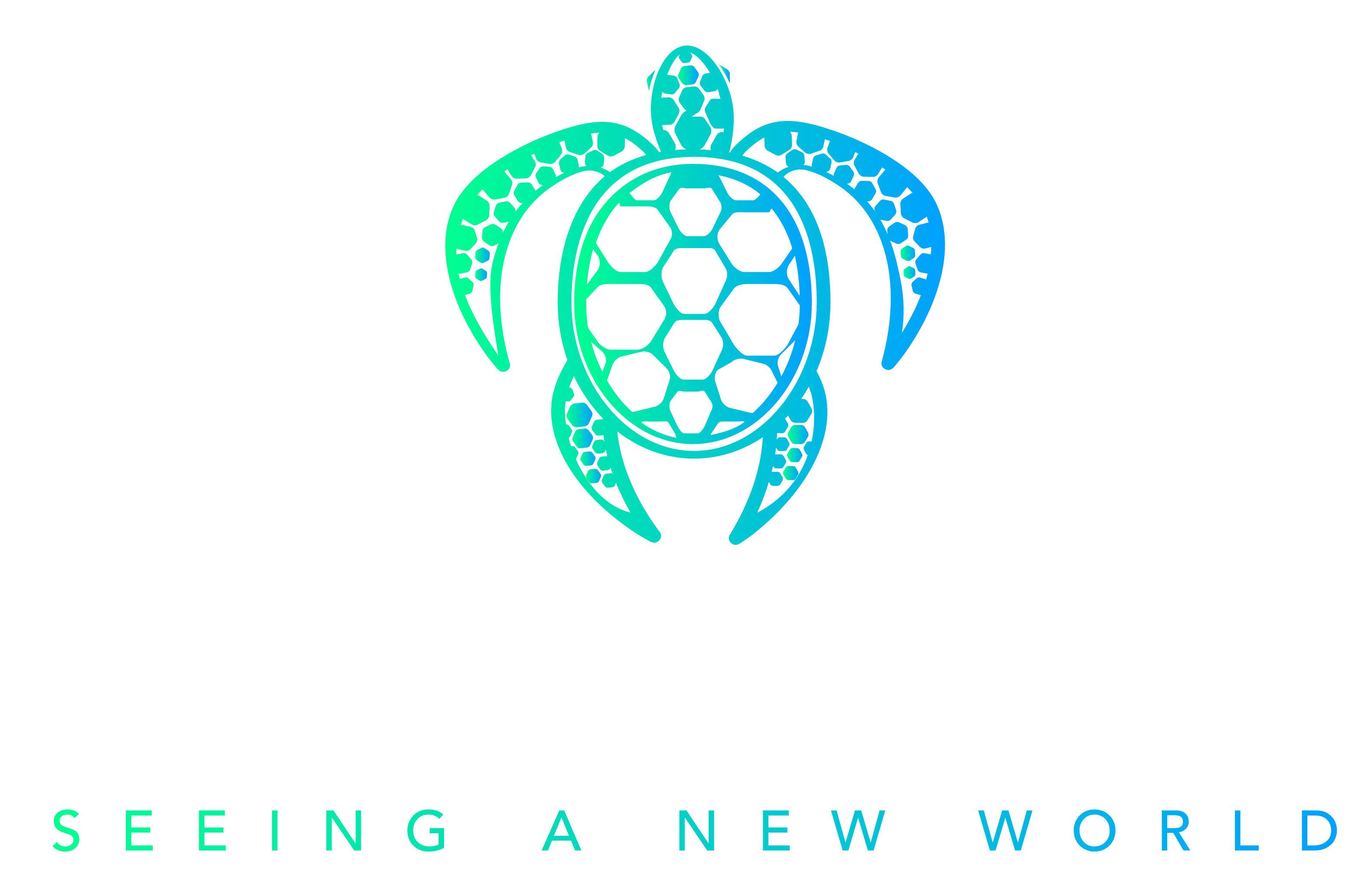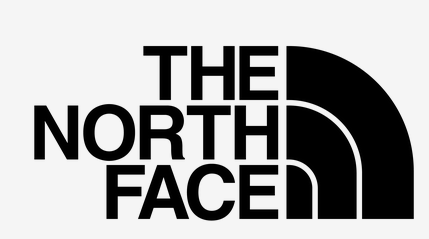Chi pratica la montagna e le sue discipline da un po’ di decenni, è certamente passato attraverso una rapida e costante evoluzione tecnica e culturale. Ancor più dell’aspetto tecnico, è importante la trasformazione di “costume” che ha contraddistinto l’alpinismo e le discipline affini. Questo cambiamento, infatti, è strettamente correlato con l’evoluzione/potenza dei mezzi d’informazione e la diffusione dei modelli attrattivi.
La crescita imponente di escursionisti, scialpinisti, alpinisti, arrampicatori, è direttamente proporzionale a questa condizione. Siccome la storia ci dimostra che l’alpinismo (uso questo termine comprensivo) è un fenomeno sociale, possiamo affermare che questo nuovo “andare in montagna” sia figlio dei social network. Sono “troppe”, oggi, le persone che vanno in montagna? Bisogna porre un freno come vorrebbe qualcuno? Io penso che non solo sia assurdo e anche impossibile, ma che è fin troppo chiaro che una soluzione “esterna” e collettiva non esiste. Non si rende più sicuro l’andare in montagna vietando, chiudendo, sanzionando, cercando d’inquadrare in regolette quello che non potrà mai essere inquadrato, cioè l’ambiente “selvaggio” o non antropizzato. Io dico: per fortuna.
In una società che è senza limiti e che, specialmente grazie ai social network, diffonde una cultura no limit dell’alpinismo e delle discipline affini, sarebbe oltretutto un po’ come darsi un colpo di scure sulla mano e poi cercare di metterci un cerotto. Le istituzioni della montagna puntano quasi esclusivamente sui vademecum e forniscono ai cosiddetti inesperti, vaghe regole, promuovono soluzioni tecnologiche come salvifiche, oppure obblighi come quello dell’ARTVA. Se calcoliamo che queste indicazioni sono fornite a un’utenza che, mediamente, fa attività solo nei fine settimana e che vive, dalla città, uno scollamento con l’ambiente selvaggio naturale, e se pensiamo che gli stessi esperti sono spesso i primi a ignorare i “limiti” e a “osare”, offrendo un messaggio contraddittorio, si comprende allora fin troppo bene che tutto ciò da solo non può funzionare. Se una soluzione non esiste, si può pensare, però, di andare in controtendenza, recuperando un senso del limite. Il che però, come tutte le osservanze dei limiti, comporta delle rinunce, il non assecondare logiche di mercificazione della montagna e, soprattutto, l’imparare a essere onesti con se stessi.
Questa proposta che è soprattutto di carattere etico, potrebbe essere piuttosto ardua anche a livello individuale. Questo perché si ha la tendenza a sopravvalutarsi e a non mostrarsi deboli o deficitari di fronte all’opinione altrui, davanti agli stessi amici che vanno in montagna e, ancora peggio, di fronte a un mondo di consensi virtuali. Si finisce, così, col mentire soprattutto a se stessi e a convincersi di essere in grado di fare cose che in realtà non sappiamo fare, oppure, ancora peggio: “Che a noi un guaio non accadrà mai”. Tutto ciò va nella direzione opposta al costruire la propria consapevolezza, il proprio senso del limite e, di conseguenza, la propria autoprotezione.
Le domande che ciascuno dovrebbe porsi e che sono sicuro, pochissimi si pongono, sono molto semplici. Per esempio, se affronto una via lunga di arrampicata, sarei in grado di soccorrere il mio primo di cordata ferito, rimasto appeso a un fix o peggio ancora a un friend, in una situazione di assoluto isolamento? Sarei in grado di cavarmela da solo in parete, in alta montagna senza appoggiarmi all’aiuto di un compagno magari più esperto? Sono davvero in grado di affermare che una qualsiasi cascata di ghiaccio cui mi trovassi di fronte, presenta le condizioni per essere salita? Conosco la materia ghiaccio e la sua evoluzione nello spazio e nel tempo? So riconoscere le zone d’instabilità di una struttura? Qual è il mio reale grado di affinità con questa disciplina? Conosco davvero un ghiacciaio? Saprei riconoscere la presenza di crepacci coperti o la solidità di un ponte di neve? Saprei uscire da un crepaccio con mezzi autonomi? Sarò anche un bravissimo “sciatore”, ma cosa so davvero della materia “neve”? Sono davvero in grado di riconoscere, in una zona ignota e senza nessuna “relazione” acquisita da amici o da una virtual community, la stabilità del manto nevoso? Quanto conosco la morfologia del luogo in assenza di neve e la “storia” locale delle nevicate? Sono davvero in grado, in condizioni di stress, di soccorrere, da solo, un compagno seppellito sotto una valanga? Ancora: sarei in grado di affrontare un bivacco di emergenza in un luogo ostile?
Sarebbe davvero interessante conoscere le risposte, possibilmente oneste, di molti frequentatori della montagna, compresi alcuni di quelli che, spesso, contribuiscono a scrivere i vademecum comportamentali. Quest’onestà, che probabilmente ridimensionerebbe tutte le nostre velleità, ma anche il nostro ego, la dobbiamo soprattutto a noi stessi se vogliamo davvero vivere la montagna come crescita progressiva e come laboratorio di esperienze autentiche. Il tutto aspirando a una maggiore sicurezza (ci tengo all’aggettivo “maggiore”), non demandata sempre a terzi oppure affidata a chiusure, sanzioni, divieti, facilitazioni illusorie, che hanno soltanto l’effetto diseducativo di deresponsabilizzare sempre di più l’individuo, rendendolo incapace di decidere.